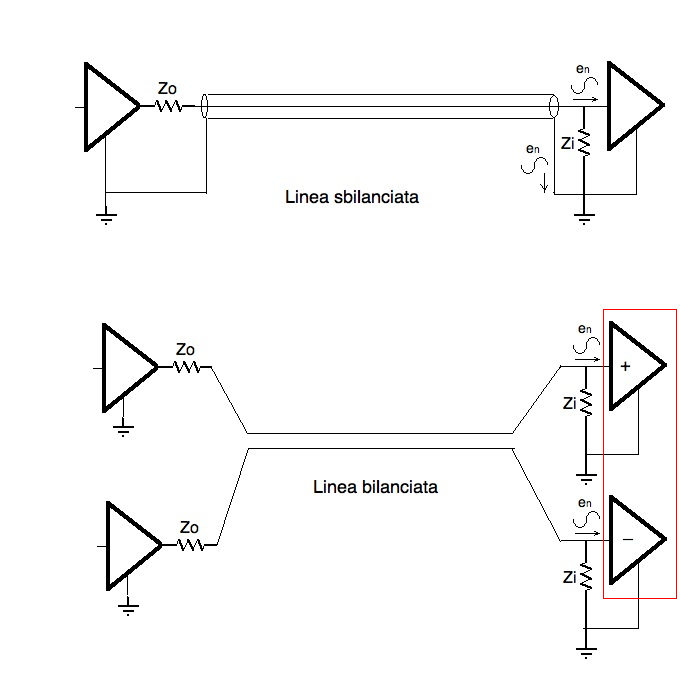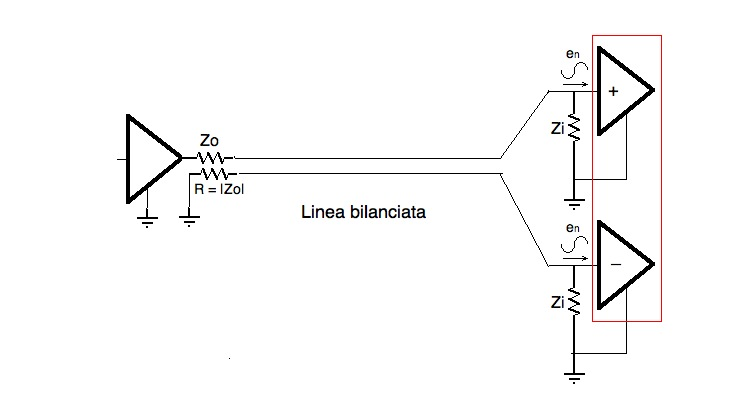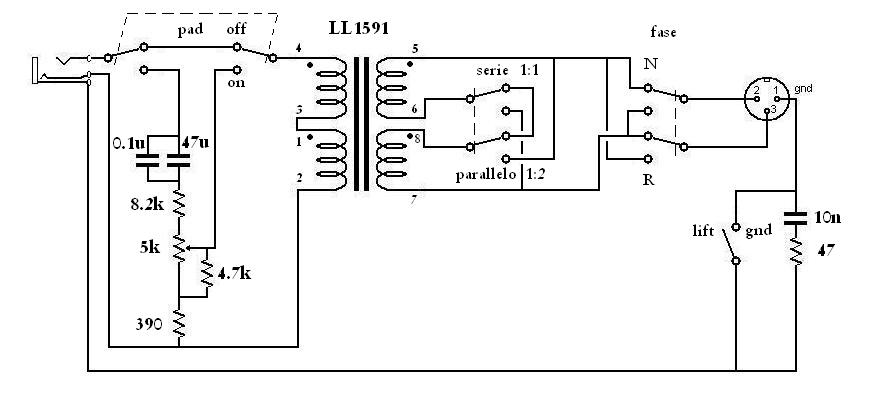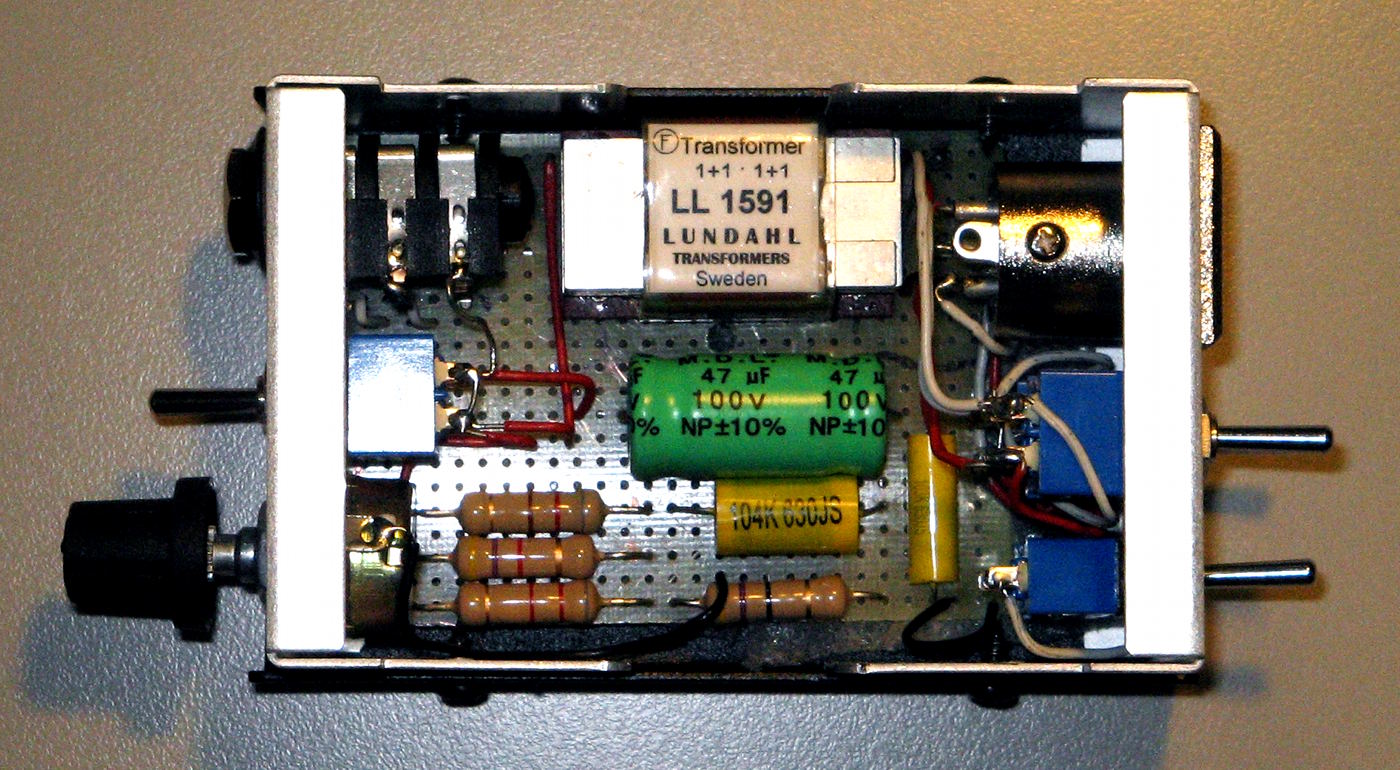|
DI Box e Trasformatori
Quando
devi collegare l'amplificatore o un altro dispositivo alla console che
dista 15 metri perché sei su un palco di concerto, dove ci sono
altri quattro o cinque amplificatori da alcune centinaia di W, un po'
di spie amplificate, luci ed altre apparecchiature che formano un
groviglio di cavi elettrici, è indispensabile una linea
bilanciata.
Non
sempre gli amplificatori per strumenti hanno una uscita DI bilanciata,
le tastiere praticamente mai, i computer men che meno, ed oggi vedere
un computer, o anche due o tre, su un palco di concerto è oramai
normale.
La linea bilanciata è l'unico modo per poter avere un cavo lungo
qualche decina di metri con la (quasi) certezza di non captare disturbi
di vario genere.
In questi casi avere sotto mano una o più DI Box significa aver risolto
il problema.
La DI Box è semplicemente una “scatola nera” che ha
un ingresso sbilanciato con connettore jack ed una uscita bilanciata
con connettore XLR: un brevissimo cavo standard per strumenti, un
cavetto unipolare da 50 o 75 cm con due jack da 1/4” (6,35 mm) ai
due capi, per “entrare”, un normale cavo bilanciato per
microfono per “uscire”.
Come è fatta una DI Box, dipende dall'utilizzo che se ne deve
fare, cioè da cosa si deve connettere alla console, in quanto
è fondamentale adattare sia i livelli di segnale che le
impedenze.
Lo standard per le console, sostanzialmente rispettato nella totalità
dei casi, è:
ingresso microfono:
circa 2,5 kohm, max 10 dBu,
bilanciato
ingresso linea:
circa 10 kohm,
max 22 dBu, bilanciato
quindi la DI Box è di tipo diverso a seconda che si debba
connettere una sorgente a bassa impedenza di uscita oppure una sorgente
ad alta impedenza di uscita.
Se si deve connettere un amplificatore non provvisto di uscita DI si
può prendere l'uscita verso l'altoparlante, attenuarla
opportunamente, trasformare il segnale attenuato in segnale bilanciato,
ed è tutto.
Se si deve connettere l'uscita linea sbilanciata di una tastiera o di
un amplificatore, non serve l'attenuazione e basta bilanciare il
segnale.
Se si vuole connettere una chitarra elettrica o un basso, con pick up
passivi, cioè non amplificati, la DI Box deve essere di tipo
attivo, in quanto i pick up passivi richiedono necessariamente una
impedenza di carico dell'ordine del Megaohm.
La DI Box attiva ha al suo interno un amplificatore con elevata
impedenza di ingresso e bassa impedenza di uscita.
Ma la questione più importante in una DI Box è il modo in cui si
ottiene il segnale bilanciato.
Un segnale sbilanciato può essere trasformato in bilanciato in due
modi: con un trasformatore o elettronicamente.
Le due soluzioni sono concettualmente e praticamente molto diverse: il
bilanciamento elettronico si ottiene semplicemente con due
amplificatori operazionali e una manciata di resistenze e condensatori,
il circuito è semplice ed economico, mentre il trasformatore
è un componente teoricamente semplice ma tecnologicamente non
facile da realizzare, quindi di costo elevato.
Due operazionali significa sostanzialmente un NE5532, nello schema che
ho proposto nel Li'l Amp;
in quello schema il “bilanciatore” è preceduto da un
TL082, circuito integrato con ingresso a J-Fet e quindi impedenza di
ingresso elevatissima: di fatto questo è lo schema di una DI Box
attiva cui connettere direttamente la chitarra o il basso.
Costo totale 5 €.
Un trasformatore per uso audio di caratteristiche buone costa molto di
più, e se le caratteristiche non sono buone fa più danno
che vantaggio.
Il trasformatore usato in questa DI Box costa circa 50 €, è
il modello definito “low cost” di una serie di
trasformatori di caratteristiche tecniche analoghe, ma prestazioni
crescenti con il prezzo, fino ad arrivare a circa 150 € per il
modello top (parlo ovviamente di prezzi per un esemplare singolo,
inclusa IVA).
Nel post sul Li'l Amp promettevo
una
analisi di trasformatori audio di classe diversa, questa realizzazione
usa un trasformatore di alta classe ma mi è servita per
chiarirmi le idee su trasformatori più abbordabili.
Fra 5 e 50 € la differenza non è poca cosa, quindi bisogna capire
perché e quando sia giustificata.
Le linee bilanciate
Ripropongo qui un breve riepilogo del funzionamento delle linee
bilanciate, già proposto nel post “Amplificatore
di Linea Push Pull”, con qualche precisazione in più.
Una trattazione completa si può trovare nel documento tecnico AN-002
reperibile sul sito di Jensen Transformers.
Che cosa significa “linea bilanciata”?
Lo
scopo della linea bilanciata è quello di consentire l'uso di
cavi lunghi in ambienti disturbati (cioè in cui vi siano campi
elettromagnetici dispersi, tipico il caso dei palchi dei concerti rock
e pop, non di classica ovviamente) senza captare rumore dai suddetti
campi.
Ai capi di un conduttore immerso in un campo elettromagnetico variabile
si forma una tensione indotta dalla variazione del campo
elettromagnetico (legge di Faraday).
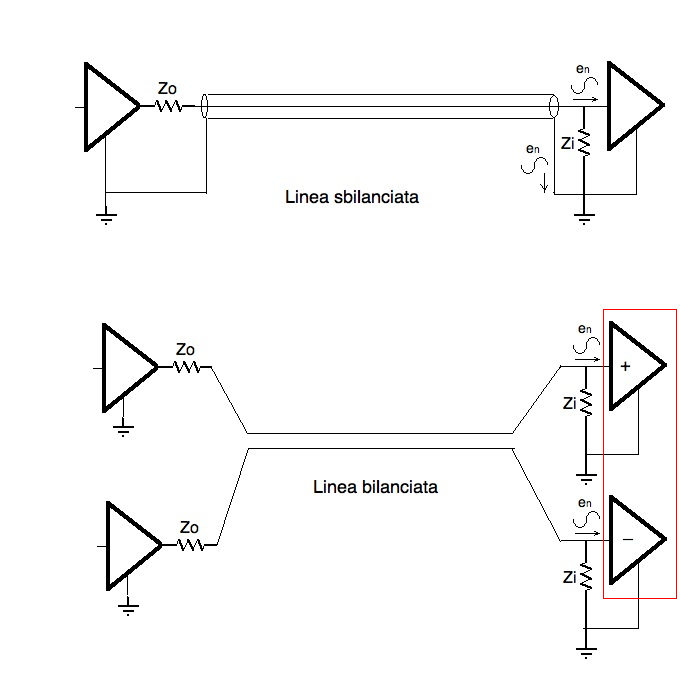
Fig. 1 Linea sbilanciata
(in alto) e bilanciata (in basso)
Una
linea sbilanciata è costituita da un conduttore che è un
normale cavo schermato con la calza connessa a massa; in questo caso il
conduttore centrale (il “caldo”), che è in certa
misura schermato dalla calza, è comunque soggetto ai flussi
magnetici, quindi ai suoi capi si forma comunque una Forza
Elettromotrice, en come ai
capi dello schermo (Fig.01, in alto).
Ma all'ingresso del dispositivo ricevente, tipicamente la console o un
amplificatore, lo schermo è connesso a massa, quindi vede verso
massa una impedenza pari a zero, mentre il conduttore caldo vede verso
massa l'impedenza di ingresso della console o dell'amplificatore Zi.
Analogamente nel circuito sorgente vediamo che il conduttore di uscita
vede verso massa una impedenza pari all'impedenza di uscita
dell'amplificatore Zo (che per
una uscita di linea è tipicamente dell'ordine di 100 ohm o
più) mentre la calza del cavo schermato è connessa a
massa e quindi la calza vede verso massa una impedenza nulla (o quasi
nulla).
Quindi il conduttore “caldo” vede verso massa una impedenza
pari al parallelo della impedenza di uscita del
“trasmettitore” e della impedenza di ingresso del
“ricevitore”, mentre la calza vede verso massa una
impedenza praticamente nulla; quindi il conduttore caldo ha una
impedenza verso massa significativa, ed ai capi di questa impedenza il
segnale di disturbo entra nel sistema.
Una linea bilanciata è costituita da due connettori di segnale
affiancati circondati da uno schermo: i due connettori di segnale
entrano nei due ingressi ( + e - ) dell'amplificatore, che amplificano
i due segnali con fase opposta (Fig.01 in basso).
I flussi magnetici dispersi hanno sui due conduttori lo stesso effetto,
in quanto i due conduttori corrono nella linea a stretto contatto fra
loro, quindi la FEM indotta è identica.
In questo caso abbiamo due conduttori isolati da massa, che vedono
verso massa dalla parte del “trasmettitore“ l'impedenza di
uscita del dispositivo, dalla parte del “ricevitore”
l'impedenza di ingresso dell'amplificatore.
Anche in questo caso ciascuno dei due conduttori vede verso massa il
parallelo dell'impedenza di uscita del “trasmettitore” e
dell'impedenza di ingresso del “ricevitore”.
In quali condizioni il segnale di disturbo, che è presente con
la stessa intensità e la stessa fase sui due capi dell'ingresso,
viene annullato
dall'amplificazione in opposizione di fase dell'amplificatore di
ingresso?
Solo
quando i due conduttori vedono una impedenza rigorosamente uguale verso
massa, perché solo in questo caso il flusso magnetico uguale sui
due cavi si trasforma in segnali con la stessa ampiezza in Volt (tutti
gli amplificatori a livello di segnale sono amplificatori di tensione).
Quindi una linea è bilanciata non quando il segnale utile si
presenta sotto forma di due segnali in opposizione di fase: questo
è del tutto irrilevante, dato che lo scopo del bilanciamento
è abbattere il rumore e non trattare il segnale utile, per il
quale in assenza di rumore una linea con un solo conduttore caldo
è più che adeguato.
La linea è bilanciata quando il segnale di disturbo, che
è comune ai due conduttori, vede impedenze perfettamente uguali
verso massa.
Uno sbilanciamento delle impedenze verso massa pari all'1% crea una
reiezione del rumore non superiore a 40 dB, uno sbilanciamento pari
allo 0,1% crea una reiezione del rumore non superiore a 60 dB.
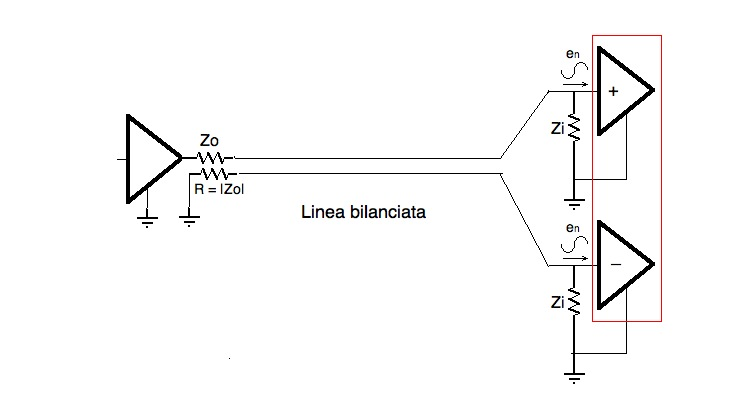
La
linea di Fig. 2 è una linea bilanciata, anche se il segnale
proviene da una sorgente sbilanciata: il bilanciamento viene ottenuto
mediante la resistenza R, posta uguale al modulo di Zo; questa è
in effetti una tecnica usata abbastanza comunemente per bilanciare una
linea.
Quando le impedenze verso massa sono determinate da componenti
elettronici quali resistenze e semiconduttori uno sbilanciamento
complessivo dell'1% è già un buon risultato.
Quando i dispositivi trasmittenti e riceventi sono trasformatori
realizzati in modo acconcio, il bilanciamento verso massa è
assicurato automaticamente, in quanto non c'è collegamento
elettrico fra i conduttori del segnale e la massa.
In questo caso quindi la reiezione del rumore può arrivare a
superare i 90 dB, in quanto l'impedenza intrinseca verso massa è
la resistenza di isolamento del trasformatore, che è
intrinsecamente uguale sui due capi (a meno di difetti di costruzione).
Il trasformatore deve però comportarsi in modo impeccabile dal
punto di vista audio, e qui può cascare l'asino, in quanto i
trasformatori si basano sulle variazioni di flusso magnetico in
materiali magnetici, che non sono lineari quindi possono introdurre
distorsione; inoltre i trasformatori hanno anche limitazioni di banda
passante, se non realizzati con opportuni accorgimenti.
È perfettamente inutile avere un rapporto segnale/rumore di 90
dB se ciò si ottiene introducendo una distorsione armonica
dell'1% con una banda passante 100 Hz – 10 kHz.
La DI Box
Per i motivi spiegati sopra la scelta per questa DI Box passiva
è caduta sul trasformatore, e la prima scelta del trasformatore
è caduta su un nome al top nel campo dei trasformatori
audio: Lundahl.
In altre realizzazioni ho usato trasformatori Sowter, che stanno a mio
parere sullo stesso livello qualitativo, cioè professionale
elevatissimo; ho semplicemente voluto provare una alternativa. Un'altra
alternativa è un nome altrettanto noto a livello professionale:
Jensen Transformer.
Il modello scelto è il trasformatore “general
purpose” a basso costo LL1591: è a basso costo in quanto
non è dotato di schermatura in mu-metal come il fratello LL1527;
essendo impiegato in un circuito totalmente passivo inserito in un box
metallico ho ritenuto che le sue prestazioni fossero adeguate; è
ovviamente una opinione discutibile, per massima sicurezza si potrebbe
scegliere il LL1527XL, dotato di schermatura e con una accettazione
(massimo segnale in ingresso per la distorsione di targa) nettamente
più alta, ma costo quasi triplo.
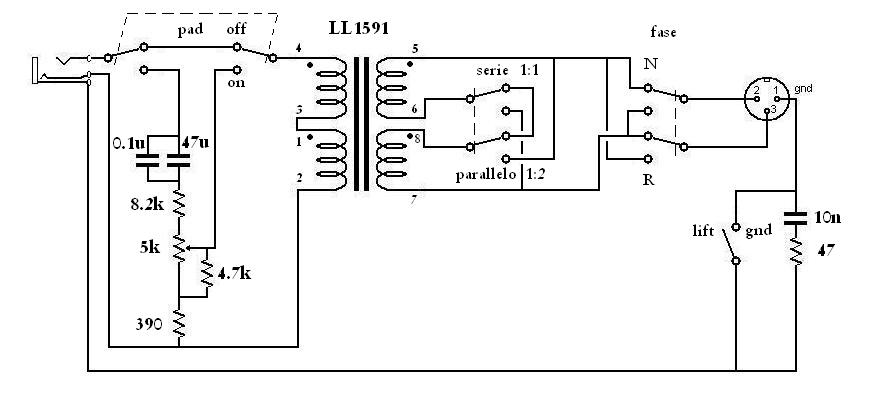
Fig.
03 : Schema elettrico della DI Box
Lo schema elettrico è in Fig. 3: il
connettore di ingresso
è un jack TRS, quindi può accettare in ingresso sia linee
bilanciate che linee sbilanciate: quando si inserisce un jack TS (jack
mono) lo schermo dello spinotto connette a massa il conduttore
“freddo” dell'ingresso bilanciato.
È poi presente un attenuatore variabile, inseribile con uno
switch: serve per connettere la DI Box direttamente ai capi di un
altoparlante, regolando l'ampiezza del segnale che viene inviato alla
console.
Questa è una pratica comune quando l'amplificatore della
chitarra o del basso non ha l'uscita DI, ma è spesso usata anche
quando l'uscita DI c'è.
Questo perché l'uscita DI, quando c'è, è
generalmente connessa a qualche punto del preamplificatore, quindi il
segnale inviato alla console non risente della distorsione dello stadio
finale, che se è a valvole dà un contributo importante al
suono: i possessori di amplificatori Marshall Lead (modelli vari)
piuttosto che Mesa, Trace, ecc sanno cosa intendo.
All'uscita troviamo un commutatore che connette in serie o in parallelo
i due avvolgimenti del secondario: serve a ridurre di un fattore 2 il
livelo di uscita e soprattutto di un fattore 4 l'impedenza di uscita,
importante se la linea è veramente lunga.
Per concludere il commutatore per l'inversione di fase ed il connettore
di uscita, un XLR standard.
Come al solito è presente lo switch per l'eliminazione del
ground loop, praticamente indispensabile: la situazione su un palco e
le condizioni dell'impianto elettrico, spesso precario, rendono
impossibile prevedere se il ronzio da ground loop sia inferiore con il
circuito aperto o chiuso.
In ogni caso un condensatore da 10 nF ed una resistenza da 47 ohm
mettono a terra i disturbi ad alta frequenza (ad esempio le
interferenze dei trasmettitori radio dei microfoni e degli strumenti a
corde).
Il circuito, essendo un prototipo, è realizzato su scheda
millefori passo 2,54 (1/10”): lo schema è così
semplice che non valeva la pena realizzare uno stampato.
La realizzazione nelle Figure 4, 5, 6.

Fig. 4: Pannello
posteriore

Fig. 5: Pannello
anteriore
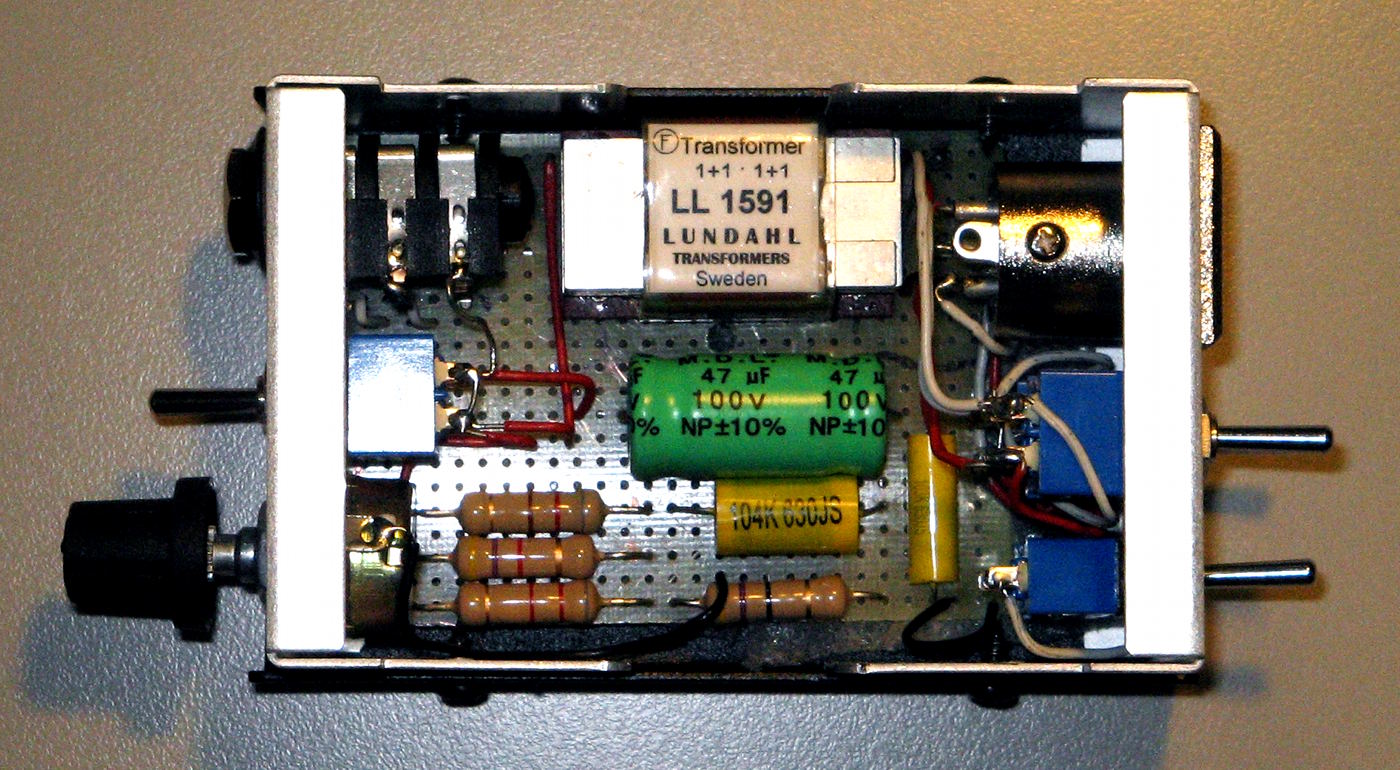
Fig. 6:
il circuito su basetta millefori
Quali
Trasformatori?
Ho approfittato di questa realizzazione per provare trasformatori di
classe diversa, come avevo preannunciato nel post sul Li'l Amp.
Tutti quelli che hanno visto gli altri Progetti di questo sito, nella
sezione "Audio di Alta Qualità", sanno che io considero il
Trasformatore,
purché di qualità adeguata al progetto, il componente
più adatto ad un sacco di funzioni.
Ho quindi dedicato un
po' di tempo ad un breve test, che non ha alcuna pretesa di essere
esaustivo, su alcuni trasformatori audio, di classi diverse, che trovate qui.
|