 |
|
Fermat: Amplificatore
di linea Push Pull
|
|
(cliccare sulle immagini per ingrandire)
Premessa
Questo
progetto è
la realizzazione con componenti moderni di
una
topologia sviluppata all'inizio del 1900 (fa un certo effetto dire:
all'inizio del secolo scorso) dagli ingegneri della Western Electric.
Siamo
nel 2007 e la valvola compie 100 anni: il primo prototipo venne
realizzato da Lee De Forest nel 1907 e ingegnerizzato e prodotto
industrialmente da WE, in pochi anni gli ingegneri ed i progettisti
della WE analizzarono e misero a punto le topologie base che avrebbero
determinato il futuro del tubo a vuoto.
Non erano topologie banali; le tecnologie di allora erano rudimentali,
mentre le esigenze da soddisfare erano pesanti: erano gli
anni
della diffusione delle linee telefoniche a lunga distanza e subito dopo
della diffusione della radio e ciò che non poteva fare la
tecnologia doveva essere realizzato necessariamente con un circuito
“intelligente” e performante.
Suggerisco a chi non l'avesse letto di rivedere quell'articolo e
soprattutto di fare qualche ricerca in rete sul nome “Western
Electric”, è un pezzo della nostra storia.

Filosofia di progetto
Qualcuno si chiederà che senso ha, al di là della
esercitazione accademica, riproporre una topologia nata 80 anni fa e
per giunta complessa e costosa.
Perché un amplificatore di tensione push pull a
trasformatori in
un'epoca di imperanti monotriodi con catodo a massa, resistenza di
placca ed accoppiamento RC nella più pura filosofia di
progetto
“less is better”?
Dipende dagli obiettivi che uno si pone: sono anch'io d'accordo che
semplice è meglio, ma anche che, come diceva Einstein,
“fallo più semplice che puoi, ma non di
più”;
ecco, ho l'impressione che oggi spesso la semplicità sia
fatta
passare per efficacia, a tutti i costi.
Il monotriodo è semplice, quindi “deve”
suonare
meglio, poi se uno ci prova e non si accontenta perché
richiede
prestazioni particolari scopre che è concettualmente
semplice ma
praticamente non tanto e ci sono molte considerazioni da fare per farlo
suonare veramente bene.
Quindi,
perché un push pull a trasformatori?
Questo è un amplificatore di linea non dedicato
esclusivamente
all'HiFi, deve avere ingressi diversi e deve alimentare uscite diverse,
con carichi piuttosto pesanti, dai 10k della scheda audio che uso per
registrare su computer, ad una linea standard bilanciata a 600 ohm.
La funzione di un amplificatore di linea è quella di
selezionare
vari ingressi e trasmettere il segnale amplificato o attenuato (il
controllo di livello è fondamentale) a qualche cos'altro: il
segnale, a parte l'amplificazione o l'attenuazione, non deve subire
altre trasformazioni in quanto verrà ulteriormente
amplificato,
miscelato e quant'altro.
Deve in altre parole avere la distorsione più bassa
possibile,
in assoluto: a mio parere per un amplificatore
“intermedio”
il concetto del decadimento armonico non si applica assolutamente,
perché qualsiasi distorsione prodotta verrà
ulteriormente
amplificata e quindi necessariamente distorta dagli stadi seguenti, in
modo non prevedibile in quanto lo stadio seguente non è
predefinito.
In un amplificatore per uso generale (cioè non vincolato ad
uno
specifico ed unico stadio successivo) la teoria dell'eliminazione
armonica non si può proprio applicare.
Se poi lo stadio successivo è un ADC ciò
è ancora più vero.
L'interfaccia a trasformatore è ulteriormente giustificata
dal
fatto che sia gli ingressi (nel caso concreto almeno uno) sia la linea
di uscita sono linee bilanciate, il cui scopo è di ridurre
al
minimo il rumore di modo comune, cioè il rumore raccolto dal
cavo o generato dalle correnti disperse che fluiscono lungo la massa
del cavo.
Il modo più efficace per ottenere un'alta reiezione
è
proprio quello di usare un trasformatore (vale sia per gli ingressi che
per le uscite), qualsiasi altro sistema introduce uno sbilanciamento,
solo un trasformatore garantisce il bilanciamento assoluto.
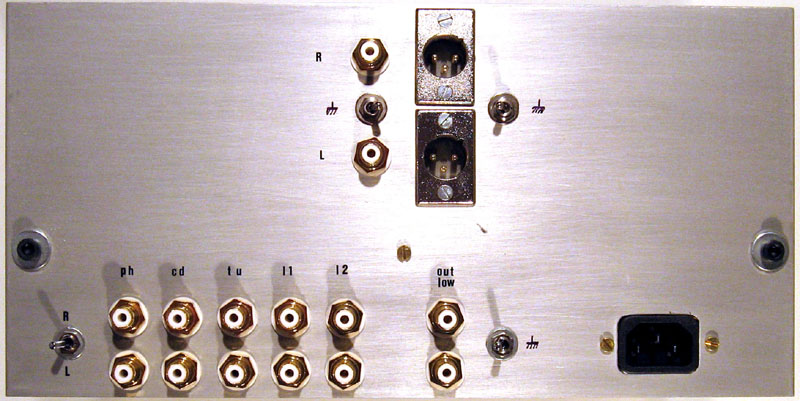 Per
una trattazione completa di questo argomento vi invito a consultare le
Application Notes di Jensen Transformers (www.jensentransformers.com). Per
una trattazione completa di questo argomento vi invito a consultare le
Application Notes di Jensen Transformers (www.jensentransformers.com).
Lo
stadio di ingresso a trasformatore obbedisce a due requisiti: il primo
è quello della reiezione del rumore di modo comune, che
nella
maggior parte dei casi di sorgenti di un sistema HiFi domestico
è un plus non molto rilevante dato che le sorgenti sono
collegate con un cavo molto breve ma diviene fondamentale quando si usa
l'input bilanciato magari perché vi è
collegato un
amplificatore microfonico collocato vicino ai microfoni e non
all'amplificatore, il secondo è di evitare l'uso di
potenziometri: i potenziometri scadenti sono una fonte di rumore e di
noie con l'invecchiamento, i potenziometri di alta qualità,
o i
commutatori con resistenze calibrate alla fine costano non meno di un
buon trasformatore (vedi DACT, solo per fare un esempio), e a mio
parere (ma qui ovviamente entriamo nel campo dell'opinabile) suonano
peggio.
Queste sono le ragioni che per questo progetto ho scelto questa
topologia.
Ovviamente tutto questo sarebbe inutile se la valvola utilizzata non
fosse all'altezza, di qui la scelta della valvola, il doppio triodo
ECC99.
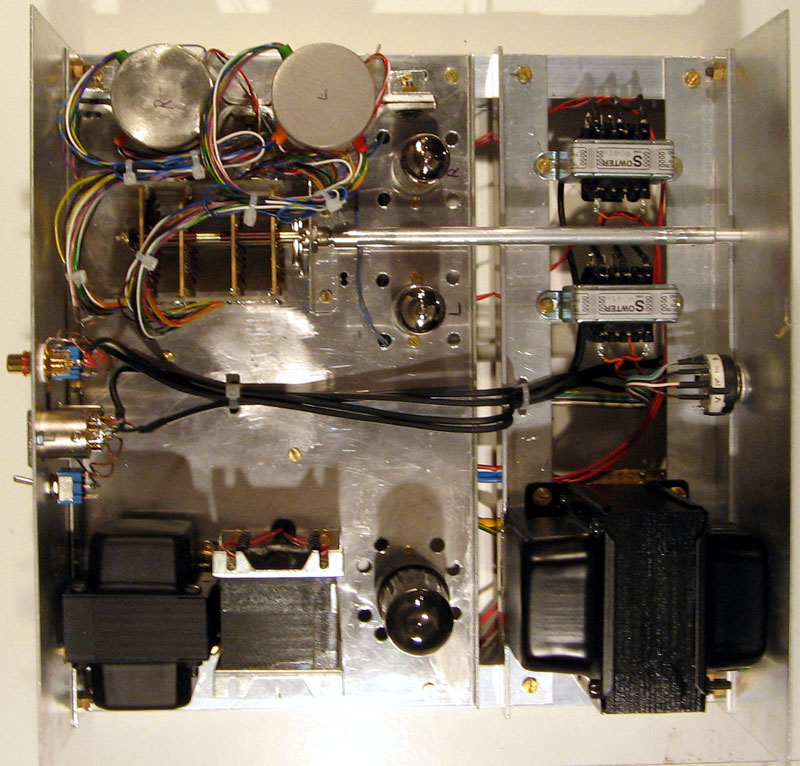 E'
una valvola robusta, in grado di erogare correnti generose (non
dimentichiamo il carico di 600 ohm), estremamente lineare (risulta
avere una distorsione di terza armonica quasi inesistente, a differenza
ad esempio della 6DJ8 o ECC88 che dir si voglia) e con il guadagno
giusto per un amplificatore di linea in questa configurazione; per un
guadagno minore la scelta sarebbe caduta sulla 6H30. E'
una valvola robusta, in grado di erogare correnti generose (non
dimentichiamo il carico di 600 ohm), estremamente lineare (risulta
avere una distorsione di terza armonica quasi inesistente, a differenza
ad esempio della 6DJ8 o ECC88 che dir si voglia) e con il guadagno
giusto per un amplificatore di linea in questa configurazione; per un
guadagno minore la scelta sarebbe caduta sulla 6H30.
Sono tutte valvole nuove, di produzione corrente, la 6H30 beneficia
della destinazione militare, ulteriore garanzia di qualità.
L'uso delle esoteriche NOS a mio parere non è giustificato
né dal costo (non che la ECC99 o la 6H30 costino poco, ma
nulla
di paragonabile ai prezzi di affezione che si vedono in giro per alcune
NOS) né dalla reperibilità: chi mi assicura che
qualora
dovessi sostituirne una la ritroverei?
Trovo poco serio proporre
progetti, o peggio prodotti, a prezzo non proprio di liquidazione, di
cui non si possa garantire la manutenzione.
A parte il fatto che nulla mi garantisce la qualità delle
NOS:
posso fidarmi di un tubetto di vetro rimasto in magazzino (quando va
bene, perché magari è anche stato trasportato
varie
volte) per 20 o 30 anni?
|
Lo schema
elettrico
Lo schema elettrico è rappreasentato a fianco.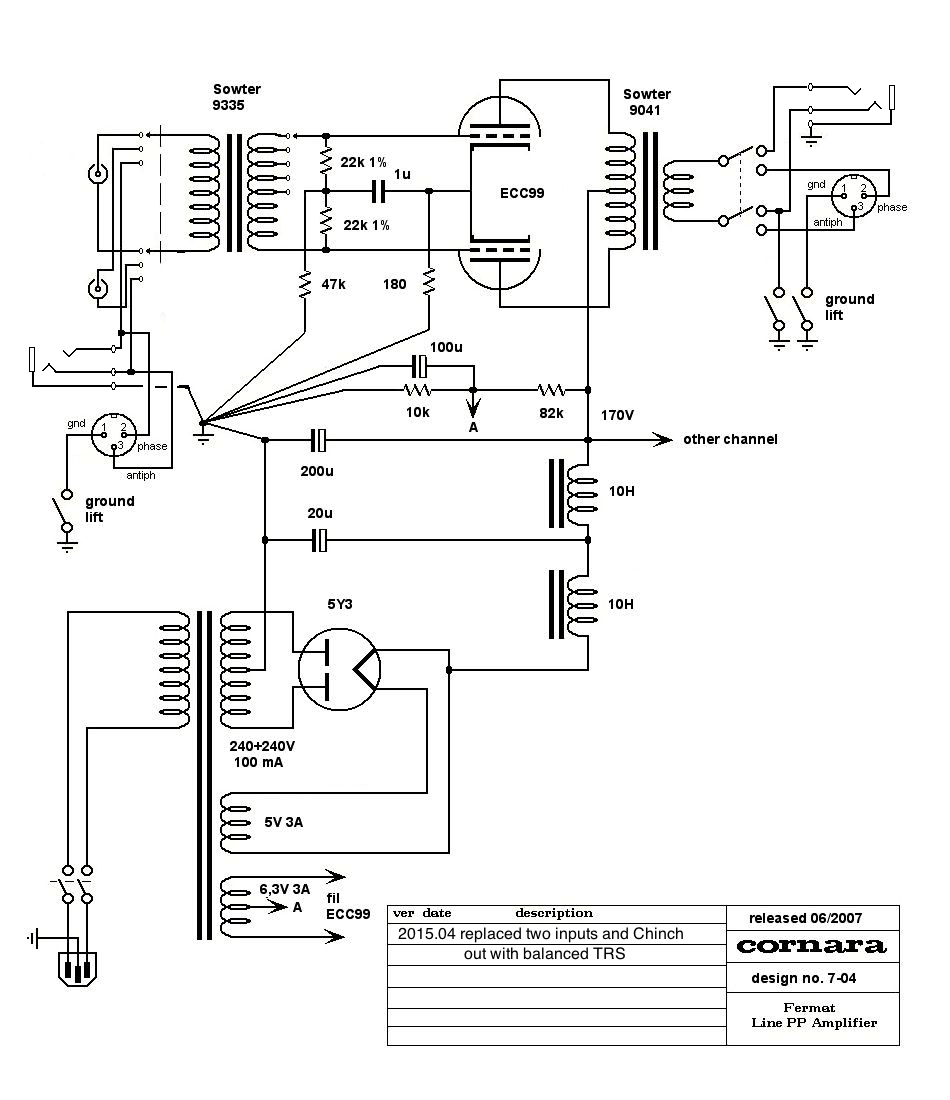
E' concettualmente semplice, analizziamo separatamente i vari
stadi.
Il
circuito di ingresso
Il circuito di ingresso è costituito da un selettore e da un
trasformatore che svolge anche la funzione di controllo di volume.
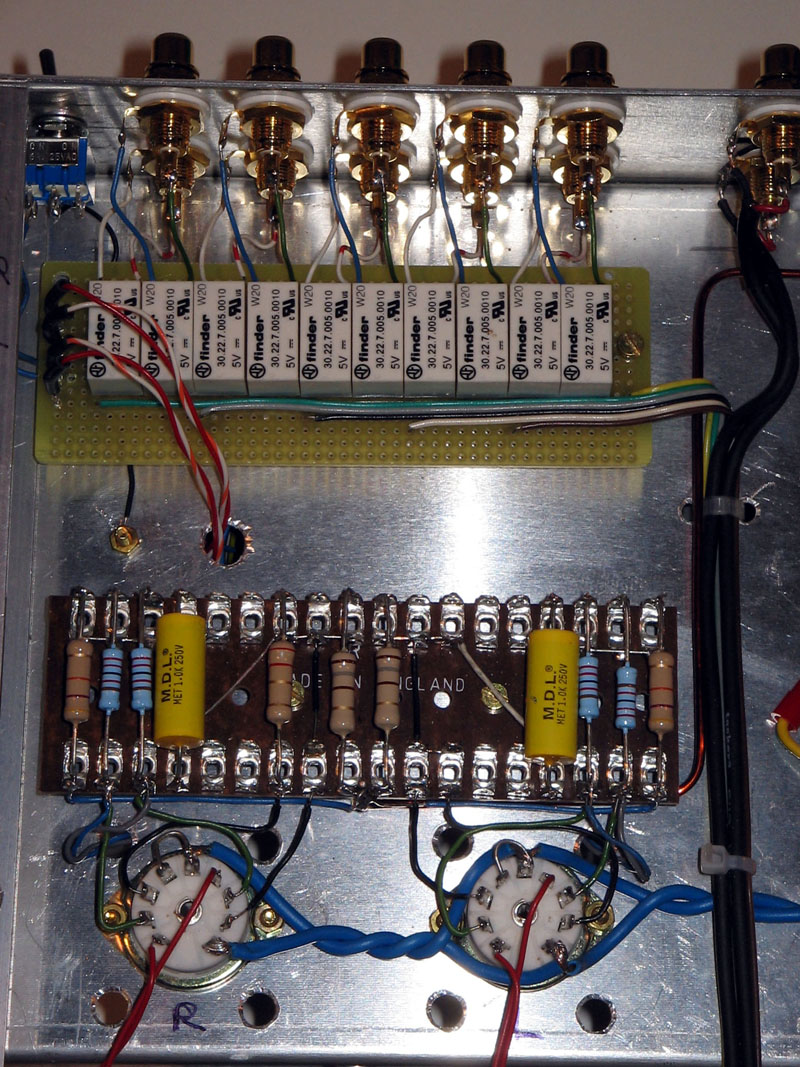 Il selettore
è
realizzato mediante commutatori a relais; come si vede dal circuito
entrambi i poli del segnale sono commutati: in questo modo
una sola sorgente alla volta è elettricamente collegata
all'amplificatore, ciò riduce la possibilità di
loop di massa e permette di collegare anche connettori per linee
bilanciate senza collegare a massa uno dei capi. Il selettore
è
realizzato mediante commutatori a relais; come si vede dal circuito
entrambi i poli del segnale sono commutati: in questo modo
una sola sorgente alla volta è elettricamente collegata
all'amplificatore, ciò riduce la possibilità di
loop di massa e permette di collegare anche connettori per linee
bilanciate senza collegare a massa uno dei capi.
Nel mio caso specifico ho un solo connettore XLR, montato frontalmente
per flessibilità, e collegato in parallelo ad un RCA
(però non possono essere usati in parallelo: o si collega il
connettore RCA o il XLR), mentre gli altri sono RCA in quanto destinati
all'uso con sorgenti HiFi standard e sono normalmente montati sul
pannello posteriore.
Un commutatore “ground lift” consente di collegare
a massa il polo freddo del primario del trasformatore di ingresso o
tenerlo “sollevato”: permette di ottenere un
isolamento galvanico dell'ingresso che può essere utile per
ridurre l'eventuale rumore di fondo.
Il connettore XLR è dotato del suo “ground
lift” che collega a massa la calza del cavo: nel caso di uso
della linea bilanciata il “ground lift” che collega
a massa il primario del trasformatore deve essere off.
Il trasformatore di ingresso è un Sowter 9335: ha un
secondario a 27 posizioni con livello variabile a scatti di 2 dB e
rapporto di trasformazione 1:1 sulla posizione a 0 dB.
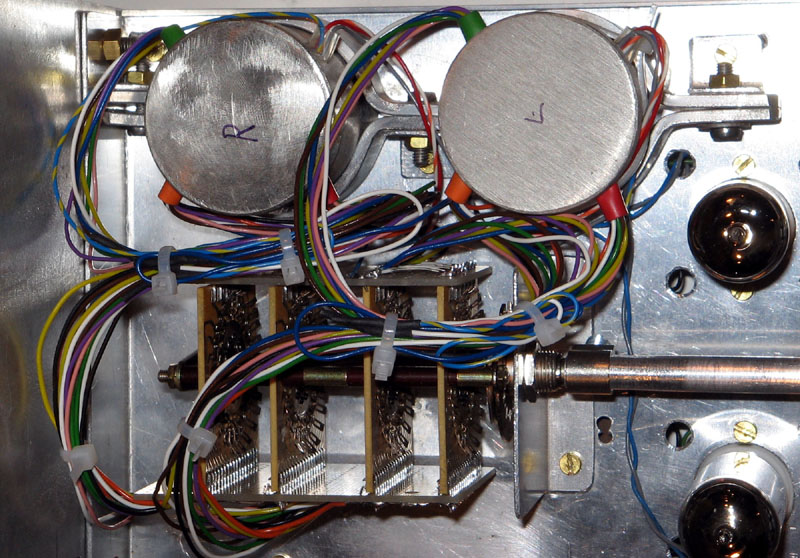 Ho utilizzato un
commutatore a
24 posizioni perché è praticamente impossibile
trovarne a 26 posizioni; quello che vedete nelle immagini è
un eccellente Alps a 4 vie che avevo disponibile, cui ho collegato le
vie in parallelo due a due. Ho utilizzato un
commutatore a
24 posizioni perché è praticamente impossibile
trovarne a 26 posizioni; quello che vedete nelle immagini è
un eccellente Alps a 4 vie che avevo disponibile, cui ho collegato le
vie in parallelo due a due.
Ho dovuto pertanto rinunciare a sfruttare tre posizioni di guadagno del
trasformatore: dato che il guadagno della valvola è
sufficiente ho optato per perdere lo step a 0 dB, lo step a –
4 dB e lo step a -50 dB.
Questa scelta è la più valida per me, date le
caratteristiche dei dispositivi che debbo collegare in ingresso ed in
uscita, ma ovviamente qualsiasi altra scelta è altrettanto
valida.
Lo
stadio di amplificazione
Come dicevo, è basato sulla ECC99 ed il circuito
è esattamente quello proposto nella simulazione
dell'articolo “L'alba” quindi un push pull con
catodi in comune e resistenza di catodo non disaccoppiata.
Il punto centrale degli ingressi, avendo un trasformatore di ingresso
con un solo secondario, viene realizzato con un partitore di resistenze
il cui nodo centrale costituisce il punto neutro; detto punto neutro
viene collegato al punto comune dei catodi con un condensatore (massa
di segnale) ed alla massa elettrica con una resistenza per dare alle
valvole il riferimento della polarizzazione (massa di alimentazione).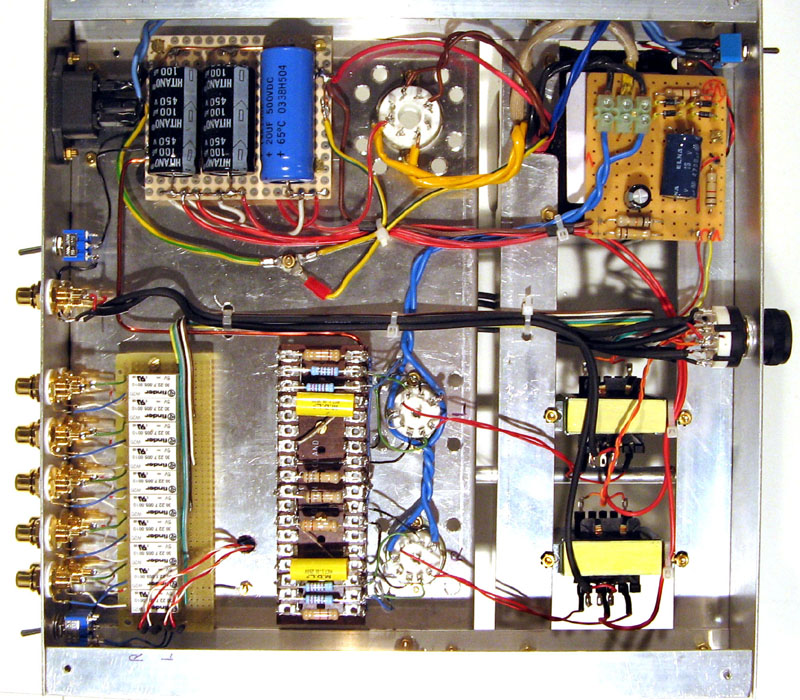
Il punto centrale delle resistenze da 22 kohm non ha segnale essendo
applicati ai due capi del partitore segnali uguali ma con fase opposta,
il punto di unione dei catodi non ha segnale in quanto le due valvole
sono in push pull in classe A profonda (la corrente anodica
è 14 mA per triodo) quindi la somma istantanea delle
correnti anodiche è costante e quindi il segnale alternato
è nullo.
Questo è vero nel mondo ideale dei componenti perfetti; nel
mondo reale né le resistenze né le valvole sono
perfettamente uguali, quindi in entrambi i punti c'è un
piccolo segnale, dovuto esclusivamente alle tolleranze dei componenti.
Il condensatore che collega questi due punti serve a compensare queste
tolleranze collegando per il segnale alternato i due punti in
questione: è quella che ho definito la massa di segnale, che
coincide con il punto di unione dei catodi.
Proprio per compensare le tolleranze costruttive delle valvole nel
circuito reale può essere presente una resistenza di basso
valore (pochi ohm) in serie ad uno dei catodi e che serve ad
equilibrare le correnti di riposo dei due triodi.
La resistenza non è indicata nel circuito in quanto non
è necessariamente presente: nel mio esemplare c'è
una sola resistenza da 2,2 ohm su un catodo di una sola delle due
ECC99, l'altra è perfettamente bilanciata senza bisogno di
aggiustamenti; è evidente che le tolleranze costruttive dei
due triodi nello stesso bulbo sono veramente ridotte.
Per il resto il circuito è semplicissimo, non ho messo le
resistenze grid stopper dato il basso guadagno totale e non ho
riscontrato all'oscilloscopio alcuna tendenza all'autooscillazione.
Il
circuito di uscita
E' costituito dal trasformatore, un Sowter 9041, e dal commutatore
selettore delle uscite.
Il trasformatore di uscita ha prestazioni eccellenti (circa 120 kHz di
banda con distorsione propria trascurabile) ma mantiene queste
prestazioni solo se le correnti nei due rami differiscono di meno di
0,5 mA: è pertanto indispensabile che le correnti anodiche
siano equilibrate al meglio, la procedura di taratura è
descritta nel paragrafo dedicato.
In alternativa il modello 9900 ammette uno sbilanciamento fino a 5 mA,
con un ingombro ed un costo molto maggiori.
Il trasformatore è un dispositivo per push pull con rapporto
spire pari ad 1:5 per una impedenza di carico fino a 600 ohm e segnale
massimo di uscita di 11 Veff per distorsione inferiore allo 0,5 % (a
livelli normali, dell'ordine di 1 o 2 Veff la distorsione è
di almeno un ordine di grandezza inferiore).
Il selettore delle uscite commuta fra l'uscita RCA (sbilanciata) e
l'uscita XLR (bilanciata), ciascuna con il suo commutatore
“ground lift”.
Questo per poter lasciare perennemente collegate le linee di tipo
diverso, che però debbono essere usate in alternativa.
Nel trasformatore è presente un ulteriore secondario con
rapporto 1:10, non indicato in circuito, che può essere
lasciato scollegato, è previsto per una eventuale
controreazione ed io l'ho utilizzato per avere una ulteriore uscita a
basso livello e bassa impedenza.
L'alimentazione
La classica alimentazione con valvola rettificatrice a due semionde e
filtro ad ingresso induttivo a due stadi.
Non mi dilungo ulteriormente sulle virtù del filtro ad
ingresso induttivo, che richiede solo una induttanza ad alto isolamento
(le normali induttanze per filtri capacitivi non sono adatte),
anch'essa fornita da Sowter, numero di catalogo 8970; la seconda
induttanza è un normale componente per filtri capacitivi.
La valvola è la 5Y3 che presenta una eccellente
caratteristica di rumore di commutazione (forse la migliore in
assoluto) ed è adatta a basse tensioni e correnti.
Il suo unico difetto è che, essendo a riscaldamento diretto,
deve funzionare in posizione verticale.
I filamenti sono alimentati in alternata, trattandosi di un
amplificatore di linea non è necessario alimentarli in
continua, sollevati a circa 20 V da massa, il che riduce il rumore di
fondo ed aumenta l'affidabilità delle valvole (è
interessante il grafico tratto dall'eccellente libro di Robert "Bud"
Tomer, Getting the Most out of Vacuum Tubes).
La
costruzione
Il telaio è secondo la mia abitudine costruito con profilati
di alluminio avvitati, il trasformatore di alimentazione contribuisce
alla solidità dell'insieme.
Il fondo è in alluminio, forato in corrispondenza delle
valvole, il coperchio in acciaio con grata di areazione; come sapete
non mi piacciono le valvole a vista, ed a parte l'estetica sono anche
pericolose.
La filatura è punto a punto su strisce di connettori, il
circuito è per altro semplicissimo.
La parte che richiede una attenzione assoluta è la saldatura
dei reofori dei trasformatori di ingresso al commutatore; assieme ai
trasformatori viene fornito comunque un chiarissimo schema di montaggio.
I trasformatori di ingresso non hanno fori filettati per il fissaggio,
è quindi necessario costruire una fascia metallica di
fissaggio che sia meccanicamente solida e colleghi a massa l'involucro
esterno (in acciaio fresato); è possibile che fascette
metalliche per il fissaggio di elettrolitici possano andare bene, se le
trovate sufficientemente robuste e del diametro adatto, circa 46 mm.
Per fissare i trasformatori di ingresso e di uscita usate viti in
ottone ed un cacciavite non magnetizzato.
I condensatori dell'alimentazione sono montati su basetta millefori, la
massa è stellare, ulteriore precauzione dopo la separazione
della massa di segnale dalla massa di alimentazione.
Il telaio è collegato alla terra, assolutamente
indispensabile dato che il telaio è metallico.
Messa
a punto
L'unica messa a punto da effettuare
è il bilanciamento delle correnti dei triodi di ogni push
pull.
E' l'unica parte laboriosa della realizzazione; laboriosa anche se
concettualmente semplice, ed ecco perché.
Come abbiamo detto, le correnti nei due rami dei trasformatori di
uscita debbono differire di meno di 0,5 mA per non causare una
magnetizzazione del nucleo in grado di degradare pesantemente le
prestazioni.
Questo bilanciamento deve essere in atto dal primo istante in cui si
alimenta il circuito in quanto bastano pochi secondi per
causare il guaio.
Pertanto il bilanciamento delle correnti deve essere effettuato prima
di collegare i trasformatori e dopo aver accuratamente rodato le
valvole: durante le prime ore di funzionamento la corrente anodica
varia anche del 10% e, dato che la corrente di riposo è
fissata a 14 mA la variazione può essere più che
sufficiente a danneggiare il trasformatore (intendiamoci, non
è un danno permanente, esiste una apposita procedura di
smagnetizzazione, ma è più laboriosa della
procedura di allineamento che sto descrivendo).
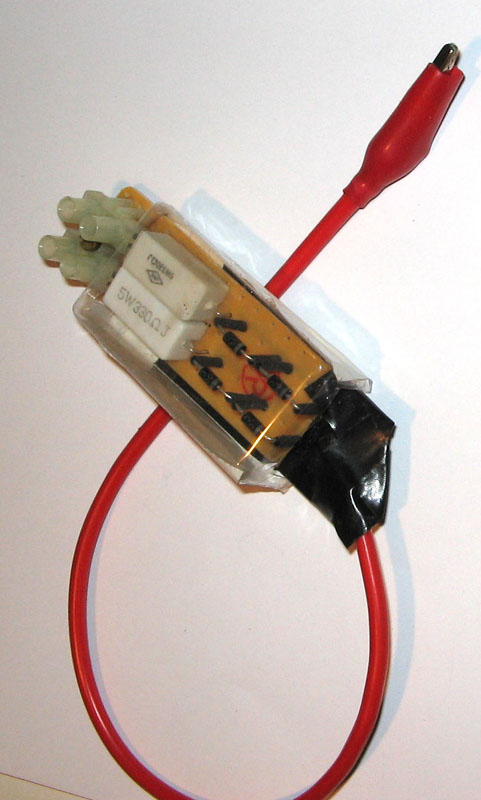 Ulteriore inghippo:
l'allineamento deve essere effettuato con il telaio capovolto, ma la
5Y3 non gradisce tale modo di operare. Ulteriore inghippo:
l'allineamento deve essere effettuato con il telaio capovolto, ma la
5Y3 non gradisce tale modo di operare.
Pertanto tutta la procedura di allineamento si esegue sostituendo alla
5Y3 il circuito a stato solido a fianco, un rettificatore a doppia
semionda costituito da diodi 1N4007 in serie con resistenze (a filo da
330 ohm 5W) per simulare il funzionamento di un tubo a vuoto.
Diodi e resistenze sono montati su una basetta accuratamente isolata e
dotata di cavetti per il collegamento volante ma sicuro (ci sono
centinaia di volt in ballo).
La prima operazione è collegare il rettificatore provvisorio
al posto della 5Y3, non collegare i trasformatori di uscita, collegare
i quattro anodi all'alimentazione anodica, i catodi direttamente alle
relative resistenze catodiche (quelle da 180 ohm) e procedere
al rodaggio delle valvole.
Per sicurezza controllare che la corrente anodica totale sia attorno ai
55 – 65 mA e che le tensioni siano corrette.
Lasciare il tutto sotto tensione per circa 48 ore, meglio se non
continuative: durante la prima ora di funzionamento vedrete l'ago del
milliamperometro (se come me usate uno strumento analogico) muoversi un
po', per poi stabilizzarsi.
Ora siamo pronti per procedere al bilanciamento, che si effettua un
valvola per volta.
Non ho usato trimmer perché non sono favorevole all'uso di
trimmer nel caso debbano sopportare correnti elevate (15 mA a mio
parere è una corrente elevata per un trimmer) e non credo
esistano trimmer da 5 o 10 ohm.
Ho quindi realizzato su una basetta millefori il dispositivo a fianco,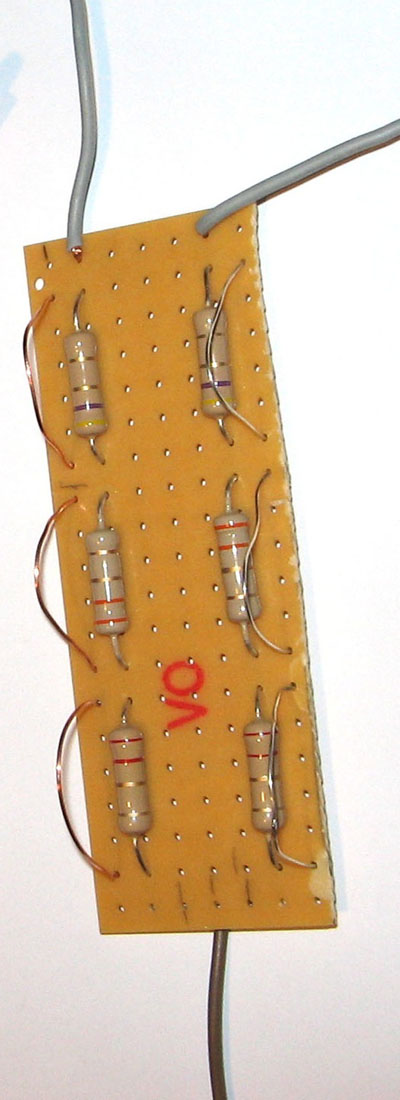 costituito da un
nodo, che si
collega alla resistenza di catodo delle due semivalvole, da cui si
dipartono due rami composti da resistenze di basso valore (da 1, 2,2,
4,7 ohm) in serie e ciascuna cortocircuitata da un ponticello; le due
estremità dei rami si collegano ai catodi delle semivalvole. costituito da un
nodo, che si
collega alla resistenza di catodo delle due semivalvole, da cui si
dipartono due rami composti da resistenze di basso valore (da 1, 2,2,
4,7 ohm) in serie e ciascuna cortocircuitata da un ponticello; le due
estremità dei rami si collegano ai catodi delle semivalvole.
Si collegano quindi due milliamperometri in serie agli anodi dei triodi
(attenzione: gli strumenti sono collegati all'alta tensione, debbono
essere posti su un piano isolato e dovete essere assolutamente sicuri
che i cavetti siano in condizioni impeccabili e che i collegamenti
provvisori siano comunque sicuri).
E' opportuno verificare prima che attorno ai 15 mA i due
milliamperometri segnino lo stesso valore: ciò si ottiene
mettendoli in serie e misurando una corrente nota; eventualmente
aggiustare uno dei due fino a che entrambi segnino lo stesso valore.
Se vi spaventa l'idea di toccare le tarature di uno strumento
(è oggettivamente più semplice da fare su uno
strumento analogico) tenete conto che ogni misura è affetta
da errore, che su questi errori è stata costruita una
teoria, che ogni strumento ha una tolleranza che dipende dalla classe
dello strumento stesso (in parole molto terra terra dal costo), che
comunque non si deve confondere la precisione con il numero di cifre,
che comunque in ambito professionale gli strumenti debbono essere
sottoposti a verifica e taratura periodicamente.
Nel nostro caso, dato che certamente i due strumenti in serie non
daranno esattamente lo stesso valore e soprattutto non ci danno
comunque il valore esatto della corrente, che nel mondo reale non
è dato conoscere, ciò che ci interessa
è che indichino un valore simile entro pochi punti
percentuali (cioè una differenza non apprezzabile ad occhio
su strumenti analogici o nulla su strumenti digitali) al
valore di corrente che ci interessa misurare.
Possiamo anche mettere la questione in questi termini: la corrente che
scorre in due milliamperometri in serie è sicuramente la
stessa ma non possiamo conoscerne il valore esatto, che nessuno dei due
strumenti ci può dare; possiamo solo essere certi che uno
dei due indica un valore che è più vicino al
vero, ma non sappiamo quale.
Quindi modificando uno dei due abbiamo il 50% di probabilità
di tarare meglio quello “peggiore” (se siamo
ottimisti, mentre se siamo pessimisti possiamo pensare che abbiamo il
50% di probabilità di starare quello migliore: è
solo questione di punti di vista).
Fatta questa operazione, con qualsiasi strumento siamo certi che una
differenza di 0,5 mA su un valore di 14 mA sulla scala 50 mA
è apprezzabile ad occhio nudo (non misurabile con una
precisione di qualche percento, ma sicuramente apprezzabile).
Con l'amplificatore alimentato si controllano ora le correnti anodiche
e si inserisce un resistenza in serie al catodo del triodo che conduce
di più, semplicemente tagliando il ponticello che
cortocircuita una delle resistenze dal lato di quel triodo: in un paio
di tentativi dovreste riuscire ad individuare il valore di resistenza
che equilibra le correnti.
Come già detto nel mio caso una delle due ECC99 non ha
richiesto alcuna compensazione, l'altra una resistenza da 2,2 ohm.
Fatta (e verificata un paio di volte) questa operazione si possono
collegare definitivamente i trasformatori di uscita agli anodi dei
triodi, collegare la resistenza necessaria sul catodo del triodo
individuato, scollegare il rettificatore provvisorio, chiudere la parte
inferiore del telaio, rimettere il tutto con i piedi per terra e
inserire la 5Y3 nello zoccolo.
|
|
|