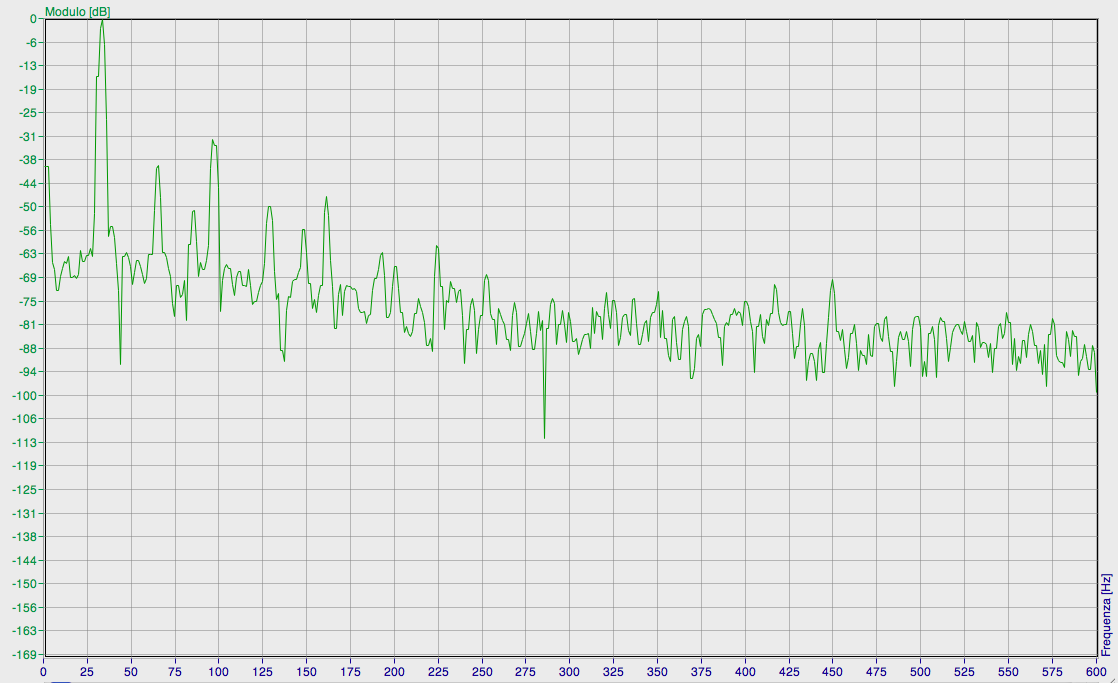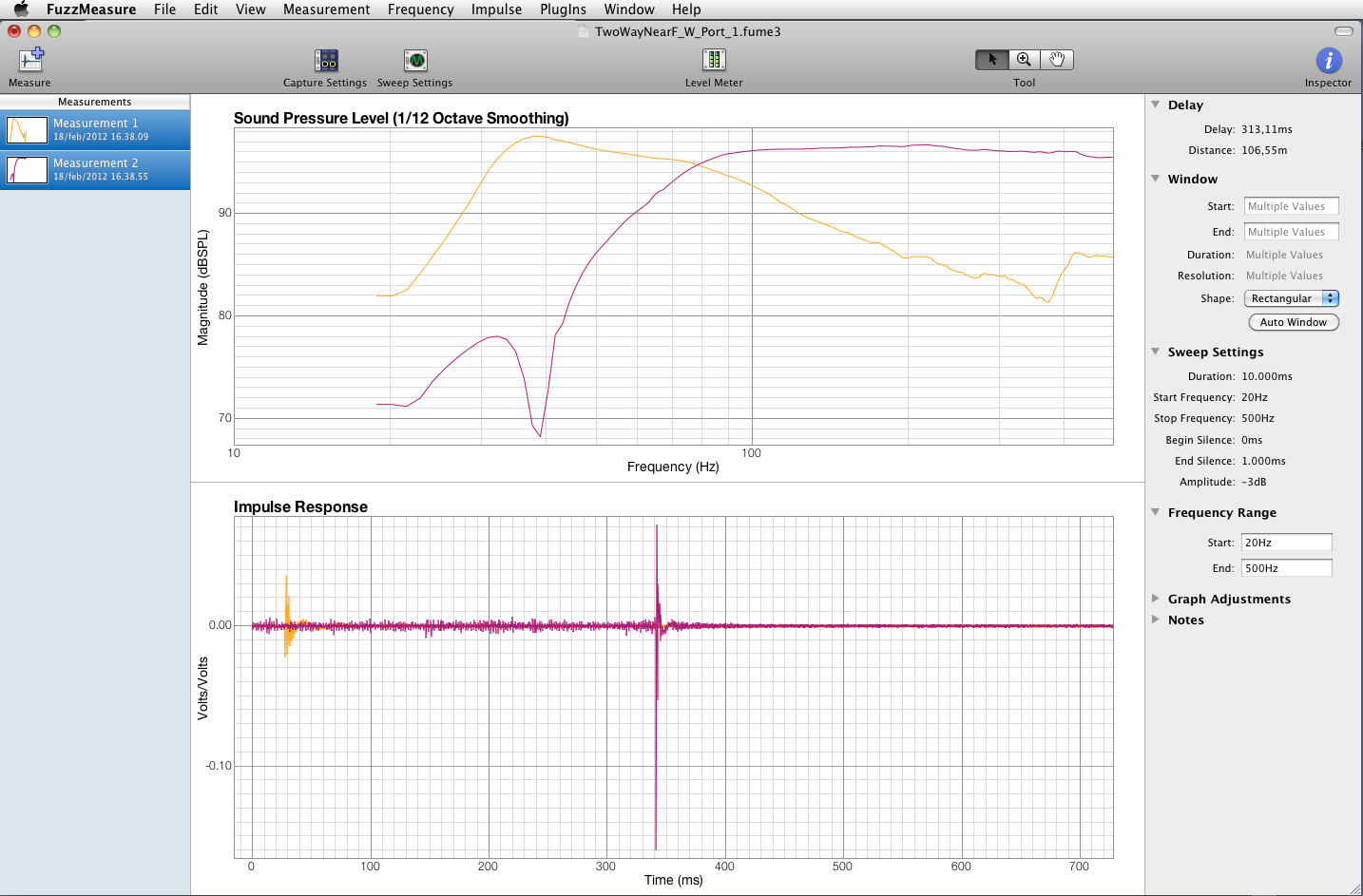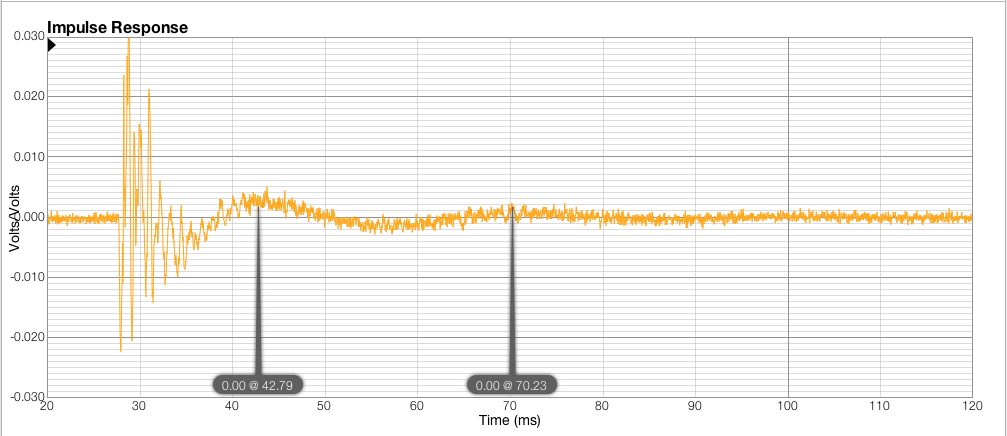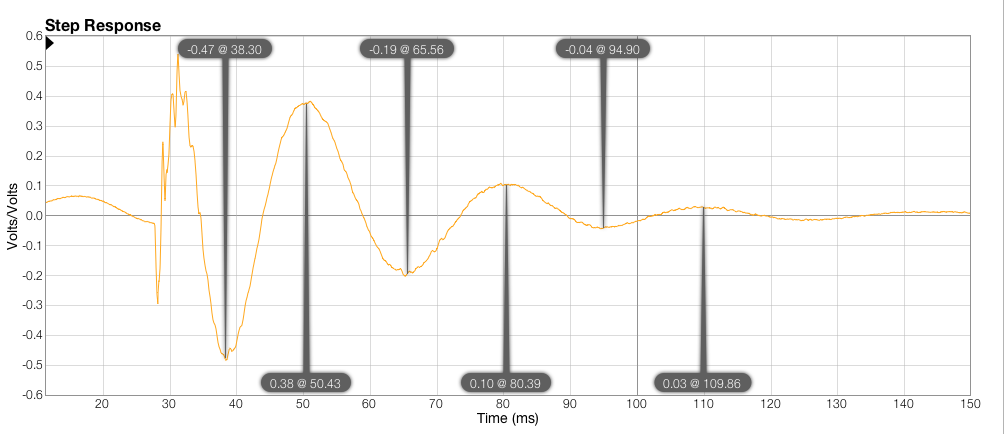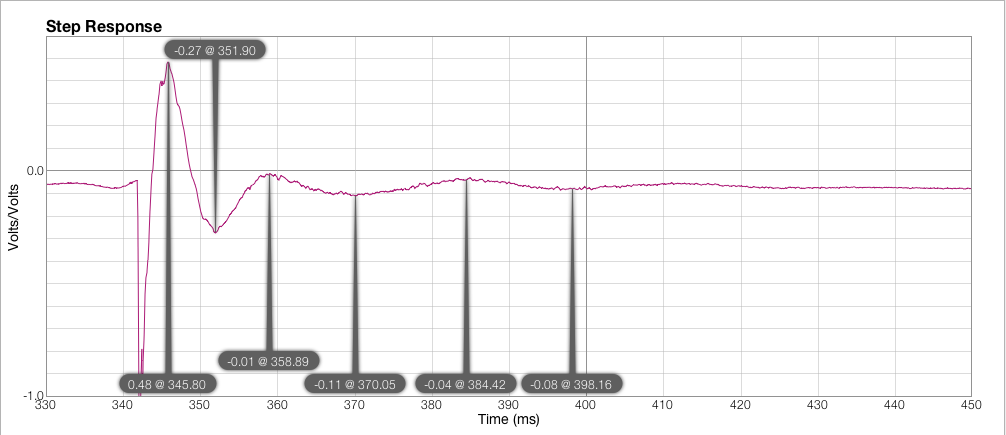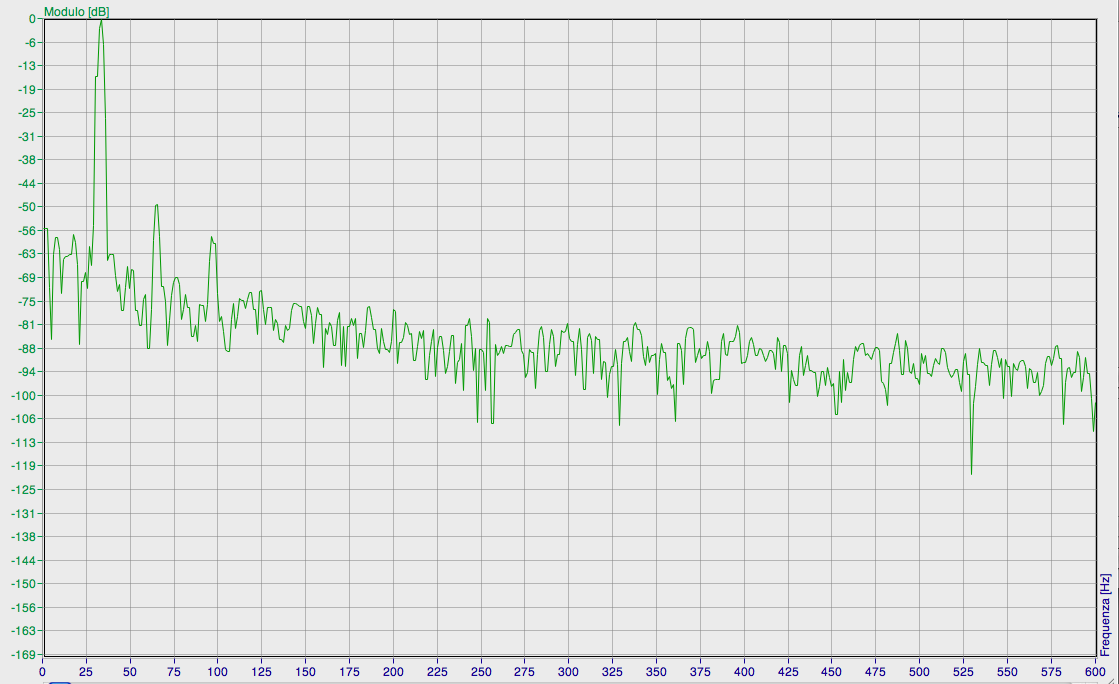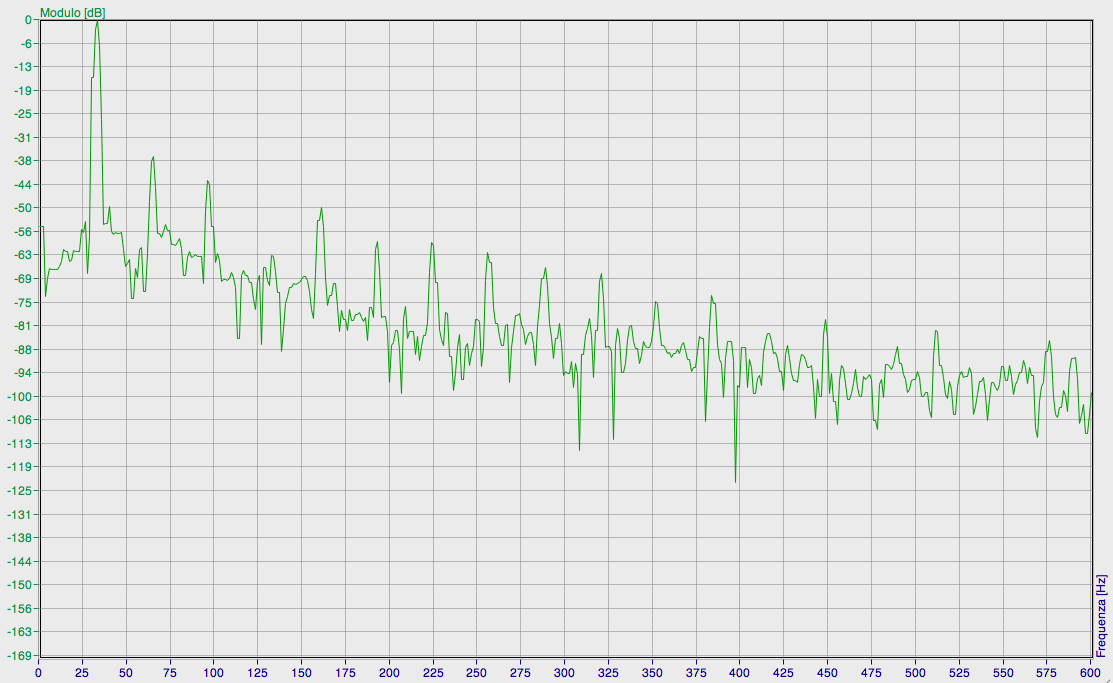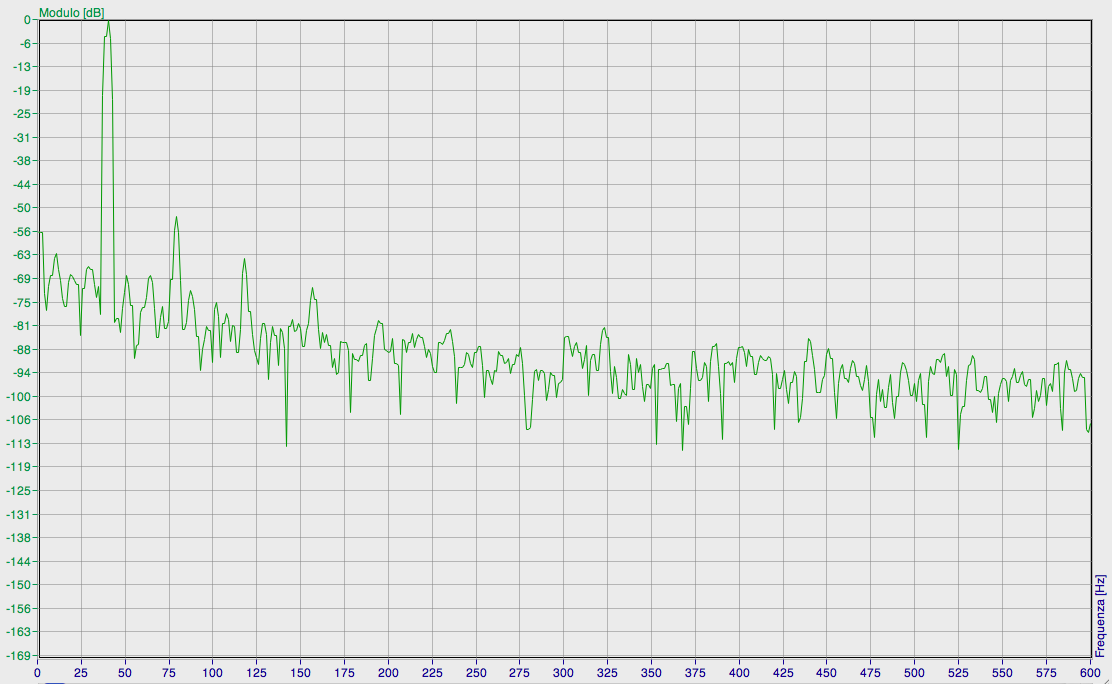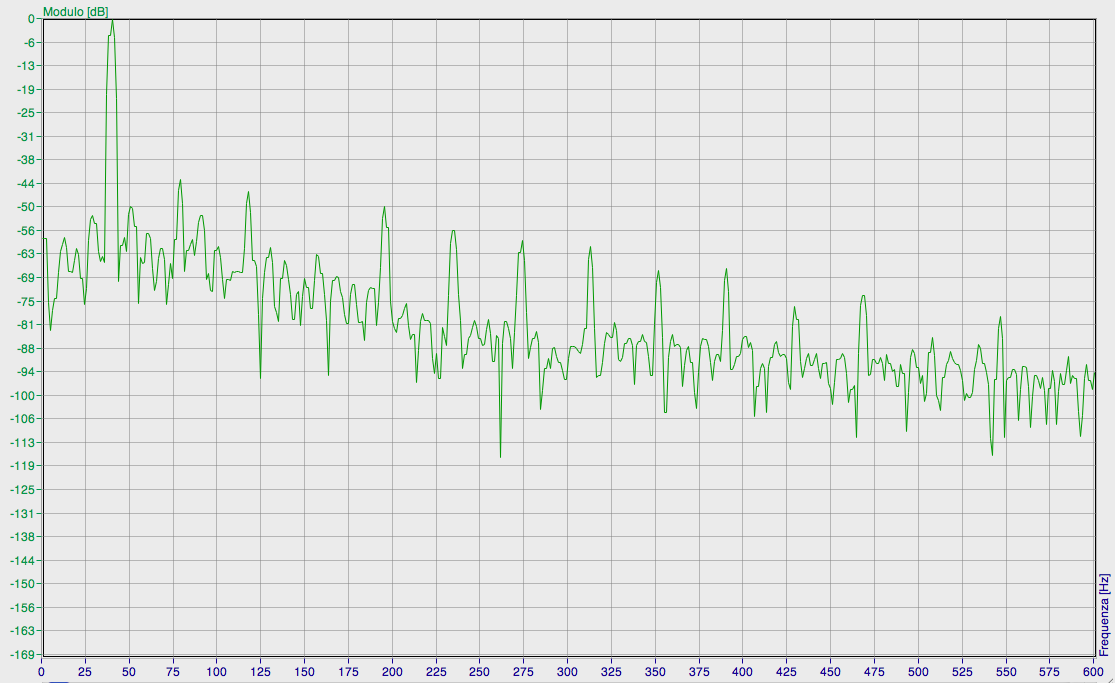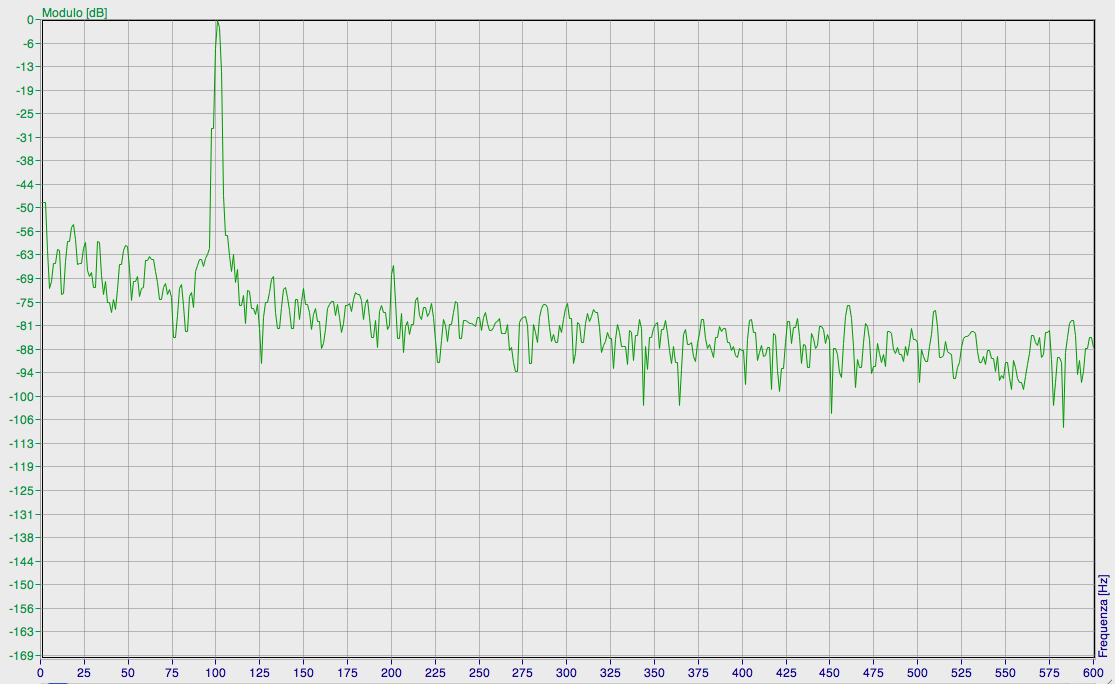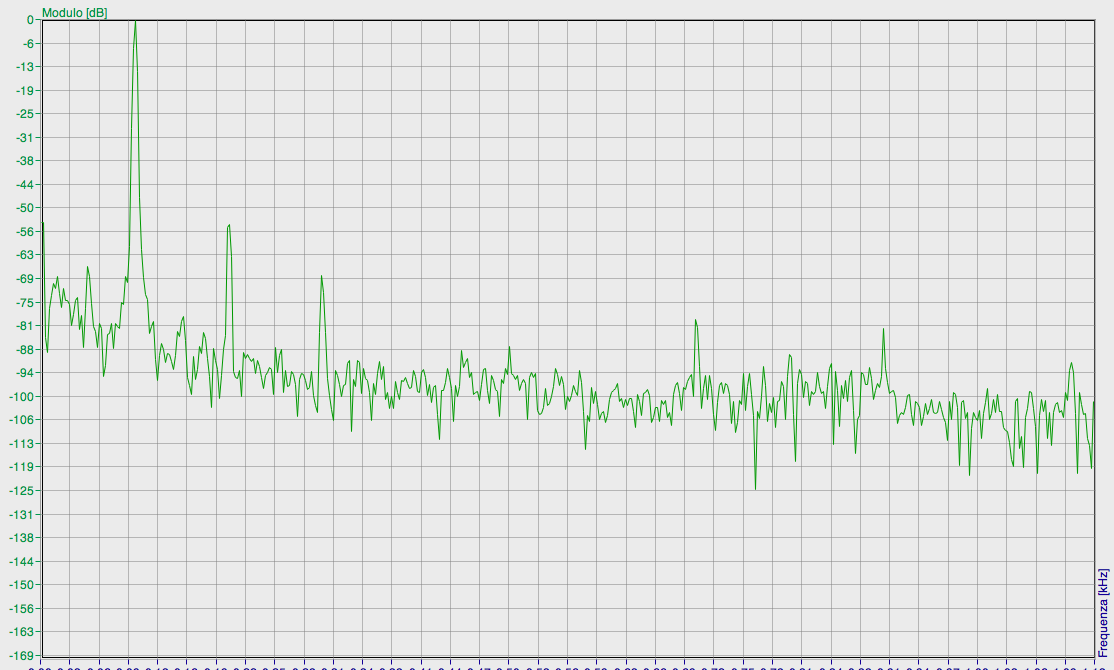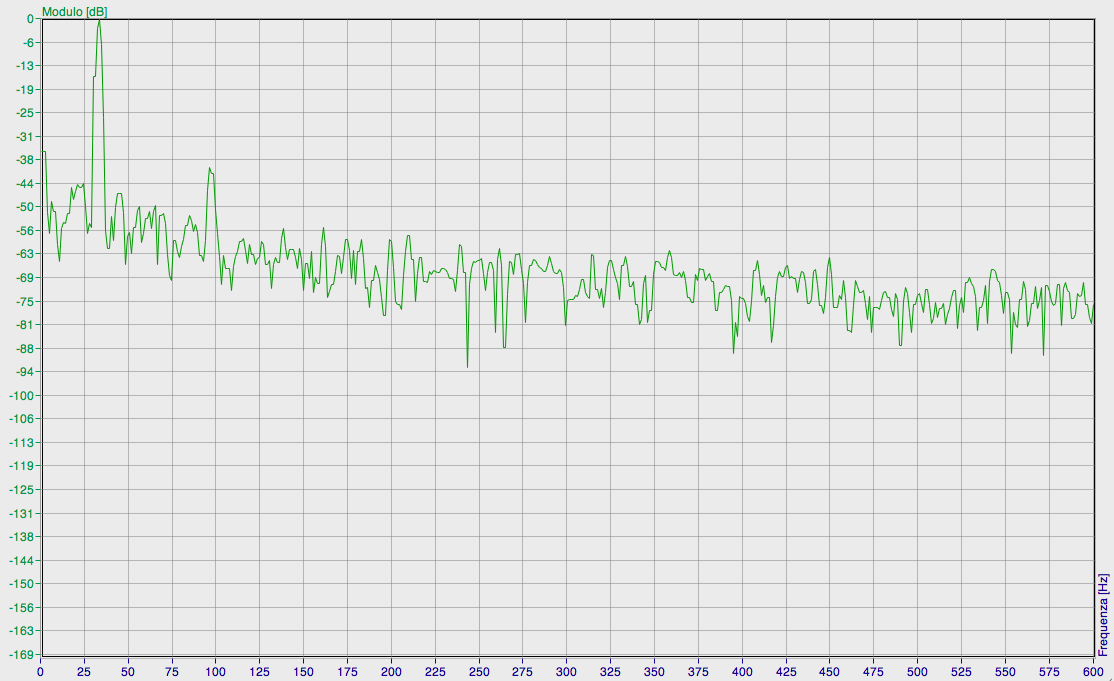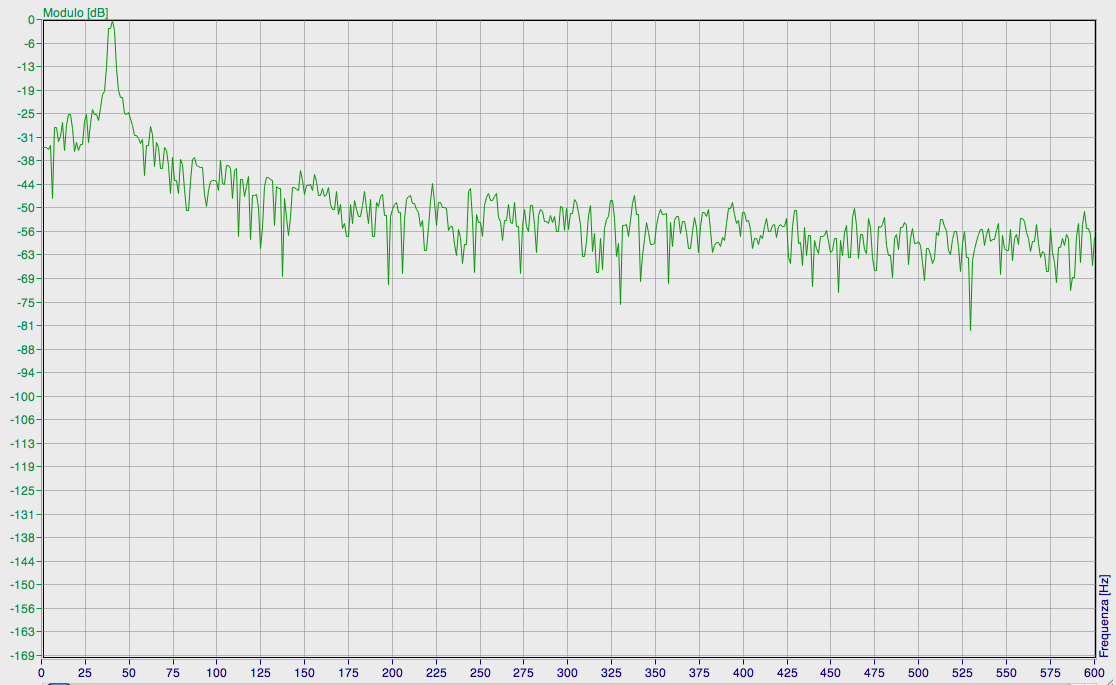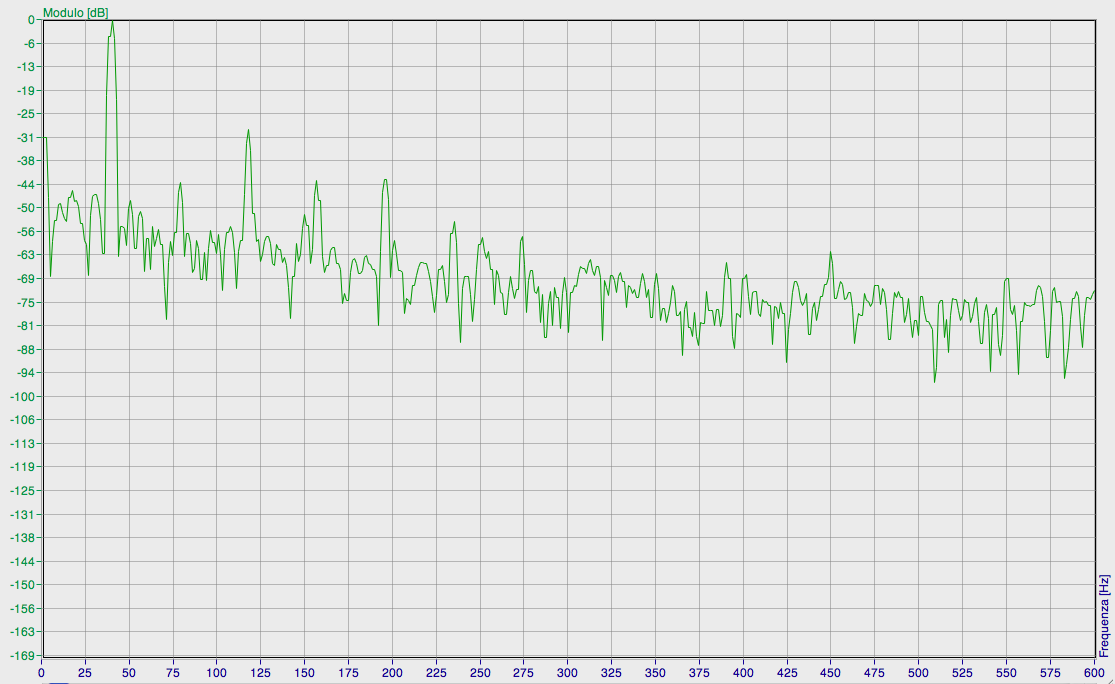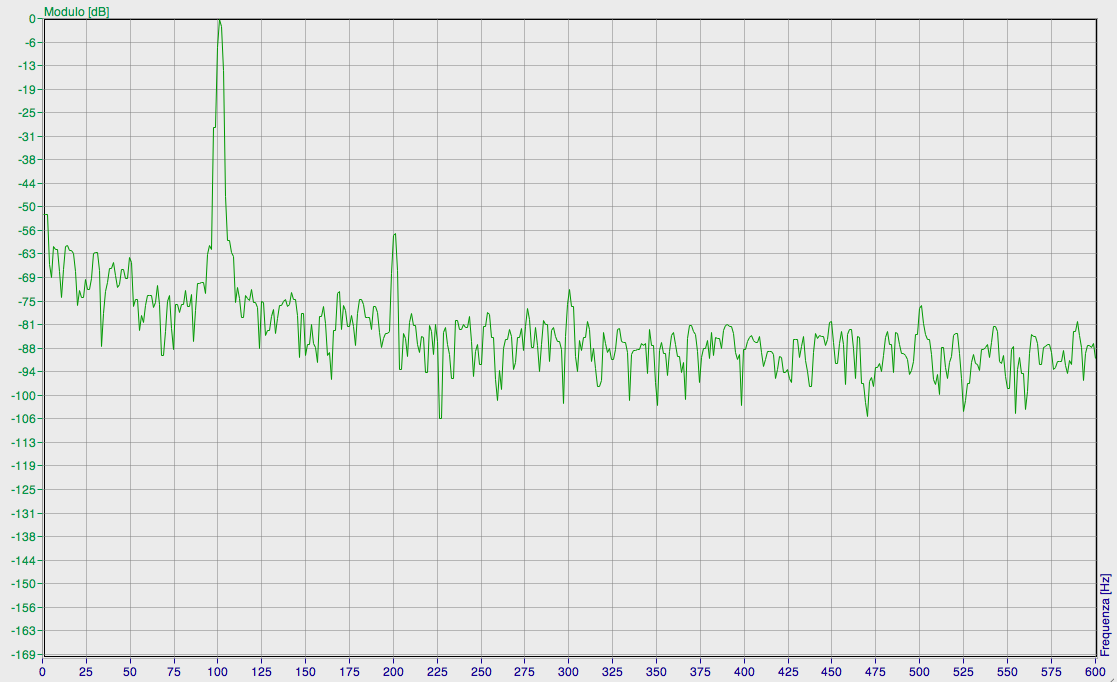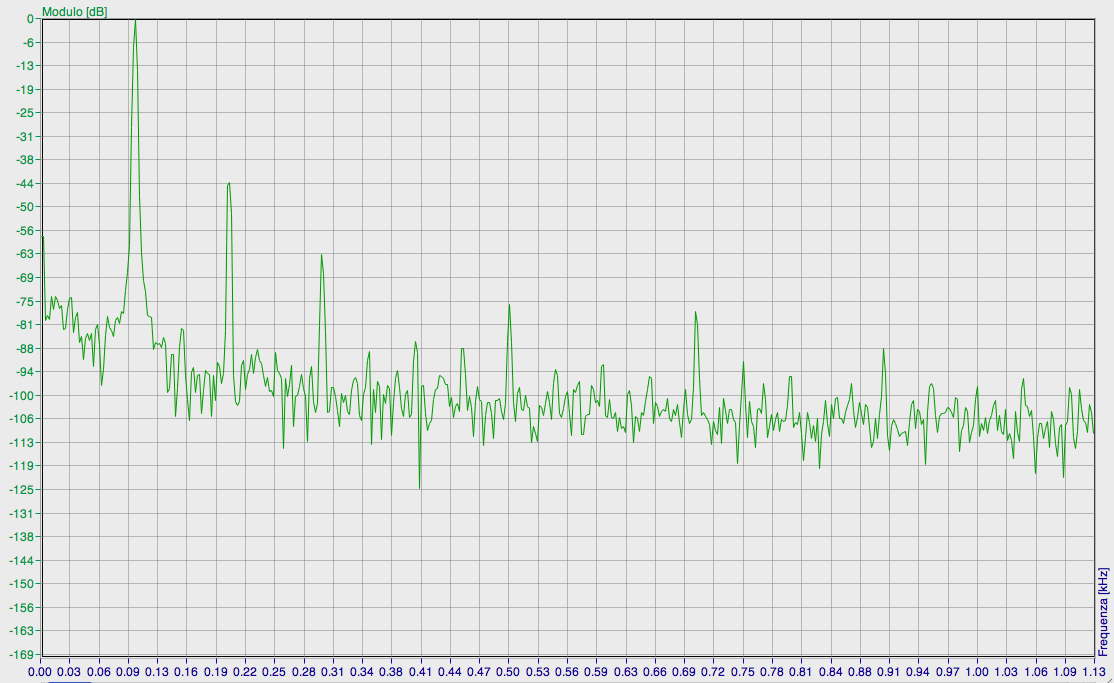|
Altoparlanti e segnali impulsivi
Il
metodo ottico ci dice tutto quello che c'è da dire su un
altoparlante in cassa chiusa, mentre per un sistema reflex il
contributo del condotto è essenziale.
Premessa e base teorica delle misure
Ho proseguito la ricerca sul comportamento dei sistemi reflex iniziata in "Altoparlanti e Impulsi",
puntando l'attenzione su quell'area che il sistema ottico non è
in grado di analizzare, e precisamente il comportamento del condotto.
Per
questa indagine è giocoforza usare il metodo acustico e, dato
che una misura acustica del comportamento del condotto è
necessariamente fatta a frequenze sotto i 100 Hz è necessario
effettuare una misura “in campo vicino”.
La misura “in campo vicino” si effettua ponendo il
microfono a pochi millimetri dall'oggetto da misurare: in questo modo
l'influenza dell'ambiente, cioè delle riflessioni, è
esclusa dalla misura in quanto il livello delle riflessioni stesse
è enormemente più basso del livello del segnale diretto,
quindi assolutamente trascurabile.
Nulla di nuovo sotto il sole, la teoria della misura “in campo
vicino” (o “near-field”) è stata presentata da
D.B. Keele alla Convention dell'AES nel maggio del 1973.
Questo metodo risulta più semplice di quello presentato da R.H.
Small nel 1971, basato sulla misura della pressione acustica
all'interno del box, seguita da una doppia differenziazione del segnale
rilevato: nella sua relazione Small dimostra che il segnale risultante
coincide con la pressione acustica misurata a distanza in ambiente
infinito.
Entrambi i metodi sono stati proposti in quanto la realizzazione di una
camera anecoica che sia realmente anecoica fino a 20 Hz è nella
pratica impossibile, o comunque troppo costoso.
Per un altoparlante con il diaframma di raggio a è dimostrato che per
f < 0,26 * c / a dove c è la velocità del suono, e
d < 0,75 * a^2 / λ
dove d è la distanza del microfono dal centro
del diaframma
l'onda rilevata dal microfono è un'onda piana e la pressione
acustica rilevata coincide con la pressione acustica teorica in uno
spazio infinito (che è l'unico ambiente veramente anecoico) con
un errore massimo di 1 dB raggiunto alla frequenza limite.
Nel caso di un sistema reflex si deve porre il microfono a pochi
millimetri (compatibilmente con l'escursione che si vuole misurare) dal
centro della cupola per misurare l'emissione dell'altoparlante, e nel
centro del condotto, a filo con la superficie del box, per misurare
l'emissione del condotto.
Si integra poi la risposta sommando le due risposte.
La somma deve essere una somma vettoriale, in quanto la fase dei
segnali è importante: risulta che sopra la frequenza di accordo
le emissioni del diaframma e del condotto sono in fase, mentre sotto la
frequenza di accordo le emissioni sono in controfase.
Inoltre la risposta del condotto deve essere “mediata”
sulla superficie del condotto rispetto alla superficie del diaframma,
in quanto la pressione dipende dalla superficie radiante, a
parità di spostamento di volume.
Se il sistema reflex ha più condotti si misurano separatamente le risposte dei condotti e poi si sommano.
SpeakerWorkshop (solo per citare un buon prodotto software gratuito) ha
una funzione dedicata alle misure in campo vicino, guida
l'effettuazione delle misure e richiede la superficie del condotto,
oltre ai parametri dell'altoparlante, per calcolare la risposta
integrata.
Le misure
Le misure sono state eseguite sulla cassa reflex presentata in “Un semplice diffusore a due vie”, che utilizza un woofer Ciare HW 161 N.
Ho usato un programma in grado di calcolare la risposta all'impulso e
la risposta al gradino a partire dalla rilevazione di un segnale
vobulato (un segnale la cui frequenza viene fatta variare da un minimo
ad un massimo), confrontando la rilevazione con il segnale originale.
Il programma è FuzzMeasure, su Mac; anche la Fig.1 in "Altoparlanti e Impulsi" è stata rilevata con FuzzMeasure.
Ho poi eseguito l'analisi spettrale del segnale emesso dal woofer e dal
condotto alla frequenza di 39 Hz, frequenza di accordo, alla
frequenza di 32 Hz e alla frequenza di 100 Hz.
Questa misura è stata eseguita con AudioExplorer (un
analizzatore di spettro) su segnale generato da AudioTest (un
generatore di segnale), sempre su Mac.
Risposta al gradino
In Fig.1 la schermata completa di FuzzMeasure, che mostra entrambe le
misure: Misura 1 in giallo la risposta del condotto, Misura 2 in viola
la risposta del woofer.
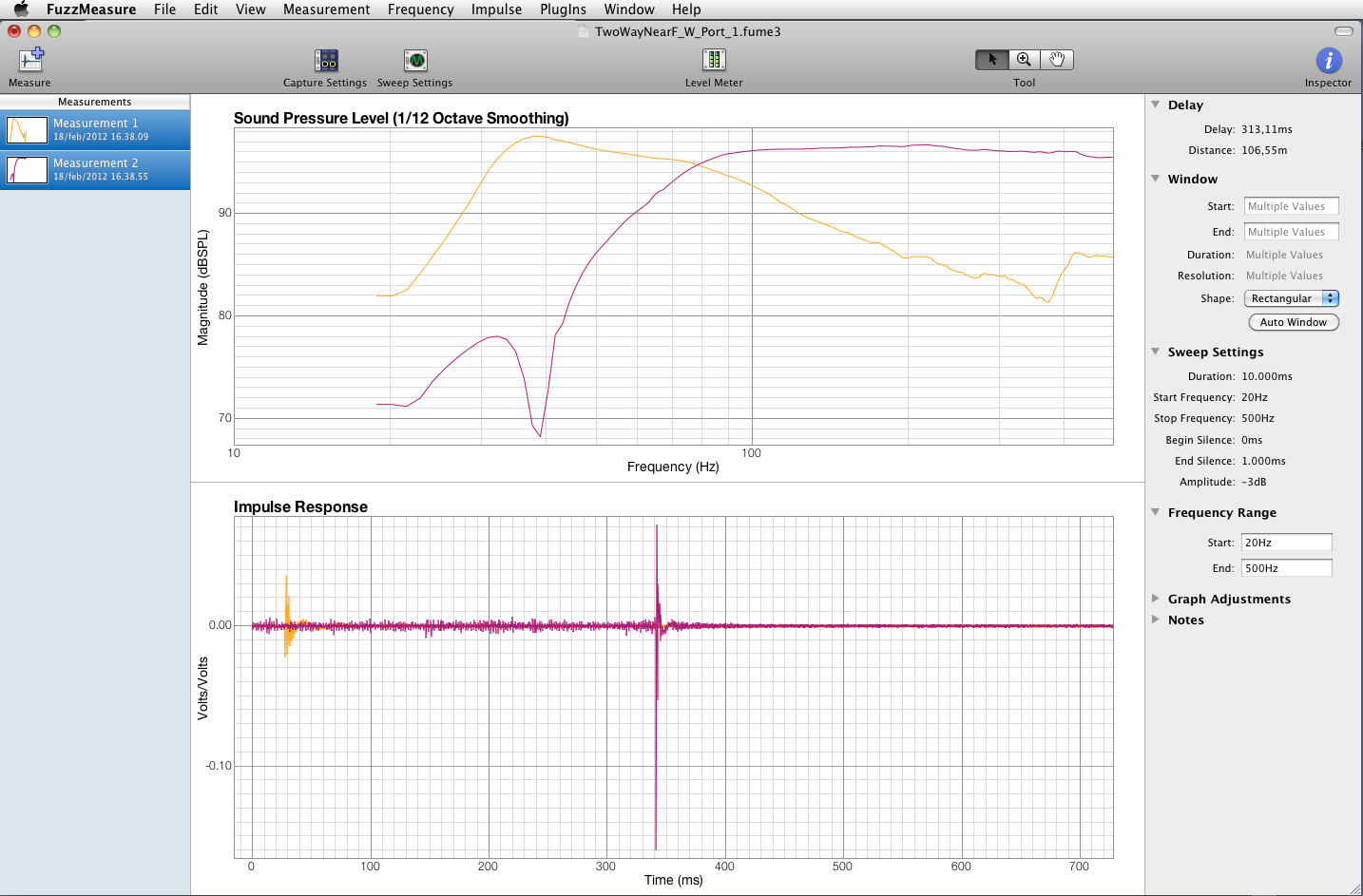
Fig.1: risposta in frequenza e all'impulso della cassa reflex
Le misure non sono mediate sulle superficie emittenti, in quanto non mi interessava eseguire la somma.
Nella parte superiore la risposta in frequenza, misurata, nella parte inferiore la risposta all'impulso, calcolata.
FuzzMeasure è in grado di calcolare, fra le varie risposte, sia la risposta all'impulso sia la risposta al gradino.
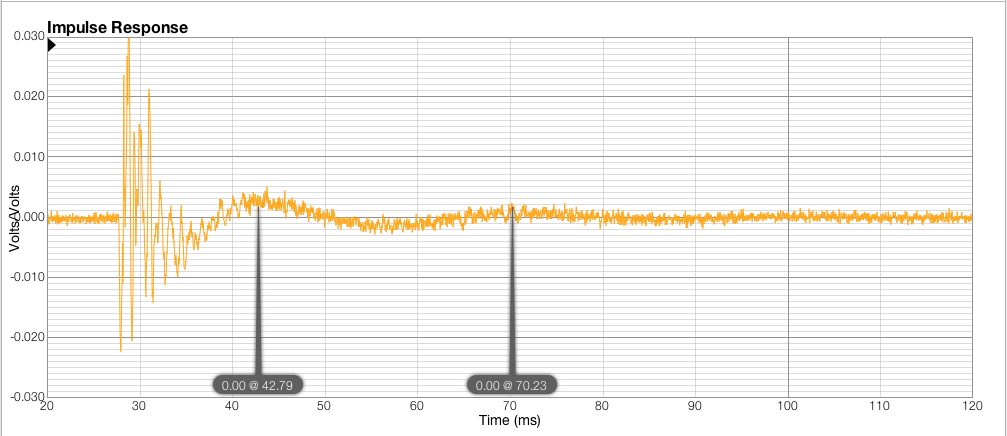
Fig. 2: risposta all'impulso del condotto reflex
In
Fig.2 vediamo la risposta all'impulso del condotto: è chiara, ma
la risposta al gradino, in Fig.3, è analizzabile con migliore
dettaglio, quindi userò le risposte al gradino per proseguire
l'analisi: in Fig.3 quella del condotto e in Fig.4 quella del Woofer.
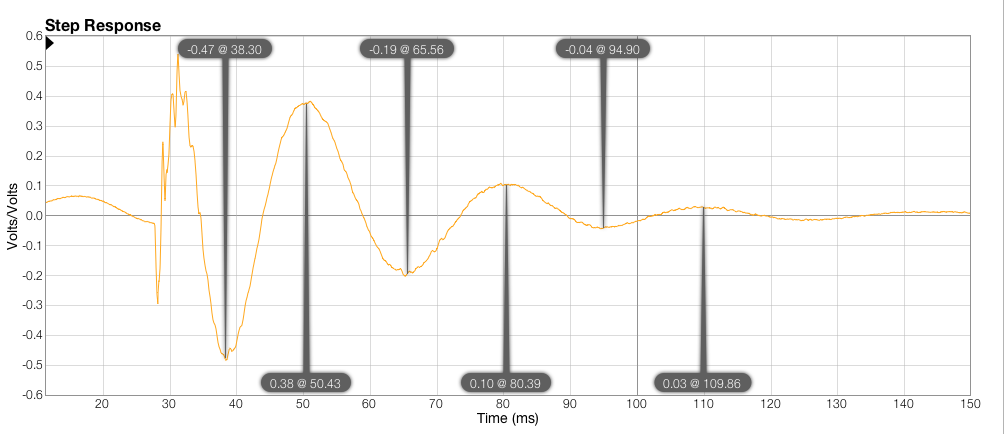
Fig.3: risposta al gradino del condotto reflex
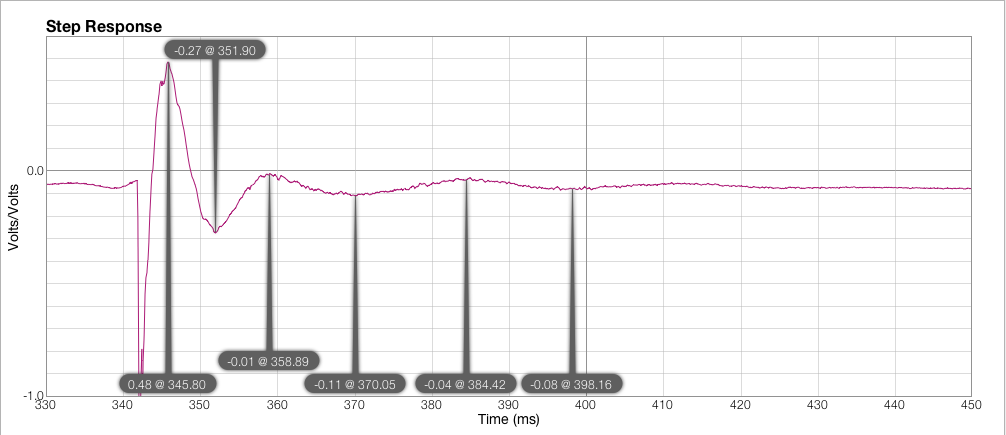
Fig.4: risposta al gradino del woofer
I
tempi iniziali del gradino sembrano “strani” in quanto
FuzzMeasure è un software nato per misure acustiche in ambiente,
quindi non calcola correttamente per distanze temporali fra il segnale
originale (generato da FuzzMeasure) e segnale rilevato che
corrispondono a distanze troppo piccole fra microfono e sorgente.
Ho verificato che per una distanza superiore a circa 25 cm il calcolo
del ritardo iniziale è corretto, in ogni caso, a parte il
ritardo iniziale, l'evoluzione successiva è corretta.
La prima cosa che appare evidente è che l'emissione del condotto
è sensibile fino a 100 ms dopo la fine dello stimolo e
l'emissione del woofer è sensibile fino a circa 70 ms dopo la
fine dello stimolo: quest'ultima è coerente con la misura
effettuata con metodo ottico, in "Altoparlanti e Impulsi", Figg.11 e 12.
Nelle risposte ho evidenziato i tempi corrispondenti ai massimi ed ai
minimi: la distanza fra due massimi o due minimi corrisponde ad un
periodo di oscillazione, dal periodo è facile calcolare la
frequenza.
Le frequenze sono il secondo aspetto rilevante di questa analisi.
Il primo periodo completo e stabile della risposta del woofer (Fig.4),
fra 345,8 e 358,89 ms, indica un periodo di 13 ms, corrispondenti a 76
Hz; il secondo periodo fra 351,9 e 370,05 indica un periodo di 18 ms
che corrispondono a 55 Hz, i periodi successivi si stabilizzano attorno
ai 39 Hz.
39 Hz è la frequenza che corrisponde al minimo della risposta
del woofer, in Fig.1, e corrisponde all'accordo del reflex, 76 Hz
è circa la frequenza corrispondente al secondo picco di
impedenza del sistema, la cosiddetta FH.
Quindi alla cessazione dello stimolo il woofer emette suono per 70 ms
con una frequenza che parte dal secondo picco di risonanza per
assestarsi sull'accordo del reflex.
Il condotto, in Fig.3, parte con un periodo a 37 Hz (27 ms fra i due
minimi a 38,3 3 65,56 ms) per assestarsi attorno ai 34 Hz, per 100 ms.
L'aspetto veramente rilevante della questione non è costituito
dai 100 ms, che tutto sommato sono un tempo breve rispetto a qualsiasi
segnale musicale vero, ma il fatto che uno stimolo qualsiasi comporta
l'emissione di suono a frequenza diversa da quella del suono originale.
Il fenomeno appare tanto più rilevante quanto più elevato è il livello.
La cassa sotto esame ha un accordo QB3N4, che è un accordo
reflex abbastanza smorzato; non ho effettuato misure su un B4, ma
avendo buttato nella spazzatura un box progettato con accordo B4 dopo
due ore di prove, per sostituirlo con un QB3N4, non ho molti dubbi sul
risultato.
Credevate che il vostro bassista stesse provando il suo nuovo fretless? Sbagliato, sta provando la sua nuova cassa.
Analisi spettrale
Ho quindi analizzato lo spettro emesso dal woofer e dal condotto a tre
frequenze, 32, 39 (accordo) e 100 Hz, a basso livello, il livello
tipico delle misure sugli altoparlanti, e a livello più elevato.
Il livello “basso” corrisponde a pochi milliwatt, quelli
cui si misurano in genere i parametri di Thiele e Small, che sono
appunto parametri per piccoli segnali.
Il livello più elevato corrisponde a circa 3 W, che per un
diffusore progettato per ascolto a livello umano in ambiente di medie
dimensioni, è un livello già “sostenuto”.
Un commento sull'interpretazione dei grafici di spettro: i grafici
presentano il livello rilevato alle varie frequenze rispetto alla
fondamentale, che è automaticamente portata a 0 dB.
Nei grafici quindi oltre alla fondamentale e ai picchi corrispondenti
ai prodotti di distorsione si vede un “fondo” costituito
dal rumore, dato che la misura è acustica.
Quindi un fondo elevato significa in realtà che il livello della fondamentale è basso.
Nelle Figure da 5 a 10 le risposte del condotto a 32 Hz, livello basso e alto, quindi a 39 Hz e a 100 Hz.
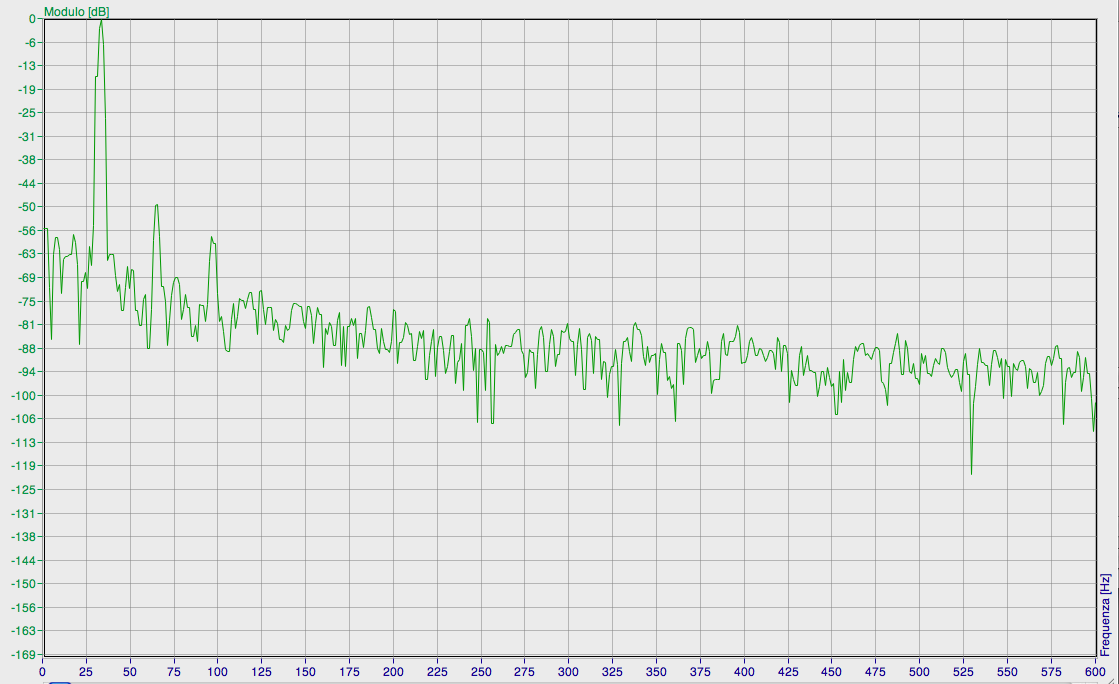
Fig.5: condotto a 32 Hz, basso livello
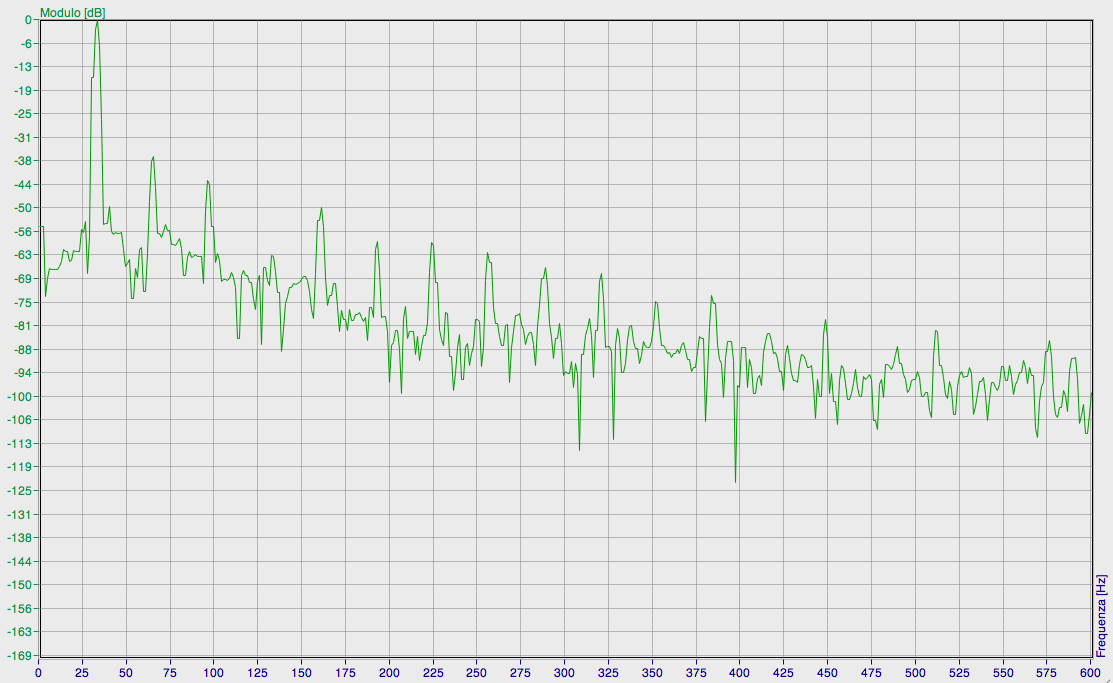
Fig.6: condotto a 32 Hz, livello elevato
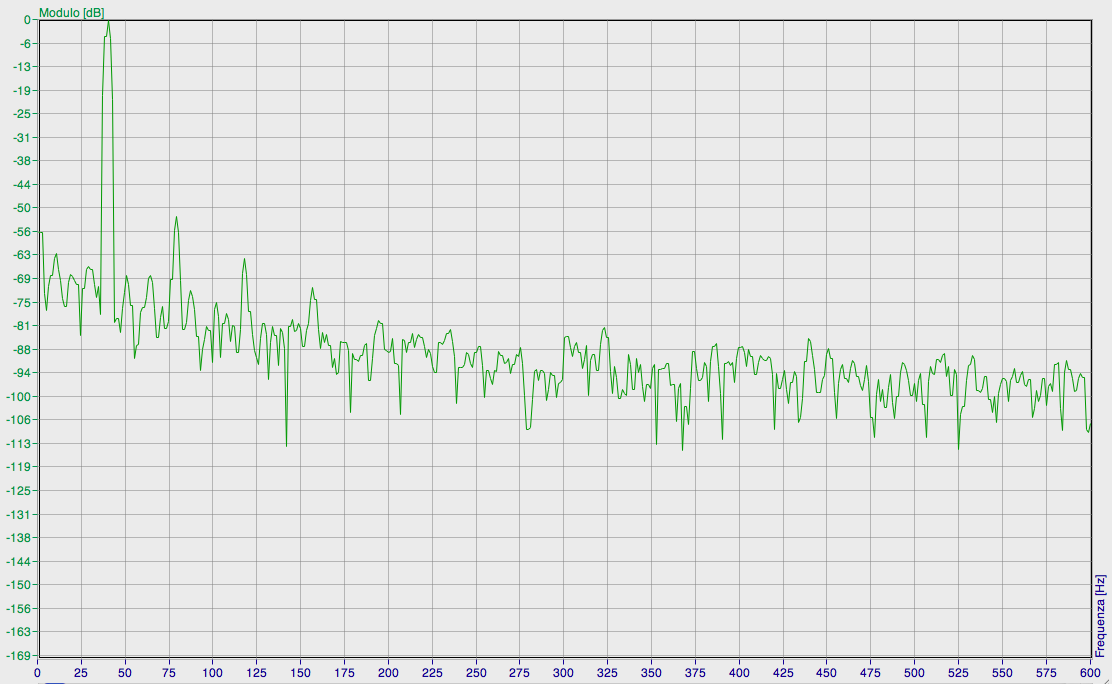
Fig.7: condotto a 39 Hz, basso livello
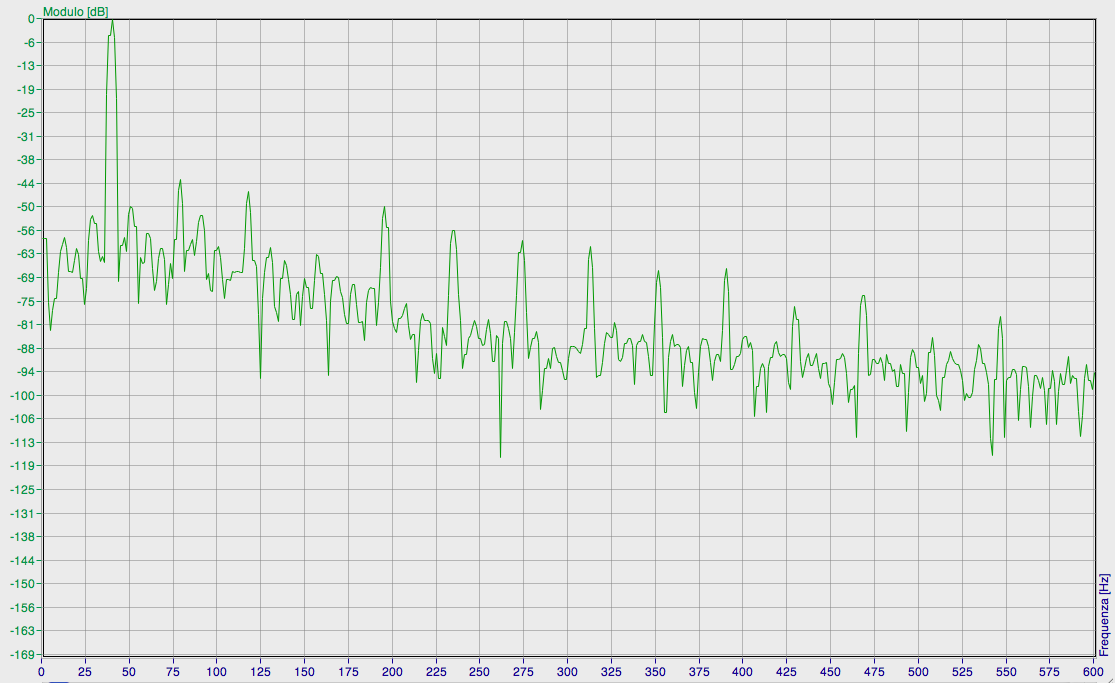
Fig.8: condotto a 39 Hz, livello elevato
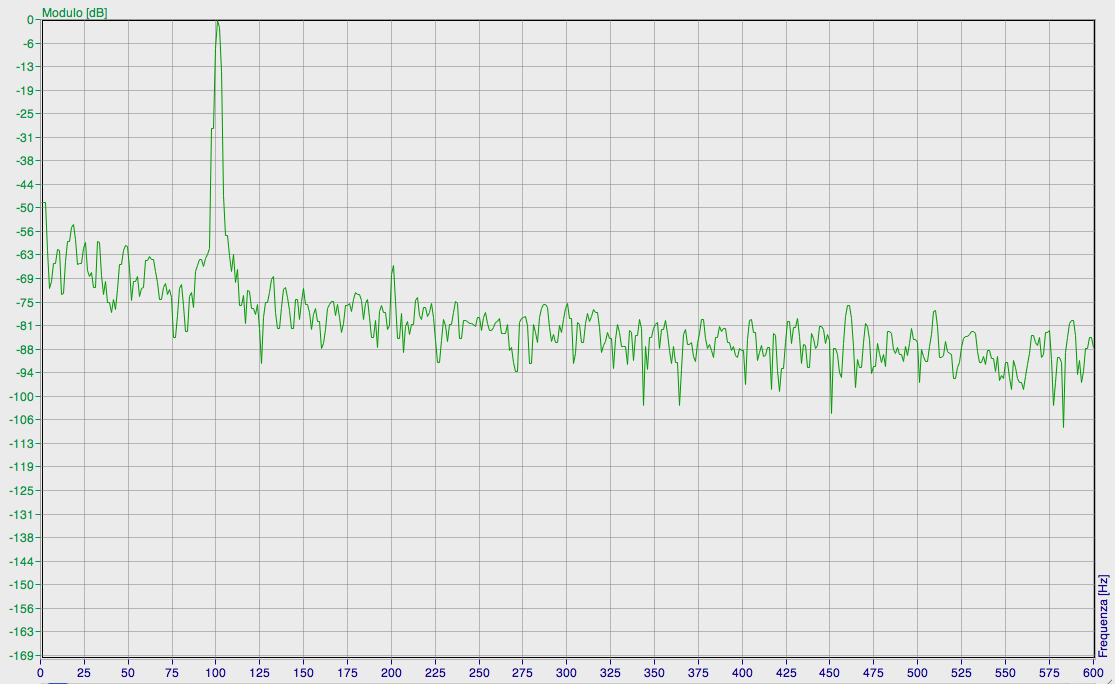
Fig.9: condotto a 100 Hz, basso livello
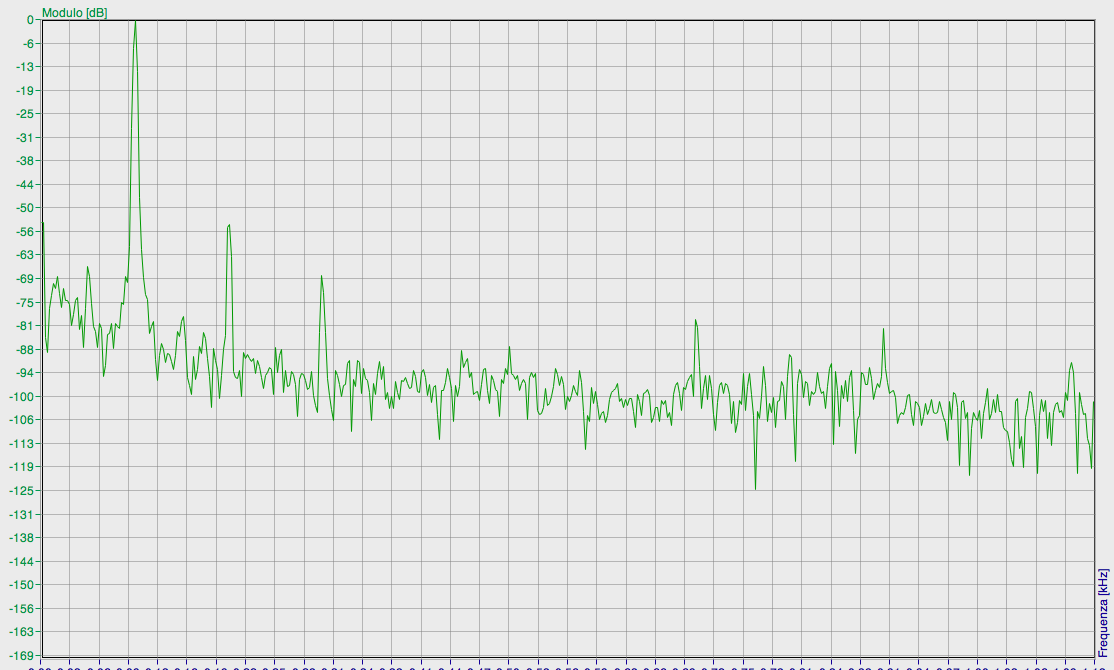
Fig.10: condotto a 100 Hz, livello elevato
Nelle Figure da 11 a 16 le risposte del woofer a 32 Hz, livello basso e alto, quindi a 39 Hz e a 100 Hz.
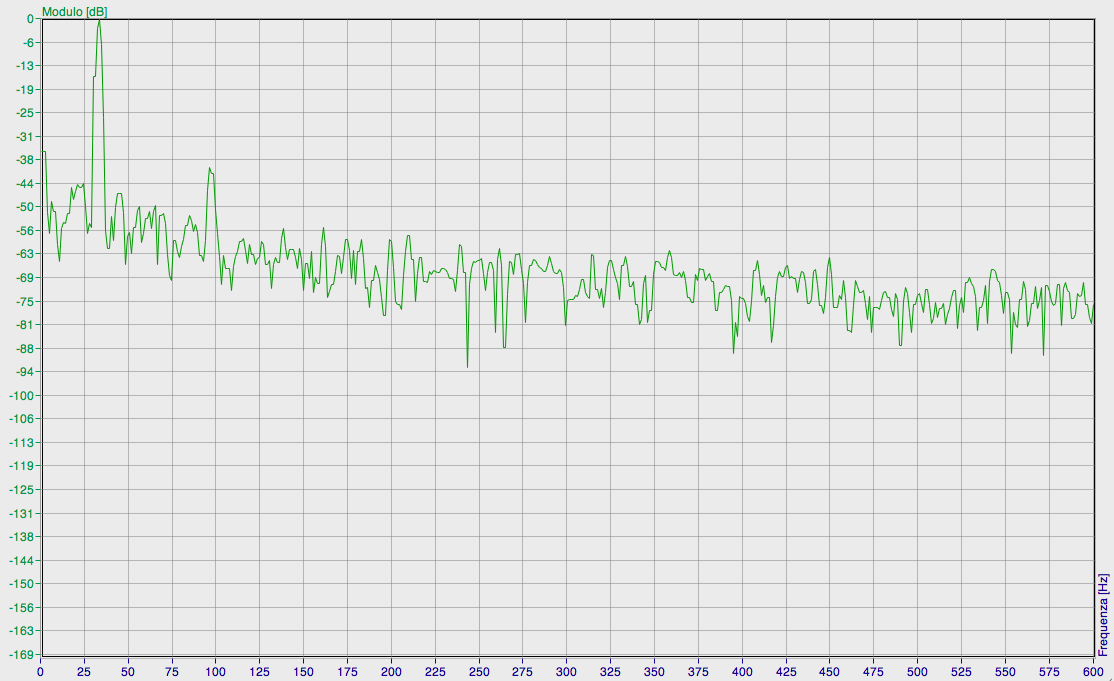
Fig.11: woofer a 32 Hz, basso livello
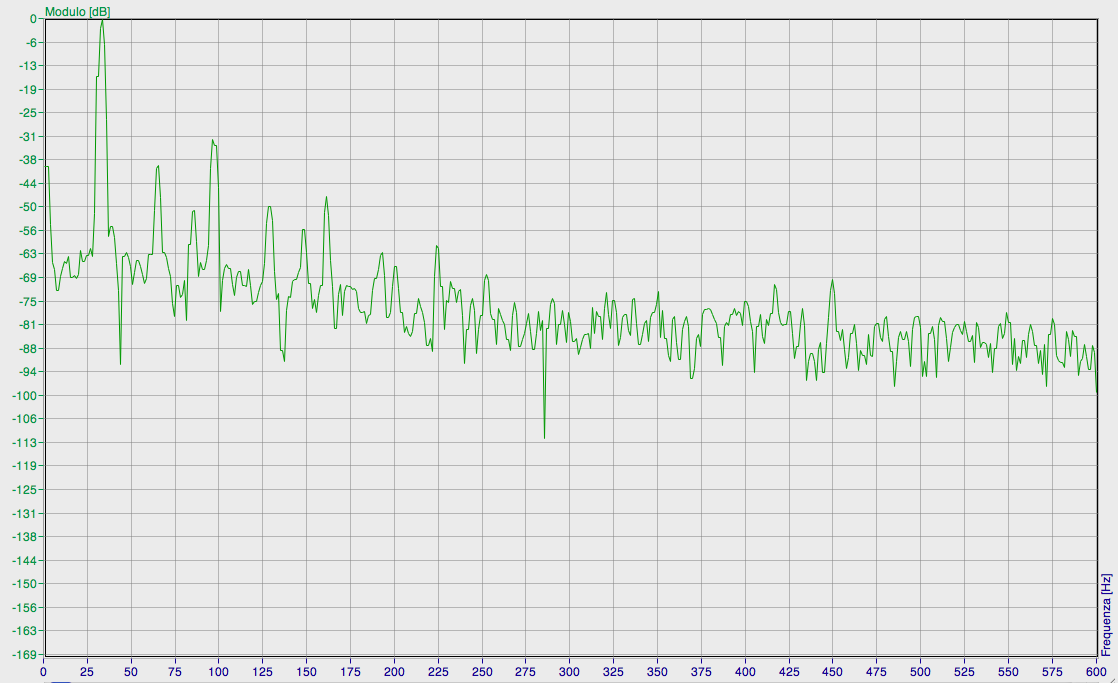
Fig.12: woofer a 32 Hz, livello elevato
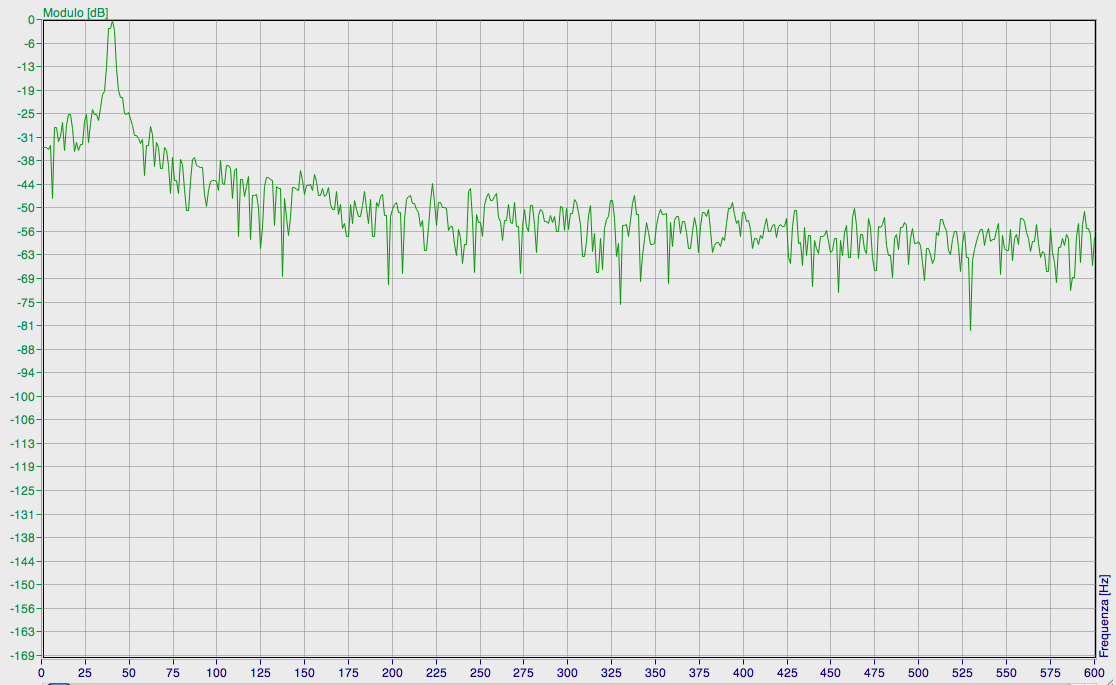
Fig.13: woofer a 39 Hz, basso livello
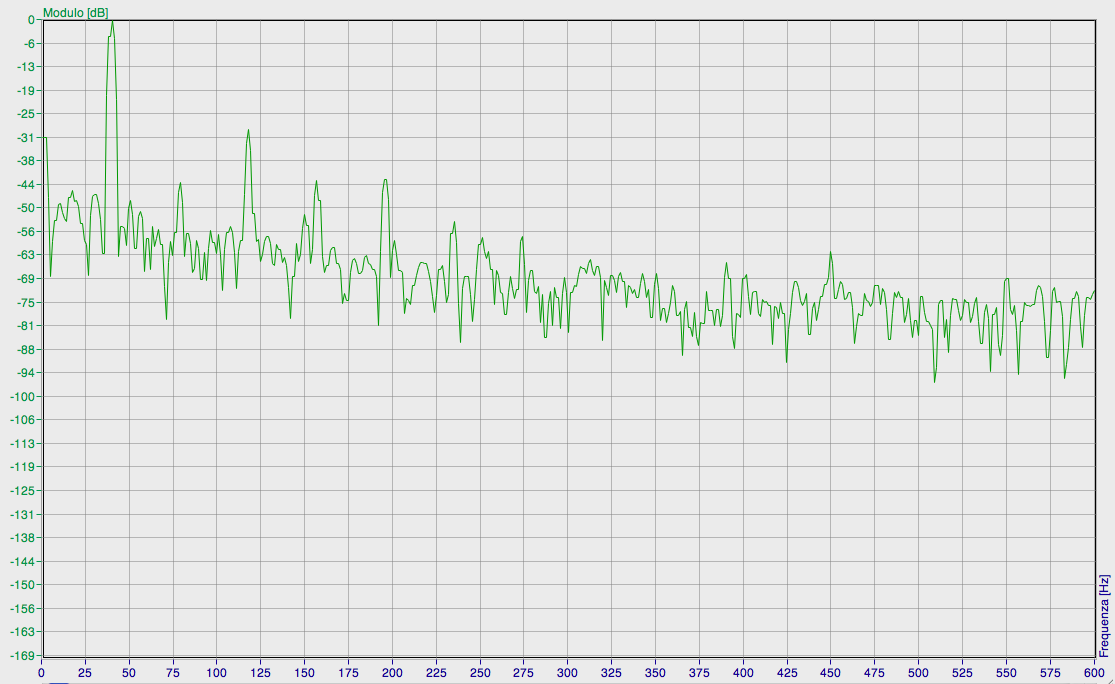
Fig.14: woofer a 39 Hz, livello elevato
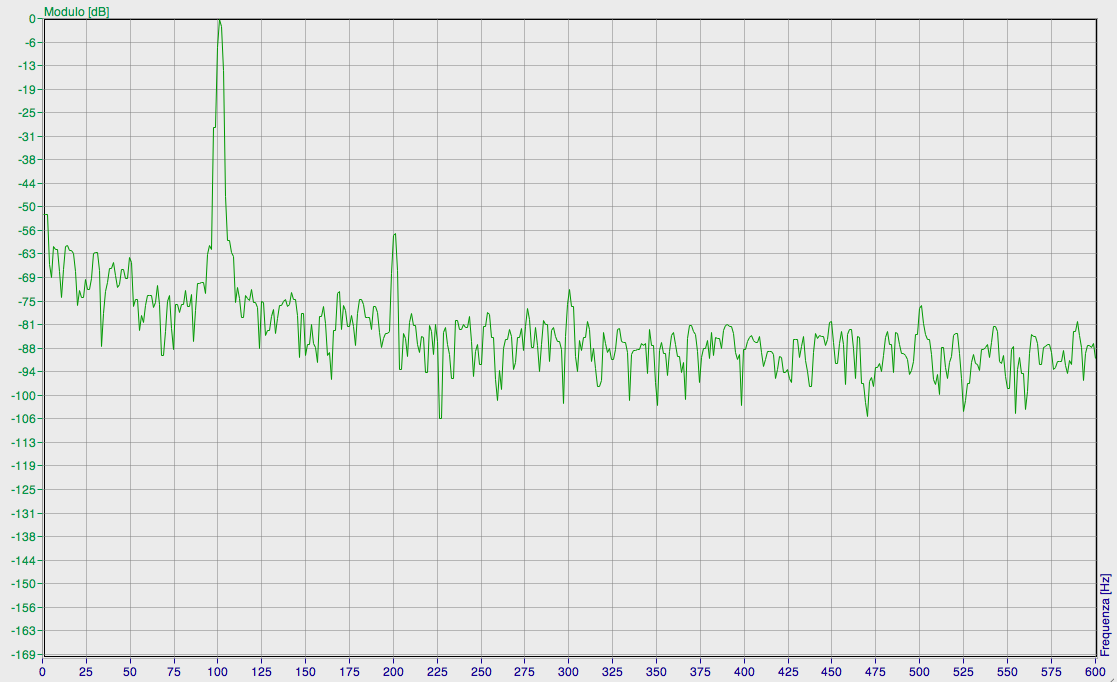
Fig.15: woofer a 100 Hz, basso livello
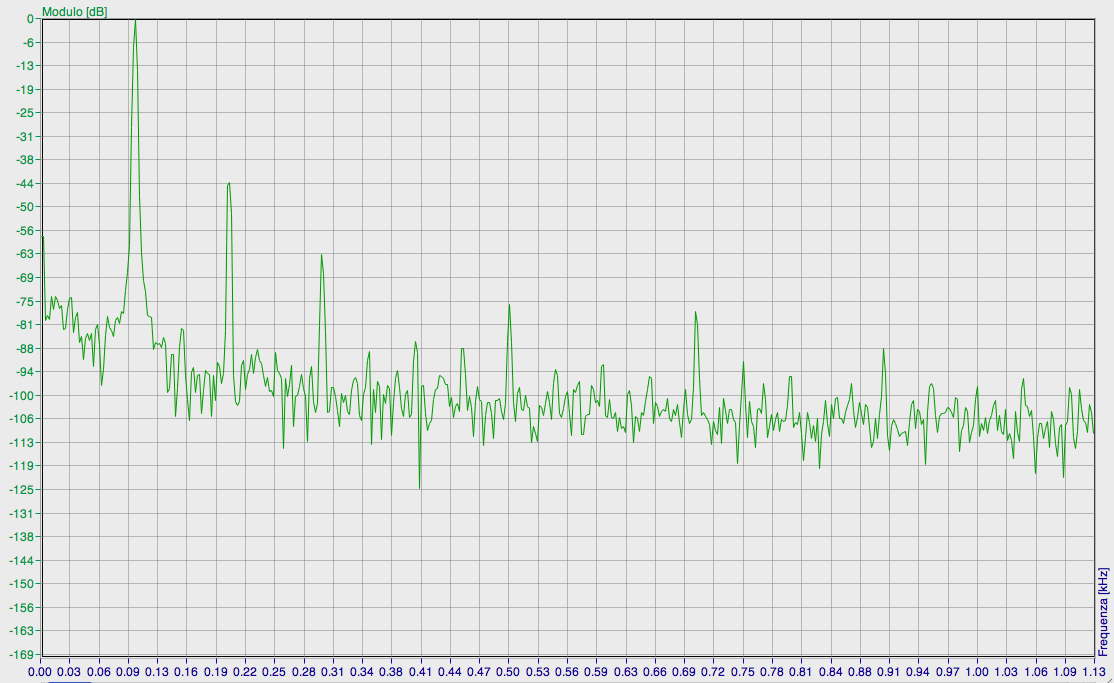
Fig.16: woofer a 100 Hz, livello elevato
Dalle
figure 7 e 13 (misure a basso livello) appare evidente una cosa
già nota, ad ulteriore conferma di quanto appare dalla Fig.1: in
un reflex alla frequenza di accordo l'emissione avviene essenzialmente
dal condotto in quanto la risonanza presenta una impedenza acustica
elevata verso il woofer, la cui escursione tende a zero a quella
frequenza.
In Fig.7, risposta del condotto alla frequenza di accordo, si vede che
il fondo di rumore è molto basso rispetto alla fondamentale e
c'è qualche residuo di distorsione, comunque basso.
In Fig.13, risposta del woofer alla frequenza di accordo, si vede che
il fondo è molto alto rispetto alla fondamentale, significa in
realtà che l'emissione del woofer è molto bassa.
In Fig.14, risposta del woofer alla frequenza di accordo a
livello elevato, si vede che l'emissione, per quanto aumentata,
è comunque ridotta e con distorsione non alta, mentre in
Fig.8, risposta del condotto alla frequenza di accordo a livello
elevato, appare il vero punto debole di un reflex: ad alto
livello la distorsione prodotta dal condotto cresce più che
proporzionalmente al livello, e i prodotti di distorsione sono di
ordine elevato.
La turbolenza si fa sentire e cresce esponenzialmente con il livello sonoro.
Questo
effetto potrebbe essere ridotto aumentando la sezione del condotto, ma
ciò comporterebbe aumentare anche la lunghezza in misura
notevole, e ciò potrebbe essere non compatibile con le
dimensioni fisiche della cassa.
Il condotto potrebbe avere le estremità, verso l'interno e verso
l'esterno della cassa, rastremate con un profilo esponenziale,
complicando in misura molto sostanziosa la costruzione del condotto
stesso.
La turbolenza rimane comunque il problema dei sistemi a condotto, e non è possibile eliminarla del tutto.
Le altre Figure mostrano un andamento tutto sommato regolare sia come
livello che come distorsione, che ovviamente aumenta con il livello ma
non così in misura sensibile come alla frequenza di accordo.
Considerazioni finali
Ovviamente le casse reflex continueranno ad essere prodotte, per tutta una serie di validi motivi.
Innanzitutto l'estensione verso il basso della risposta non è ottenibile con altri sistemi con efficacia pari.
L'estensione verso il basso aumenta comunque l'efficienza globale del
sistema (non la sensibilità globale, ovviamente, che è
determinata essenzialmente dall'altoparlante utilizzato, almeno per i
sistemi a radiazione diretta).
La
diminuzione dell'escursione del woofer nell'intorno della frequenza di
accordo consente una migliore tenuta in potenza nei sistemi dedicati
alla diffusione a basse frequenze ed alte potenze.
Nel programma musicale che non sia hard rock, metal, disco o generi
simili il contenuto a frequenze bassissime non è elevato, ed in
quei generi, con le tecniche di registrazione e soprattutto mixaggio e
mastering attuali la distorsione è il minore dei problemi.
La musica per organo è un caso a parte, in quanto i 16 Hz del
pedale sono difficilmente riproducibili con qualsiasi sistema,
sicuramente non con una cassa chiusa, comunque in un normale o anche
ampio ambiente domestico sono poco percepibili, e comunque nella
riproduzione della musica d'organo la risposta ai transitori non
è una caratteristica qualificante.
|