|
Sensibilità, Efficienza e Potenza
degli altoparlanti
Poche
annotazioni per ridurre la confusione e interpretare correttamente le
specifiche tecniche fornite dai costruttori.
Spesso si usano
indifferentemente i termini sensibilità ed efficienza, e spesso si
utilizzano gli altoparlanti in modo improprio, avendo interpretato le
specifiche tecniche in modo non coerente con i protocolli in base ai
quali le specifiche tecniche sono definite.
Mentre ciò può essere
poco rilevante nel caso di diffusori HiFi, che difficilmente vengono
sollecitati, durante l'uso normale, cioè domestico, ai limiti delle
loro potenzialità, nel caso di utilizzo professionale o musicale la
corretta interpretazione dei parametri tecnici può evitare cattive
sorprese.
Sensibilità
Quando si parla di trasduttori elettroacustici si definisce "sensibilità" la relazione fra il
livello del segnale acustico generato oppure rilevato ed il segnale
elettrico fornito oppure restituito: nel caso di microfoni la sensibilità indica il livello del
segnale elettrico restituito a fronte della pressione acustica
rilevata, nel caso di altoparlanti la sensibilità
indica la pressione acustica restituita a fronte del livello del
segnale elettrico fornito.
Nel caso specifico degli Altoparlanti
la sensibilità si esprime in dB SPL.
SPL
significa Sound Pressure Level, cioè livello di pressione sonora,
misurata rispetto al livello di pressione sonora minima udibile:
ovviamente è una definizione basata su standard, la pressione “minima
udibile” è un livello stabilito una volta per tutte su base statistica.
Dato che l'orecchio ha una risposta non lineare alla pressione
acustica, ed al di sopra di un certo livello la risposta è
approssimativamente logaritmica, la sensibilità è misurata in dB (decibel, cioè decimi di Bell),
che è una misura logaritmica.
Il livello minimo udibile è, per quanto detto prima, fissato in modo
convenzionale tale che
0 dB SPL corrisponde ad una pressione di 0,0002 μ bar
oppure circa 20 μ Pa
(bar e Pa = Pascal sono due unità di
misura per la pressione).
Molto approssimativamente si dice che il ronzio di una zanzara a 3
metri in un ambiente silenzioso corrisponde al livello di 0 dB ( è
ovviamente una indicazione molto approssimativa, non supportata né da
misure né da definizione di standard).
Giusto
per fare alcuni esempi, stabilito questo riferimento standard si può
dire che una officina meccanica in funzione produce un livello di 90 dB
SPL, un martello pneumatico ad 1 metro un livello di 100 dB SPL, un
motore a reazione a 3 metri un livello di 140 dB SPL.
La soglia del dolore è ad un livello di
130 dB SPL.
Un
altoparlante è un trasduttore elettroacustico, cioè un dispositivo che
trasforma un segnale elettrico in un suono.
Se
leggiamo le specifiche tecniche di un altoparlante come quelle che
seguono, che sono ricavate dai cataloghi Eminence, Ciare, Faital (le
specifiche di qualsiasi altra casa sono sostanzialmente identiche),
vediamo che la sensibilità viene espressa come un numero che
esprime la pressione acustica in dB emessa in condizioni predefinite;
nelle stesse specifiche tecniche viene sempre esposta anche la curva
che esprime la pressione acustica generata alle varie frequenze.
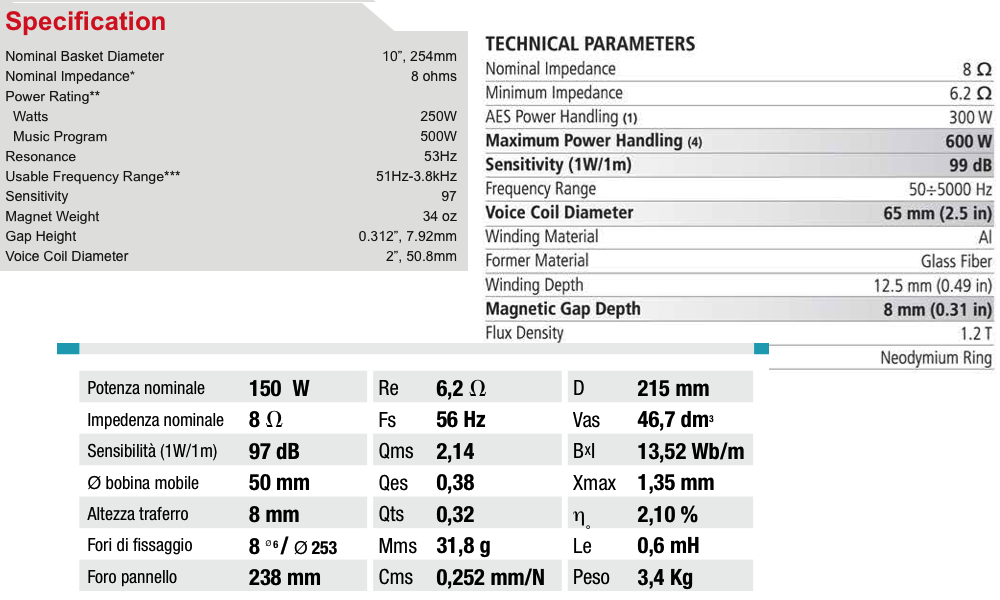
Se si esprime la sensibilità con un numero, la sensibilità misurata ad
una sola frequenza non è significativa, in quanto a seconda delle
caratteristiche dell'altoparlante e delle condizioni di misura, la
pressione acustica non è costante con la frequenza anche se il livello
del segnale è rigorosamente costante.
Ciò appare evidente esaminando la curva della sensibilità ad esempio
del CW251, qui sotto.
Quindi quando si esprime la sensibilità mediante un numero, la
sensibilità è rilevata non con un segnale sinusoidale monofrequenza, ma
con un segnale contenente uno spettro continuo di frequenze adeguate al
tipo di altoparlante.
Generalmente il segnale è un rumore rosa filtrato a frequenza bassa ed
a frequenza alta, per misurare la sensibilità in una gamma di frequenze
che l'altoparlante è in grado di riprodurre.
La sensibilità in questo caso esprime la pressione acustica media che
viene prodotta utilizzando tutta l'energia contenuta nel segnale.
In un segnale con spettro
continuo tutte le frequenze presenti nel segnale contribuiscono a
determinare l'energia elettrica che viene inviata all'altoparlante, ma
è chiaro che tutte le frequenze che l'altoparlante non è in grado di
riprodurre non danno origine a pressione acustica.
Quindi quando la
sensibilità è espressa con un semplice numero deve assolutamente essere
specificato rispetto a quale segnale questa sensibilità è misurata; in
mancanza di questa informazione il numero non è significativo.
L'informazione più
esauriente si ha quando la sensibilità di un altoparlante è
rappresentata da una curva che esprime il livello dB SPL in funzione
della frequenza, rispetto ad un segnale determinato.
L'immagine che
segue mostra la curva di sensibilità del PW251: la useremo come base di
discussione per cercare di chiarire i vari aspetti del problema.
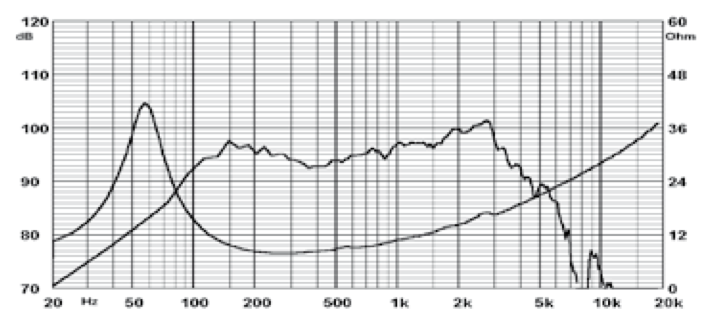
La figura contiene anche la curva di impedenza misurata in aria libera,
ci servirà più avanti.
Quando
si espongono parametri tecnici e misure, questo vale sempre in ambito
tecnico e scientifico, i numeri esposti sono una informazione priva di
significato se non è specificato come viene effettuata la misura.
Vediamo quindi le modalità di misura in
funzione delle caratteristiche misurate.
Regolarità ed estensione
La prima osservazione che si può fare
è che la sensibilità, cioè il livello sonoro prodotto, dipende molto
dalla frequenza e non è affatto regolare: a questo punto bisogna capire
da cosa derivano queste irregolarità, cioè in quale misura le
irregolarità siano una caratteristica propria dell'altoparlante e
quanto le modalità di misura influiscano sulla curva stessa.
Nel
catalogo Ciare da cui la curva è tratta è specificato che questa misura
è rilevata con l'altoparlante montato su pannello IEC.
Altri
altoparlanti sono invece misurati in cassa chiusa, e nell'introduzione
tecnica al catalogo è specificato che il volume della cassa non corrisponde necessariamente al
volume ottimale.
Il
pannello o la cassa servono ad evitare il “cortocircuito acustico” alle
frequenze basse: quando la lunghezza d'onda del suono emesso diventa
paragonabile alle dimensioni dell'altoparlante si crea una interferenza
fra l'emissione anteriore e quella posteriore, che falsa il risultato
della misura.
Il
pannello sposta l'interferenza a frequenze basse, ma non essendo di
dimensioni infinite l'interferenza si colloca comunque a frequenze che
rientrano nella gamma riprodotta; le curve rilevate con pannello IEC
presentano necessariamente un avvallamento fra i 300 ed i 450 Hz ed un
altro, meno pronunciato, fra 600 e 900 Hz: questi avvallamenti non
sono caratteristici dell'altoparlante ma del modo in cui la sensibilità
viene rilevata.
Le
frequenze 300 e 600 Hz e rispettivamente 450 e 900 Hz dipendono dalle
dimensioni del pannello: le frequenze più basse per il pannello
maggiore e le più alte per il pannello minore.
La cassa chiusa elimina totalmente
l'interferenza, ma modifica il comportamento dell'altoparlante.
È quindi evidente che alcune
caratteristiche della curva, in entrambi i casi, non dipendono
dall'altoparlante ma dalle modalità di rilevazione, è quindi importante
sapere come la rilevazione è effettuata, e ciò è sempre indicato nei
fogli delle caratteristiche tecniche.
Per paragone, possiamo confrontare la
curva con quella del PW328,
sempre dal catalogo Ciare, che è rilevata in cassa chiusa.
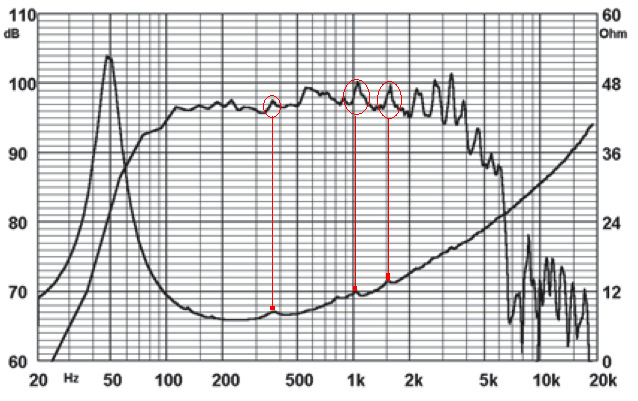
La
curva presenta notevoli irregolarità ad alta frequenza, come quella del
PW251 (tutti i woofer ad alta frequenza si comportano così), il livello
di emissione sulle basse è più elevato in quanto la cassa chiusa
elimina totalmente l'interferenza fra le emissioni anteriore e
posteriore.
La
sensibilità quindi è più costante con la frequenza, ed il valore medio
coincide abbastanza con il dato numerico dichiarato nel catalogo: 98 dB.
Le
irregolarità ad alta frequenza dipendono dal fatto che il cono, che
alle basse frequenze è effettivamente “rigido” (cioè tutte le sue parti
si muovono assieme), alle frequenze alte, cioè quando la lunghezza
d'onda è minore del diametro del cono, non è più veramente rigido.
La
parte vicina alla bobina mobile, che riceve la sollecitazione, si muove
in maniera solidale con la bobina mobile, le parti periferiche (quelle
vicine alla sospensione) non riescono a seguire il movimento della
parte interna, il cono si flette in modi vari che dipendono dalla
frequenza e la risposta diviene irregolare.
Negli
altoparlanti per strumenti queste irregolarità contribuiscono al
“carattere” sonoro dell'altoparlante stesso, mentre nell'uso HiFi o PA
si provvede mediante il crossover a tagliare il segnale a quelle
frequenze cui le irregolarità diventano sensibili.
Si
può osservare che esiste una coincidenza fra le irregolarità nella
risposta e le irregolarità nella curva di impedenza, le più
significative a 370, 1000 e 1500 Hz: le irregolarità nella curva di
impedenza indicano che a quella frequenza il cono cambia "modo" di
vibrazione, si verifica il cosidetto "break up" del diaframma, e il
livello del suono ne risente.
Livello
del segnale di misura
Un
altoparlante è un trasduttore elettroacustico, cioè un dispositivo che
trasforma un segnale elettrico in un suono.
Per un altoparlante quindi è utile conoscere quale livello sonoro
produce quando alimentato con un segnale elettrico di livello
determinato.
La curva di sensibilità, oppure il numero che esprime la Spl, ha senso,
cioè ci fornisce una informazione “vera” ed utile se è chiaro con quale
segnale la rilevazione viene effettuata.
Le modalità correntemente utilizzate
per dichiarare la sensibilità sono due:
con riferimento alla potenza
con riferimento alla tensione
Misura con riferimento alla
potenza
La
rilevazione con riferimento alla potenza è quella più antica, ed è
quella suggerita dall'AES nella specifica AES02-1984-r2003:
AES Recommended Practice- Specifications of loudspeaker components used
in professional audio and sound reinforcement.
La risposta dovrebbe essere misurata con una potenza di 1 W, quindi
“con una tensione ai capi della bobina mobile numericamente pari
a Zmin½ “.
La
maggior parte dei costruttori di altoparlanti segue questa
raccomandazione, ma la tensione applicata è generalmente determinata in
modo più semplice.
Ciare
dichiara, nella introduzione al Catalogo, che la curva è misurata “in
camera anecoica con il microfono di misura posto ad 1 metro di distanza
dall'altoparlante, pilotato con una tensione equivalente ad 1 W di
potenza calcolato sull'impedenza nominale dell'altoparlante”.
Eminence
dichiara nei fogli tecnici che la rilevazione è effettuata “across the
usable frequency range when applying 1W/1m into the nominal impedance.
Ie: 2.83V/8ohms, 4V/16ohms”.
Altre case dichiarano
sinteticamente “1W/1m”.
La
specifica “impedenza nominale” si chiarisce osservando la curva di
impedenza dell'altoparlante: l'altoparlante con una impedenza nominale
di 8 ohm ha una impedenza che in realtà dipende dalla frequenza e varia
da un minimo di circa 8 ohm ad un massimo che può superare i 200 ohm,
nella gamma di frequenza utile.
Definire
una potenza di 1 W ( ricordiamo che W = V^2 / R ) per
misurare una quantità (la sensibilità) che varia con la frequenza,
quando il carico (l'impedenza dell'altoparlante) non è costante con la
frequenza non è molto significativo in quanto si dovrebbe alimentare un
altoparlante con una tensione variabile con la frequenza in funzione
dell'impedenza, ed è inutile ai fini della valutazione del trasduttore
(è a questo scopo che sono stati definiti i Parametri tecnici e gli
standard di misura, per ottenere dati confrontabili in quanto ottenuti
in condizioni note e riproducibili); in altri termini la Potenza non è un riferimento univoco quando
il carico ha un comportamento non costante e varia con la frequenza in
modo “arbitrario”.
Ed anche la potenza degli amplificatori
viene definita su carico resistivo, cioè costante con la frequenza.
Pertanto
si effettua la misura con un segnale la cui tensione RMS è quella che
darebbe una potenza di 1 W su una resistenza pura (che è indipendente
dalla frequenza) di valore pari all'impedenza nominale
dell'altoparlante.
Quindi
un altoparlante da 8 ohm viene misurato con una tensione di 2,83 V,
mentre un altoparlante da 4 ohm viene misurato con una tensione di 2 V
ed un altoparlante da 16 ohm viene misurato con una tensione di 4
V.
Misura
con riferimento alla tensione
Alcuni produttori di
altoparlanti dichiarano la sensibilità con riferimento ad una tensione
fissa, che è nella totalità dei casi 2,83 V RMS, qualsiasi sia
l'impedenza nominale dell'altoparlante.
I due metodi sono perfettamente
equivalenti, purché sia chiaro quale metodo viene usato.
Infatti 2,83 V RMS
equivalgono ad una potenza di 1 W su 8 ohm, ad una potenza di 2 W su 4
ohm e ad una potenza di 1/2 W su 16 ohm.
La sensibilità rilevata così
per un altoparlante da 4 ohm è quindi numericamente superiore di 3 dB
alla sensibilità rilevata con riferimento alla potenza.
Come
viene misurata la sensibilità è una informazione importante, perché
consente di paragonare altoparlanti diversi e consente anche di
valutare le informazioni fornite dai simulatori.
Ad
esempio il simulatore BASS-PC ed altri simulatori calcolano la
sensibilità con un segnale di 2,83 V RMS, indipendentemente
dall'impedenza nominale dell'altoparlante; AFW (Audio for Windows)
fornisce entrambi i dati: a 1W/1m e a 2,83V/1m.
Dato che questo è dichiarato esplicitamente nella schermata del
calcolo, ciò non costituisce assolutamente un problema, nel caso venga
fornito solo il dato riferito alla tensione basta sapere che se si
vogliono confrontare un altoparlante da 8 ohm ed uno da 4 ohm, si
debbono sottrarre 3 dB alla sensibilità risultante per l'altoparlante
da 4 ohm.
La misura con riferimento alla potenza è la più antica, nata quando gli
amplificatori erano prevalentemente a valvole, in quanto un
amplificatore a valvole, con trasformatore di uscita, è un generatore
di potenza, e dispone di prese di uscita con impedenza diversa cui
collegare gli altoparlanti.
La misura con riferimento alla tensione è invece adeguata agli
amplificatori a stato solido, che sono essenzialmente dei generatori di
tensione, ed erogano potenza in funzione dell'impedenza del carico,
entro i limiti costruttivi dell'amplificatore.
Condizioni di misura
La
misura di sensibilità a basse frequenze è significativa se si elimina
il cortocircuito acustico fra l'emissione anteriore e posteriore.
L'eliminazione totale si ha solo con uno schermo infinito, che non è
fisicamente realizzabile, quindi i costruttori utilizzano modalità di
misura differenti, specificando nei fogli tecnici le modalità effettive.
Un metodo ampiamente usato è il
Pannello Standard IEC (IEC 268-5, 1972):

Lo
standard è stato stabilito da IEC per altoparlanti da 8” (20 cm) nel
1972, ed accolto da AES nella raccomandazione AES02-1984-r2003:
AES Recommended Practice- Specifications of loudspeaker components used
in professional audio and sound reinforcement nella quale
determina le misure A, B, C, D per i diametri più comuni degli
altoparlanti.
Con un pannello di
dimensioni finite la cancellazione avviene al di sotto di una frequenza
che dipende dalla distanza dell'altoparlante dal bordo: nel pannello
IEC l'altoparlante è montato in posizione decentrata affinché la
distanza dell'altoparlante dai bordi esterni non sia costante.AES suggerisce di ricavare le
dimensioni per altoparlanti con diametro diverso da 8” scalando
proporzionalmente le dimensioni del pannello IEC 268-5, ricavando la
Tabella Tab2.1.
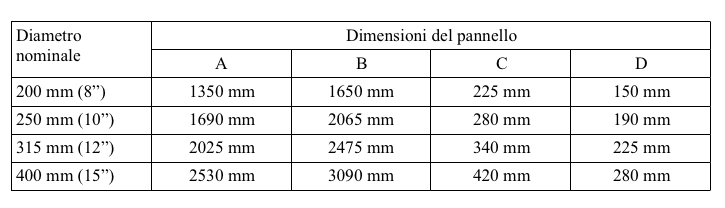
Ciare
dichiara che la curva è misurata “in camera anecoica su pannello IEC”,
mentre Eminence dichiara che “ baffle is built into the wall with the
speaker mounted flush against a steel ring for minimum diffraction“,
condizione che approssima meglio lo schermo infinito.
È comunque vero
che nessuna camera anecoica reale è veramente anecoica al di sotto di
frequenze basse ma non bassissime, sia a causa delle dimensioni della
camera sia perché l'efficacia dei materiali fonoassorbenti diminuisce
con la frequenza, quindi la sensibilità di qualsiasi altoparlante è
difficilmente misurabile con precisione al di sotto di frequenze non
bassissime.
Si
può ritenere che, a meno di camere anecoiche di dimensioni tali da
essere assolutamente antieconomiche, la misura della risposta sia
precisa al di sopra di 150 – 200 Hz.
Efficienza
L'efficienza si definisce come rapporto fra la potenza acustica resa e la potenza elettrica fornita: essendo
un rapporto fra potenze, quindi fra grandezze omogenee, l'efficienza è
un numero adimensionale (un numero puro).
La potenza acustica si misura in
Watt acustici, la potenza elettrica si misura in Watt elettrici.
Questa
in realtà è una definizione teorica o nominale, in quanto la potenza
elettrica realmente fornita all'altoparlante è difficilmente
definibile, come si è visto in relazione alla sensibilità.
Pochi fabbricanti dichiarano
l'efficienza, nei fogli tecnici Ciare è identificata dal
simbolo η° .
L'efficienza
è un valore calcolato in base ai parametri dell'altoparlante,
secondo la formula che segue (è un'ottima approssimazione):
η°
= 4π^2 * Fs^3 * Vas / c^3 * Qes
( c è la velocità del
suono)
L'efficienza
tipica di un altoparlante professionale può essere compresa fra il 2%
ed il 5%, l'efficienza di un altoparlante HiFi è generalmente
inferiore; uno dei fattori che influenzano l'efficienza è il diametro
(maggiore è il diametro maggiore è l'efficienza).
Questi valori di efficienza
significano che su 100 W forniti ad un altoparlante ne vengono
trasformati in energia acustica fra 2 e 5, tutto il resto (cioè fra 98
e 95 W) viene trasformato in calore, quindi perso.
Il problema più grosso degli
altoparlanti professionali è proprio la dissipazione del calore
prodotto: oggi sono di uso comune nel settore professionale
altoparlanti con potenze dichiarate di 1000 W, dei quali 950 o più se
ne vanno in calore, praticamente una stufetta elettrica.
Relazione fra Sensibilità ed
Efficienza.
L'efficienza
espressa secondo la definizione classica non fa riferimento ad alcun
livello di potenza predefinito, in elettroacustica sono invece stati
definiti standard di riferimento per i livelli, come si è già visto per
la pressione acustica.
Per la potenza acustica il riferimento
di 0 dB è stato stabilito a 10 -12 Watt acustici, e 1 W acustico
significa 120 dB.
In realtà la potenza acustica non si
misura ma si calcola, ciò che si misura è la pressione acustica.
La
misura si intende effettuata in un semispazio, cioè in 2π radianti, che
ad 1 m significa la distribuzione di potenza su una superficie pari a
2π, equivalente a -8 dB.
Pertanto
a 1 m una efficienza del 100% comporterebbe una sensibilità pari a 120
– 8 = 112 dB (nel caso di irradiazione non direzionale, quindi a
frequenze basse).
Si ha quindi:
Sensibilità in dB
SPL = 112 + 10 log
(efficienza)
Da
questa formula di conversione si ricava che un altoparlante con
efficienza pari al 100% ha sensibilità (a 1W/1m) pari a 112 dB
(infatti log( 1 ) = 0), ed un altoparlante con
efficienza pari al 3,27% (l'altoparlante di Fig.2.1b) ha sensibilità (a
1W/1m) pari a 97,1 dB, che mostra un buon accordo con la
sensibilità dichiarata di 98 dB.
Sulla
base di questa conversione è divenuto di uso corrente in
elettroacustica definire l'efficienza in dB, misurando la sensibilità a
1W/1m.
È ovvio che la sensibilità di un
altoparlante è legata all'efficienza: maggiore è l'energia acustica
emessa ( = più efficienza) maggiore è il livello sonoro ( =
maggiore sensibilità), a parità di energia elettrica fornita.
I due parametri però sono concettualmente diversi, e
alla fine ci dicono due cose diverse, anche se correlate: l'efficienza
ci dice quanta potenza elettrica viene convertita in energia sonora,
quindi analogamente quanta energia elettrica si spreca, la sensibilità
ci dice quanto suono si produce.
Però
ciò che è veramente importante è la curva di risposta:
due altoparlanti caratterizzati dallo stesso valore numerico di
efficienza potrebbero avere un comportamento molto diverso in funzione
della frequenza: ad esempio uno potrebbe avere una curva di sensibilità
che sale verso le alte e un altro una curva di sensibilità che
scende, e quindi suonare in modo diverso e a seconda
dell'utilizzo potrebbero produrre un diverso volume di suono.
Un fatto importante da tenere presente
è che la presenza della cassa influenza la sensibilità solo nella gamma
di frequenza bassa, (mediamente fino a 300 Hz, dipende dal diametro del
cono), mentre oltre questa frequenza, (che, ripeto, dipende in realtà
dal diametro del cono) la sensibilità non è influenzata dalla presenza
della cassa.
Esempio concreto
Facciamo un esempio concreto, basato
su due altoparlanti reali, per chiarire meglio cosa significano queste
informazioni e come utilizzarle al meglio.
Prendiamo due esempi dal catalogo
Ciare 2010.2011: il PW320, un altoparlante presente in catalogo da
qualche anno, ed il PW321, una new entry.
Ecco le specifiche funzionali:

La serie di simboli sotto il disegno tecnico specifica alcuni parametri
tecnici e di utilizzo: il PW320 è indicato per la chitarra,
mentre il PW321 è indicato per basso (anche se la descrizione dice il
contrario, i simboli danno la destinazione vera).
Il simbolo accanto alle curve ci dice
che entrambi sono misurati su Pannello IEC: questo rende il confronto
quasi immediato.
I due altoparlanti dichiarano una
sensibilità di 98-99 dB entrambi, ma le due curve di sensibilità sono
molto diverse.
Per comodità di analisi ho riportato
le curve di sensibilità sulla stessa scala (disegnate a mano su carta
logaritmica, come si usava quando io ero giovane):
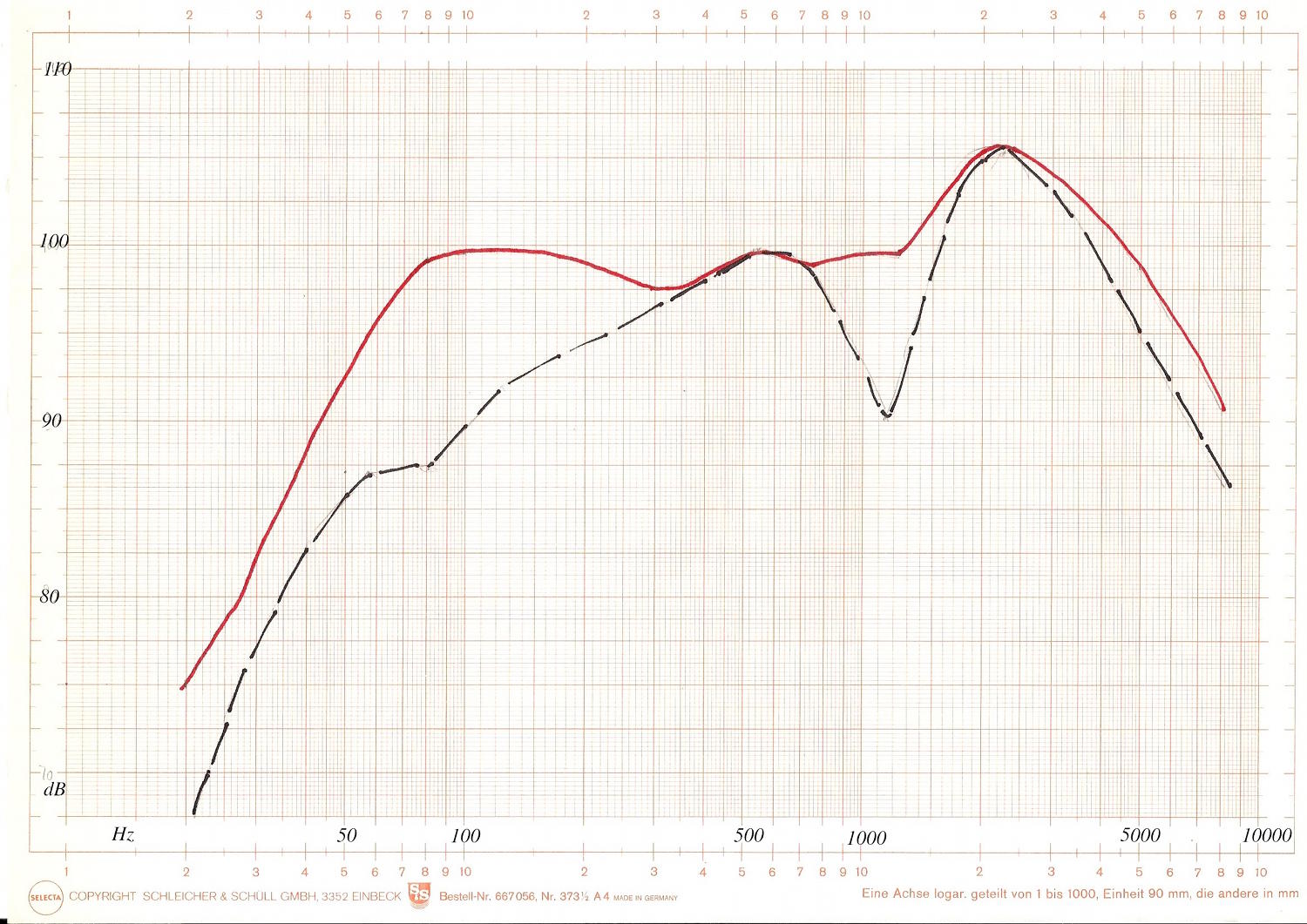
In rosso il PW321, in nero il PW320.
La sensibilità massima è la stessa per
entrambi, ed è raggiunta attorno ai 2200 Hz, ma il comportamento a
bassa frequenza chiarisce la destinazione d'uso.
È importante notare che la curva del
PW321 sta mediamente più in alto, ed a basse frequenze la sensibilità è
circa 10 dB maggiore, e quindi la superficie racchiusa dalle due curve
è molto diversa: infatti il PW321 ha una efficienza = 3,88%, mentre il
PW320 ha un più ridotto 2,25%.
Per concludere, anche l'escursione
massima chiarisce la destinazione: per il PW321 Xmax = 3,5 mm, mentre
per il PW320 Xmax = 1,25 mm.
Potenza
Concludo con alcune note sulla potenza
degli altoparlanti, importanti per capire come interpretare i numeri
che compaiono sui cataloghi (e quindi non distruggere un prezioso
componente per una errata interpretazione di un numero allettante).
Innanzi tutto è importante capire che
cosa significa il numero in W
della potenza di un altoparlante.
Un altoparlante è un trasduttore fatto
per tradurre in suono un segnale elettrico derivante da una sorgente
musicale: gli altoparlanti non sono
progettati per riprodurre segnali sinusoidali continui (cioè
segnali composti da una sola frequenza pura).
Quindi la potenza di un altoparlante
viene dichiarata in funzione di un segnale simile al segnale musicale.
È ovviamente impossibile definire in
numeri un segnale musicale reale qualsiasi, ma in linea di massima un
segnale musicale “normale”, cioè il segnale complessivo che deriva da
un evento musicale come un concerto, è un segnale composto da strumenti
molto diversi fra loro, sia come gamma di frequenza emessa sia come
intensità di suono.
Il segnale musicale più completo è
quello prodotto da una grande orchestra, che comprenda tutti gli
strumenti, dalla grancassa al triangolo passando per timpani,
contrabbassi, controfagotti, violoncelli, tromboni, trombe, violini.
Dato che una misura ha senso, cioè
comunica informazioni utili, solo se è chiaro in quali condizioni è
stata eseguita, si deve definire un “surrogato” di segnale musicale
standard, che sia ragionevolmente assimilabile ad un segnale musicale
medio, quale quello della grande orchestra, ma che sia definibile
matematicamente in modo univoco ed inequivocabile.
Anche qui la documentazione tecnica
Ciare ci viene in aiuto (*): dalla documentazione del 12.75 W1, un
woofer della serie Pro-Audio (prodotto destinato all'industria)
ricaviamo (**)
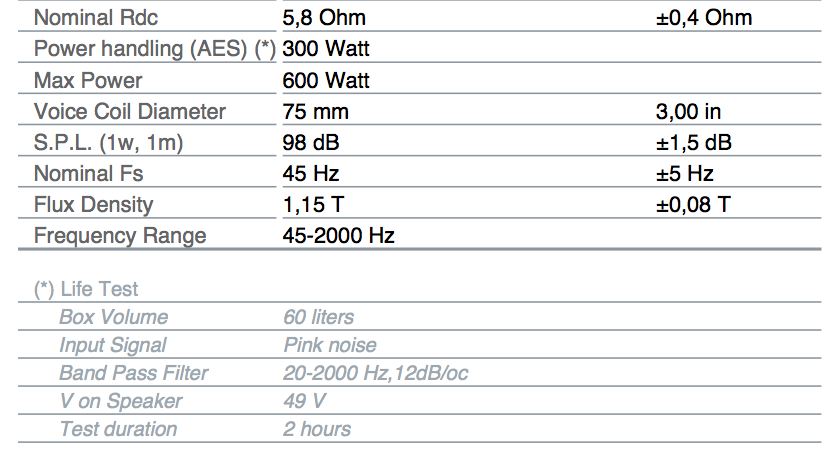
La documentazione specifica: “Power Handling (AES)”; il termine AES tra
parentesi significa che sono rispettati i protocolli standard della
Audio Engineering Society, quindi si parla di Potenza continua.
Esistono
raccomandazioni differenti per la misura della potenza degli
altoparlanti, al di là delle differenze specifiche lo scopo di ogni
raccomandazione è di rendere confrontabili altoparlanti diversi.
La
raccomandazione AES02-1984-r2003 suggerisce di misurare la potenza degli
altoparlanti in aria libera, applicando un segnale composto da rumore
rosa con fattore di cresta pari a 6 dB, con larghezza di banda pari ad
una decade a partire dalla frequenza utile più bassa specificata dal
produttore; i filtri sono a 12 dB/ottava con andamento Butterworth.
La
specifica Ciare è più impegnativa della raccomandazione: la nota dice
che la misura è eseguita con altoparlante in box di 60 litri, che il
segnale è costituito da rumore rosa filtrato a 12dB/ottava a 20 Hz e 2000
Hz, quindi per due
decadi, e la tensione efficace ai capi dell'altoparlante è 49V.
L'informazione fondamentale è che il
segnale è un rumore rosa, filtrato.
Il rumore rosa è un segnale composto
da tutte le frequenze (per questo è definito rumore e non suono) ed il
livello elettrico delle componenti di frequenza diversa decresce di
3dB/ottava.
La caratteristica fondamentale del
rumore rosa è che l'energia è costante per ogni ottava, cioè il segnale
contiene nella gamma fra 100 e 200 Hz la stessa
energia totale che contiene ad esempio nella gamma fra 1000 e 2000 Hz.
Il rumore rosa è una ragionevole
approssimazione del segnale musicale dell'orchestra, ed è perfettamente
definito: ogni generatore di segnali permette di generare onde
sinusoidali, quadre, triangolari, rumore rosa e rumore bianco.
La seconda informazione importante è
che il segnale è filtrato a 20 Hz e a 2000 Hz: il limite inferiore
significa in pratica che l'altoparlante non deve essere alimentato in
corrente continua, il limite superiore significa che è un woofer,
quindi non deve essere alimentato da alte frequenze con potenze elevate.
La specifica dei 49 V ci dice la
stessa cosa che ci diceva la specifica della misura della sensibilità:
49 V sono esattamente 300 W su un carico resistivo di 8 ohm;
l'altoparlante non è un carico resistivo quindi l'unico dato
inequivocabile è la tensione, non la potenza.
Per capire a cosa servono queste
informazioni bisogna capire come è fatta una bobina mobile.
Qui vediamo la bobina mobile da 100 mm
di diametro di un subwoofer da 18”, a doppia bobina, certificato per
600 + 600 W:
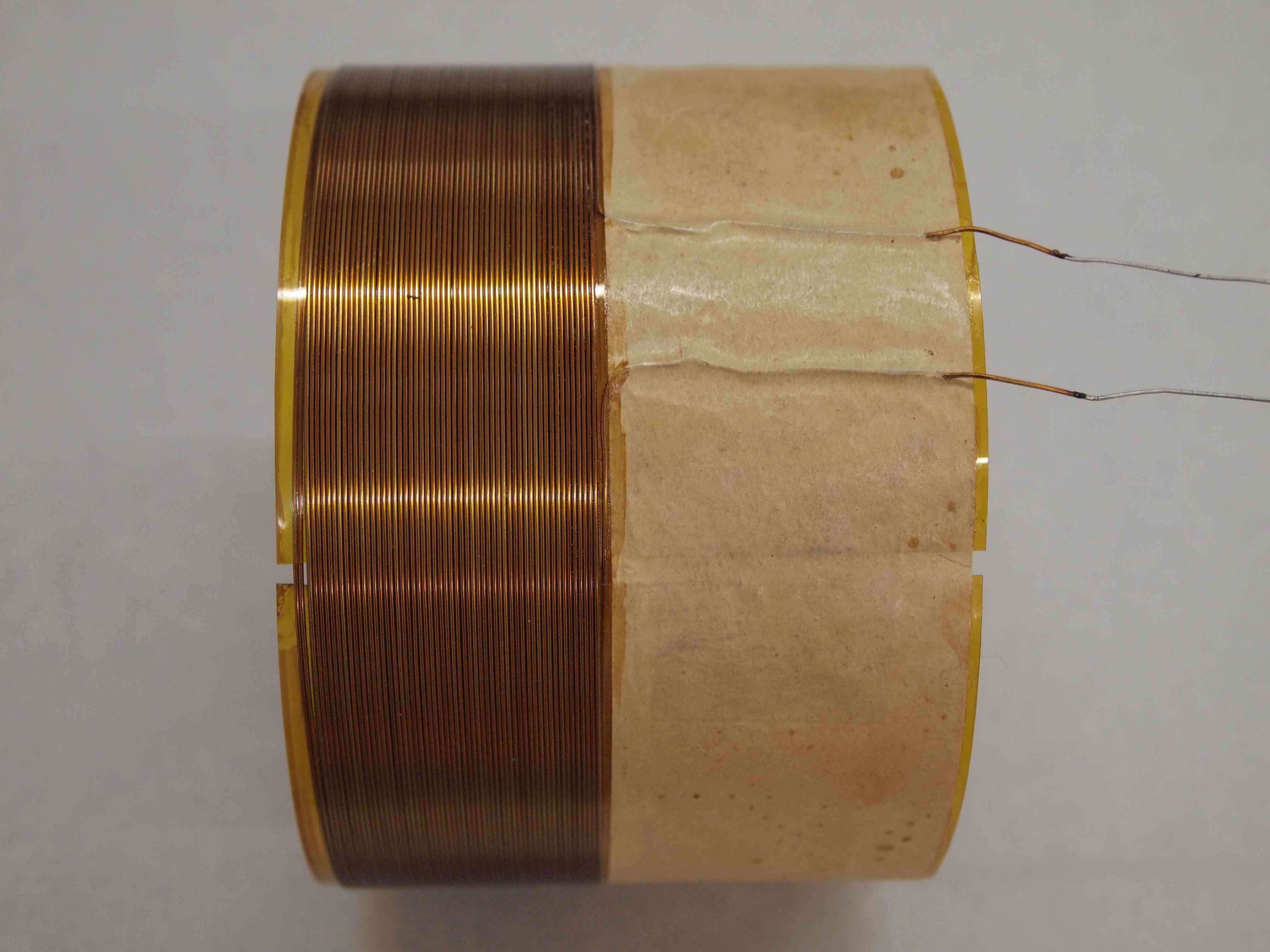
Il filo di rame di cui è costituita la bobina ha un diametro di 0,42
mm, cioè una sezione di 0,14 mm2 , 600 W significa che vi può scorrere
una corrente di 8 (otto) Ampere.
Come abbiamo visto al punto
dell'efficienza, circa 570 W di questi 600 se ne vanno in calore.
In pratica un tostapane domestico, le
cui resistenze diventano rosse e raggiungono temperature di centinaia
di gradi.
Com'è che questo filo (che ha una
sezione di soli 0,14 mm2) non fonde? E comunque, a parte la fusione del
rame, il problema vero è costituito dalla vernice isolante e dagli
adesivi che tengono assieme la bobina mobile, che non resisterebbero ad
una temperature superiore a circa 160° - 180°.
La bobina mobile non brucia nell'uso
normale in quanto la bobina mobile è in costante movimento, quindi
viene raffreddata dall'aria (che trasmette il calore all'ambiente
circostante ed alle parti metalliche dell'altoparlante stesso, che
quindi lo disperdono a loro volta nell'ambiente: è una delle ragioni
per cui i cestelli sono in alluminio e verniciati in nero opaco).
Il movimento del cono è il motivo per
cui il segnale è filtrato: il woofer deve essere alimentato con
frequenze che permettano al cono di essere in costante movimento,
quindi non si può alimentare con frequenze che non è in grado di
riprodurre.
Con una corrente continua il cono sta
fermo perché è continua, con un segnale di 5 kHz sta fermo in quanto
l'equipaggio mobile ha una massa troppo elevata per muoversi
significativamente a quella frequenza.
Il fatto che la misura è eseguita con
rumore rosa significa che i 300 W sono validi se il segnale è
costituito da una miscela uniforme di tutte le frequenze,
specificamente quelle in grado di fare muovere il cono.
Un segnale monofrequenza a 2000 Hz e
300 W distruggerebbe comunque la bobina mobile.
Un segnale
monofrequenza a 10 Hz a 300 W per un tempo
sufficientemente lungo avrebbe lo stesso risultato.
Un amplificatore a stato solido da 200
W in clipping spinto può produrre fino ad un massimo teorico di 200 W
di frequenze elevate, sopra la fondamentale del segnale clippato, e
quindi sicuramente può distruggere la bobina mobile.
Bastano meno di 100 W di segnale
qualsiasi, se il cono è fermo, per distruggere quella bobina mobile.
Conclusioni
Le specifiche tecniche ci forniscono
numeri, che debbono essere interpretati: i numeri da soli non servono a
nulla.
Quando si leggono i fogli tecnici dei
componenti le annotazioni, le premesse, le note a fondo pagina sono
come le clausole scritte in caratteri piccoli nelle polizze
assicurative: sono più importanti del contenuto scritto in chiaro.
I documenti tecnici seri hanno
all'inizio oppure alla fine una spiegazione dettagliata di tutti i
termini e tutti i simboli usati nel corpo della documentazione, e la
spiegazione delle modalità di misura oppure il riferimento agli
standard industriali utilizzati.
(*) Tutte le case dichiarano le modalità della misura: ad es. Eighteen
Sound dice che la misura è eseguita con rumore rosa, Eminence fa
riferimento a protocolli standard, Sica specifica che la misura è
eseguita con rumore rosa con un fattore di cresta di 6 dB (equivale più
o meno a dire che è filtrato).
(**) È anche interessante notare che nel prodotto destinato
all'industria vengono dichiarate anche le tolleranze di produzione: i
parametro significativi possono variare per lo stesso modello, fra il
5% e il 10% in più o in meno del valore nominale.
Questo per dire quanto poco “smart” sia incaponirsi sui decimali quando
si usano i simulatori.
|

