 |
|
|
|
Cassa 12" per basso
|
|
|

|
Dopo
l’amplificatore “da studio” il logico
complemento è una cassa.
Perché non ho pensato ad un combo? Data la bassa potenza
sarebbe stata la soluzione più immediata, secondo la
tradizione.
Io però non ho simpatia per i combo. Li trovo scarsamente
flessibili: una volta che ce l’hai, te lo tieni
così; al massimo, se è previsto ci puoi mettere
in parallelo un’altra cassa, ma a mio parere questa
è una soluzione di ripiego usata nei
“combetti” commerciali dove per ragioni di costo il
cono è generalmente sottodimensionato (soprattutto nei combo
per basso) e/o di bassa qualità (ora qualcuno si
arrabbia…. ma io la penso così, e potrei fare
anche qualche misura su quei combo, se non fosse una perdita di tempo).
Poi, se per suonare in maniera decente ci devi attaccare
un’altra cassa, dove va la comodità del combo?
(sui combo per chitarra la questione è completamente
diversa, la chitarra emette dagli 80 Hz in su, e qualsiasi
10” lavora benissimo a queste frequenze, anche un
8” va benissimo).
|
|
|
|
|
Poi
la questione tecnica: immaginatevi di sottoporre la vostra amata (e
costosa) KT88 (non che le altre valvole si divertano) a vibrazioni a 41
Hz (il Mi) di ampiezza non trascurabile…
Con ampli a stato solido ovviamente il problema non si pone
(forse…)
E se poi volete cambiare amplificatore?
Quindi una cassa separata.�
|
|
|
|
Criteri e scelte di progetto
|
|
|
|
|
12”
perché per me è il minimo per suonare bene il
basso (come sempre è questione di gusti), l’ideale
sarebbe un 15” accompagnato da un extended range da
8” o 10” opportunamente filtrato ma per un ampli da
15W sarebbe stato un po’ troppo.
Bass reflex per scendere in frequenza: un accordo attorno ai 45 Hz, ben
smorzato, garantisce una buona riproduzione fino al Mi di cui sopra.
|
|
|
|
Scelta del cono.
Decisi i criteri di progetto (che mi sono venuti automatici dopo non
poche discussioni con alcuni amici bassisti) via alla ricerca del cono
adatto e quindi alla progettazione della cassa.
La scelta del cono è stata effettuata spulciando i cataloghi
Eminence e Ciare (giusto per restare su costruttori noti e i cui
prodotti siano reperibili facilmente) ed effettuando una serie di
simulazioni con i coni da 12” della serie per Basso di
Eminence e professionali di Ciare.
La prima serie di simulazioni è stata eseguita cercando il
cono che mi desse i migliori risultati in un accordo standard semplice,
QB3 n.4, che dà una risposta più smorzata anche
se meno estesa del B4.
Il “ginocchio” è più dolce e,
se pure la frequenza di taglio è più alta, sotto
la frequenza di taglio la pendenza della curva di risposta è
minore dei classici 24 dB/ott per cui a frequenze più basse
la risposta è di fatto più estesa e soprattutto
promette bassi più puliti e non il classico boom boom boom
che potrete gustare (si fa per dire, tutti i gusti son gusti) ogni
volta che vi avventurate nei settori HiFi (ci vuole coraggio e faccia
tosta a definirli così) di tutti i megastore.
Se suono il basso voglio distinguere perfettamente il Mi dal Fa sulla
IV corda.
Per le simulazioni continuo ad usare con soddisfazione BASS-PC Ver. 3,
sì, proprio quello progettato da Renato Giussani negli anni
70.
_______________________________________________________________________________________
Digressione
sulle simulazioni.
Il
fatto che BASS-PC giri sotto Dos, che non usi il
“sorcio”, che abbia una grafica povera sono aspetti
assolutamente irrilevanti, il software funziona, nel senso che fa
esattamente quello che deve fare con precisione sufficiente e mostra i
risultati con una risoluzione equivalente alla maggior parte degli
oscilloscopi digitali presenti sul mercato (a prezzi umani,
s’intende). So
che ha dei limiti.
Io
effettuo le simulazioni con una resistenza serie fissa da 1 ohm
perché presumo di collegare le mie casse ad ampli valvolari;
1 ohm è un valore che può essere alto, giusto o
basso a seconda dell’ampli che ci collego, ma una scelta si
deve fare e comunque si fanno tante approssimazioni in questi calcoli
che questa non è di sicuro la più influente.
Però
la resistenza serie è vista da BASS-PC come
se fosse una resistenza fisica collegata in serie
all’altoparlante, per così dire
“dopo” l’amplificatore, quindi la
sensibilità è calcolata per la potenza nominale a
monte della resistenza ed è quindi inferiore alla reale.
Poi
il calcolo delle perdite fisiche non è flessibile: il
fattore di merito del mobile per i reflex è per default a 5 e per
le casse chiuse le situazioni possibili sono senza assorbente e con
assorbente, ma “con assorbente” non significa molto
se non si è in grado di specificare quanto e di che tipo.
BASS-PC intende: "senza assorbente" = cassa vuota, "con
assorbente" = condizione di riempimento critico, cioè oltre il
quale l'effetto si inverte in quanto l'assorbente è talmente
compresso che non è più in grado di vibrare con l'aria
(è la vibrazione dell'assorbente che assorbe energia e quindi
smorza).
D’altra
parte sfido chiunque a esprimere in termini
fisicamente corretti ed attribuendo valori non inventati il fattore di
merito del mobile o il fattore di perdita (se così si
può dire) dell’assorbente usato.
La condizione di smorzamento critico e la sua efficacia dipendono pesantemente dalla qualità dell'assorbente.
Quello
che voglio dire è che quantità fisiche di
quel tipo sono talmente complesse che sono difficilmente (eufemismo)
rappresentabili in modo attendibile, ammesso che si possano misurare, e
comunque il software serve a progettare, quindi si debbono fare delle
assunzioni prima di poter effettuare qualsiasi misura.
Lo
strumento va usato senza dimenticare di accendere prima il cervello,
altrimenti staremo a disquisire se la lunghezza del condotto di accordo
debba essere di 134 mm o 135 mm, senza magari curaci di sapere se il
condotto è un tubo piazzato lontano o vicino dalle pareti o
un condotto realizzato lungo una parete.
Fine della digressione
_______________________________________________________________________________________
La prima serie di simulazioni, fatte come dicevo in modo rapido, senza
varianti e aggiustamento di parametri, cioè il calcolo
automatico di accordi QB3 n.4 mi ha portato a scegliere il Ciare PW328,
che per vari fattori mi è sembrato il più adatto
al mio progetto.
Attenzione, non sto dicendo il migliore in assoluto, che non esiste, ma
il migliore per la cassa che stavo progettando per essere collegata ad
amplificatori di potenza non spropositata e senza dover
accendere un mutuo decennale.
Il PW328 è un eccellente prodotto che si presta a
costruire casse di volume accettabile con buona risposta; la potenza
non elevatissima nel caso di questo progetto non è un
problema.
Perché dico “potenza non elevatissima”?
Il fabbricante dichiara 150W di potenza nominale, che sembrano molti,
ma la potenza nominale è misurata con rumore
rosa filtrato in frequenza a seconda dell'altoparlante sotto test
(esistono protocolli standard riconosciuti per queste misure), quindi
con un segnale in cui la potenza è
“spalmata” su una gamma molto ampia di frequenze.
Un altoparlante per strumenti musicali invece deve sopportare segnali
quasi monofrequenza, quindi segnali in cui tutta la potenza disponibile
è concentrata in una gamma strettissima, e qui entrano in
gioco l’escursione massima del cono e il tipo di cassa.� |
|
|
|
Escursione, tipi di cassa e tipi di
accordo.
|
|
|
|
|
Il vero
limite all’utilizzo di un altoparlante è
l’escursione massima del cono; al di là di tutte
le considerazioni che si possono fare sui criteri per misurarla,
l’escursione ci dice qual è lo
spostamento del cono oltre il quale la non linearità diventa
inaccettabile (in genere la massima escursione meccanica è
maggiore, Eminence dichiara sia la massima escursione utile sia la
massima escursione meccanica, Ciare solo la massima escursione utile).
Ora a parità di livello acustico emesso
l’escursione di qualsiasi altoparlante cresce con il
diminuire della frequenza, in quanto in un mezzo elastico la pressione
acustica emessa da un mezzo oscillante (nel nostro caso il cono
dell’altoparlante) dipende dalla velocità dello
spostamento del mezzo, e non dall’ampiezza.
In un moto oscillante che supponiamo sinusoidale la massima
velocità di spostamento si ha al passaggio per la posizione
di riposo, cioè a spostamento zero; quando la frequenza
è elevata il cono passa per la posizione zero molte volte al
secondo, quindi necessariamente la velocità è
elevata, in quanto la velocità è data da ds / dt
(la distanza percorsa divisa per il tempo impiegato a percorrerla) e a
frequenze elevate dt è per forza di cose piccolo.
A frequenze basse dt è necessariamente grande (il cono passa
per la posizione zero poche volte al secondo) quindi per avere una
velocità elevata anche ds (che alla fine è la
nostra escursione) deve essere grande.
(I matematici mi perdonino per questa spiegazione veramente poco
rigorosa, ma mi importava far capire le ragioni fisiche dei fenomeni
anche a chi ha solo cognizioni elementari di fisica, spero di esserci
riuscito)
Il problema delle casse per basso è che
l’emissione è concentrata in una gamma di
frequenze molto basse in cui pertanto l’escursione
è comunque molto elevata; le frequenze emesse da un basso a
4 corde vanno dai 41 Hz del Mi vuoto ai circa 196 Hz del Sol sul 12
tasto, con un basso a 5 corde si parte dai 30 Hz del Si basso.
Eminence, specializzata nella produzione di altoparlanti per strumenti,
produce due serie diverse di altoparlanti con diametri analoghi, una
per basso ed una per chitarra, ciò che le distingue
è ovviamente l’escursione massima (ed ovviamente
il costo).
Quindi nella progettazione di una cassa per basso bisogna scegliere a
priori un altoparlante che abbia una escursione elevata, ma anche nella
scelta del tipo di accordo bisogna controllare accuratamente
l’escursione del cono.
Da questo punto di vista BASS-PC è un ottimo strumento, iin
quanto fornisce le indispensabili curve dell’escursione in
funzione della frequenza e della potenza e la potenza massima
applicabile in funzione della frequenza.
Io non sono certo che le escursioni calcolate siano esatte entro
l’1%, anzi ne dubito molto viste le semplificazioni fatte nel
modello utilizzato da BASS-PC (qualsiasi modello fa delle
semplificazioni rispetto alla realtà) ma sono convinto che
l’approssimazione ottenuta sia più che sufficiente
per far da guida in un progetto.
Anche se i grafici non sono esatti al 100% sicuramente sono in grado di
dar conto del diverso funzionamento dei diversi tipi di cassa.
|
|
|
A titolo di
curiosità riporto in Fig. 1 il risultato della
simulazione del PW328 in cassa chiusa calcolata per Qtc = 0,8: la cassa
calcolata ha un volume di 25 l (senza assorbente) con frequenza di
risonanza di 103 Hz e frequenza a -3dB di 92 Hz.
Dal grafico si vede quella che è la caratteristica
fondamentale della cassa chiusa: l’escursione aumenta con la
diminuzione della frequenza fino ad un massimo, oltre il quale non
aumenta più; la frequenza corrispondente a questo massimo
è inferiore alla frequenza di risonanza.
In altri termini la cassa chiusa mantiene sempre il controllo
dell’escursione del cono anche sotto la frequenza di
risonanza della cassa.
La simulazione è stata fatta
impostando una potenza massima di 100W, come si vede
la curva MIL è piatta fino a |

Fig. 1:
simulazione in cassa chiusa
|
|
|
frequenze
bassissime, in questo caso la
potenza massima applicabile è veramente la potenza nominale
del cono.
Questa cassa sarebbe eccellente per chitarra, senza limiti pratici di
potenza, il PW328 ha una risposta ben estesa verso l’alto,
credo che un 4x12 sarebbe fenomenale, ma per il basso è
inutilizzabile, con la sua frequenza a –3dB pari alla
frequenza del Sol (che è la corda più alta del
Basso a 4 e 5 corde).
Il bass reflex ci permette di abbassare quasi di una ottava la
frequenza minima riproducibile, ed è quindi la soluzione
direi obbligata per il basso, ma la contropartita si vede in Fig. 2,
che espone il risultato della simulazione per un accordo standard QB3
N4, che risulta accordato a 56 Hz.
Il reflex è un sistema risonante, la cui frequenza di
risonanza è determinata da vari fattori (volume, superficie
dell’apertura, lunghezza del condotto ecc); alla frequenza di
risonanza del sistema “altoparlante + cassa”
l’aria contenuta nella cassa vibra in fase con il cono e
l’apertura (con eventuale condotto) emette un’onda
in fase con l’oscillazione dell’aria nella cassa
che quindi, essendo in fase con il cono, rinforza l’emissione
del cono stesso; è per questo motivo che il reflex estende
verso il basso la frequenza di risposta.
In questo modo l’aria contenuta nella cassa offre un carico
al cono che è massimo proprio alla frequenza di risonanza,
limitandone quindi l’escursione.
E’ ovvio che questo effetto che si verifica alla risonanza si
verifica anche a frequenze vicine alla risonanza, nei fenomeni fisici a
livello macroscopico non si hanno discontinuità brusche
(“Natura non facit saltus” dicevano i nostri
bisnonni), cioè se a 54 Hz si ha il rinforzo
dell’emissione, non è che a 53 o 55 il rinforzo
non c’è più; ci sarà ancora
anche se via via minore mano a mano che la frequenza si allontana dalla
risonanza.
Quindi il carico offerto al cono diminuisce allontanandosi dalla
frequenza di risonanza, e proprio qui sta il problema: se aumentando la
frequenza questa diminuzione di carico, che controlla
l’escursione del cono, è compensata dalla
diminuzione naturale dell’escursione stessa dovuta
all’aumento di frequenza, quando la frequenza diminuisce
(sotto la frequenza di accordo) il carico sul cono diminuisce
permettendo che l’escursione aumenti, e contemporaneamente
l’escursione aumenta ulteriormente per effetto della stessa
diminuzione di frequenza.
In altri termini sotto la frequenza di accordo il reflex non ha
più alcun controllo sul cono, è come avere un
cono in aria libera e l’escursione aumenta in modo
incontrollato.
|
|
|
La curva
viola in Fig. 2 mostra chiaramente cosa succede,
l’effetto risultante è che la potenza massima
applicabile, espressa dalla curva gialla, presenta un massimo proprio
alla frequenza di accordo, sotto questa frequenza scende rapidamente
verso lo zero e sopra ha una flessione notevole da cui si riprende a
frequenza abbastanza elevata (quanto elevata dipende dal fattore di
merito della cassa, cioè dal tipo di accordo),
cioè a quella frequenza alla quale la presenza
dell’apertura di accordo diviene ininfluente rispetto al
movimento del cono.
Nel progetto di un reflex quindi si debbono fare scelte un
po’ più complesse che nel progetto di una cassa
chiusa, e le scelte ovviamente implicano dei compromessi: bisogna
decidere cosa privilegiare ed a che cosa si può/deve
rinunciare; questo è appunto quello che
|
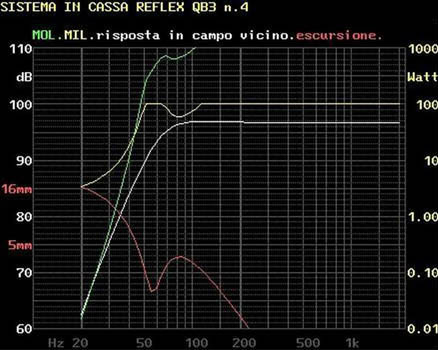
Fig. 2:
simulazione QB3 N4 standard |
|
|
vedremo
nella
progettazione vera della nostra cassa per basso, perché
quello che abbiamo visto finora è solo
l’applicazione brutale dello strumento (BASS-PC) senza fare
alcuna scelta (tranne quella, che definirei scontata, del reflex).�
|
|
|
| Progetto |
|
|
|
Non avendo
problemi di potenza massima applicabile ho deciso di
estendere verso il basso la risposta della cassa e di ottenere nel
contempo un maggiore smorzamento: il ginocchio della curva di risposta
è piuttosto brusco e la pendenza della risposta
sotto l’accordo elevata, fatti che indicano un comportamento
non molto smorzato (avrete sicuramente oramai intuito quale
è il tipo di suono che mi piace).
Per fare ciò ho aumentato il volume e abbassato la frequenza
di accordo, provando vari valori fino ad ottenere quello che mi
è sembrato un buon compromesso con le mie esigenze,
cioè la massima estensione con potenza applicabile non
elevata.
Ne è risultata una cassa di 65 l accordata a 45 Hz, dotata
quindi di un tubo di accordo di 120 mm di diametro lungo 156 mm.�
Le curve caratteristiche sono in Fig. 3: Risposta, escursione e MIL e
in Fig. 4 Impedenza e fase.� |
|
|
|
La Fig. 4 è particolarmente importante
in quanto
sarà confrontata con l’impedenza e fase misurate
alla fine
della realizzazione: l’accordo fra le curve di progetto e le
curve misurate sarà indicativo della correttezza delle
assunzioni fatte, delle approssimazioni e anche della bontà
dello strumento di simulazione.�
Ai 65 l richiesti da BASS-PC ho aggiunto 2 l per
il
volume occupato dall’altoparlante (stimati molto
spannometricamente, è chiaro) e altri 2 l per il volume
occupato
dal condotto (c’è chi dice che questo non deve
essere
aggiunto, ma non ho mai trovato una spiegazione chiara né in
favore del sì né in favore del no) quindi ho
calcolato le
dimensioni del box con il criterio della sezione aurea.
|
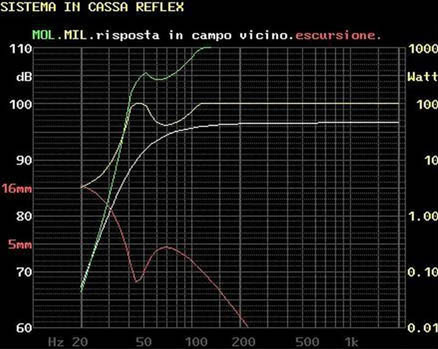
Fig. 3: curva di risposta, MIL ed
escursione simulate
|
|
|
|
|
Avete
notato che la maggior parte delle casse per strumenti hanno
almeno una faccia perfettamente quadrata, ed in qualche caso la loro
forma si avvicina moltissimo ad un cubo (succede nella maggior
parte degli 1x15”)?
È noto a tutti gli appassionati di HiFi che avere due o
più dimensioni del box uguali o quasi è il
miglior modo
per concentrare in una gamma strettissima tutte le risonanze interne e
quindi ottenere un box rimbombante, mentre in un reflex non si
può usare l’assorbente per smorzare le onde
stazionarie,
se non in quantità minima, pena la modifica sostanziosa
dell’accordo e del fattore di merito della cassa.�
Quando le dimensioni stanno fra loro in un rapporto pari a 1,6 (circa,
il famoso numero aureo, senza essere troppo pignoli sui decimali) le
frequenze delle onde stazionarie generate dalle |

Fig. 4: impedenza e fase
simulate |
|
|
|
|
risonanze
interne sono spaziate nel modo più
regolare,�assicurando che non vi saranno rimbombi concentrati in gamme
ristrette
e che pertanto il livello delle onde stazionarie sarà il
più basso
possibile.
Quindi un box dalle dimensioni interne pari a cm 60 x 41 x 29, dopo gli
opportuni arrotondamenti ai cm interi, come rappresentato in Fig. 5.�
|
|
|
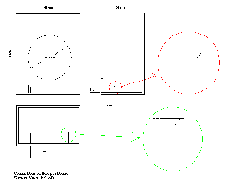
Fig. 5 - piano di costruzione
( cliccare per ingrandire ) |
Per
l'accordo
ho adottato la soluzione del condotto rettangolare addossato ad una
parete, di sezione 6 x 20 cm, circa equivalente ad uno circolare di
diametro 12 cm, in quanto più facile da realizzare (a mio
parere, s’intende).
Dato che addossare il condotto ad una parete causa un allungamento
virtuale del condotto stesso, ma l’entità di
questo
allungamento è difficilmente calcolabile, ho deciso in prima
battuta per 130 mm invece di 156, riservandomi di modificare la
lunghezza dopo il test.
|
|
|
|
|
|
Costruzione
Il materiale è truciolare da 22 mm per il mobile, da 12 mm
per
il condotto (avevo giusto alcuni spezzoni che si adattavano
perfettamente).�
Truciolare
e non MDF perché pesa un po’ meno, costa molto
meno e
anche perché pare (non ne sono sicuro ma è una
ragione in
più) che il truciolare essendo composto di frammenti di
legno di
misura varia e non da segatura sottile ed uniforme abbia una
caratteristica di assorbimento delle onde acustiche molto
più
regolare al variare della frequenza rispetto alla MDF; se non
è
vera è ben trovata, comunque peso e costo sono ragioni
più che sufficienti per un progettino con limiti di budget.
 
Figg. 6 e 7: la costruzione della
cassa
Colla vinilica abbondante,
“sergenti” di dimensioni
adeguate e viti, da 4 a 6 per ogni lato a seconda della lunghezza,
assicurano un mobile molto solido anche con pochi rinforzi interni.
La colla in eccesso si spalma lungo la giunzione con un dito,
dopodiché non servono altri sigillanti.
 
Figg. 8 e 9: La cassa aperta ed il
condotto
 Per
agevolare il montaggio del condotto ho fissato per ultima una
parete laterale; non è possibile montare tutto in un colpo
solo,
quindi il montaggio completo richiede parecchio tempo, per lasciare
alla colla il tempo necessario ad asciugare bene prima del montaggio
dei pezzi successivi (almeno 12 ore fra due montaggi successivi). Per
agevolare il montaggio del condotto ho fissato per ultima una
parete laterale; non è possibile montare tutto in un colpo
solo,
quindi il montaggio completo richiede parecchio tempo, per lasciare
alla colla il tempo necessario ad asciugare bene prima del montaggio
dei pezzi successivi (almeno 12 ore fra due montaggi successivi).
Alla fine del montaggio una mano di turapori sia all’interno
che
all’esterno, quindi si è pronti per predisporre il
fissaggio dell’altoparlante.
Prima però è opportuno pensare alle maniglie:
alla fine
il mobile sarà né piccolo né leggero e
per
spostarlo, cosa che mi sembra altamente probabile non trattandosi
dell’HiFi di casa, esse sono indispensabili.
Praticamente qualsiasi tipo di maniglie per strumenti con
caratteristiche adeguate al peso richiedono o di forare il mobile o di
fresarlo, ed è opportuno fare tutte le operazioni di
falegnameria prima di pensare all’altoparlante.
Quindi anche il foro nel pannello posteriore per il fissaggio dei
connettori va fatto prima; ho usato un normale jack che è
più che adeguato a bassa potenza (a partire da 100 W userei
invece gli Speakon) fissato ad un pannellino di MDF da 6 mm a sua volta
fissato con colla e 4 viti al fondo, dall’interno, come si
vede
in Fig. 10.
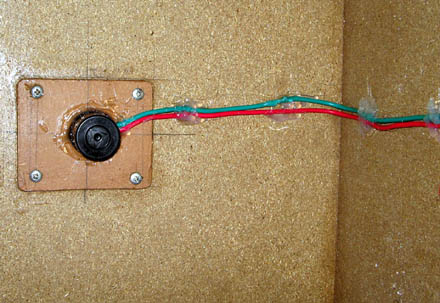 Finalmente si
arriva al fissaggio dell’altoparlante: il cono non
dovrebbe essere montato e smontato più di un paio di volte,
però nel nostro caso dato che il diametro del foro
è 282
mm e il diametro su cui stanno i fori di fissaggio è 295 mm
(questi sì devono essere esatti!) ed il materiale
è
truciolare, che non assicurerebbe una buona tenuta nemmeno al secondo
riavvitamento, ho usato inserti filettati in ottone annegati nel legno
per effettuare il fissaggio con viti in acciaio con testa a brugola. � Finalmente si
arriva al fissaggio dell’altoparlante: il cono non
dovrebbe essere montato e smontato più di un paio di volte,
però nel nostro caso dato che il diametro del foro
è 282
mm e il diametro su cui stanno i fori di fissaggio è 295 mm
(questi sì devono essere esatti!) ed il materiale
è
truciolare, che non assicurerebbe una buona tenuta nemmeno al secondo
riavvitamento, ho usato inserti filettati in ottone annegati nel legno
per effettuare il fissaggio con viti in acciaio con testa a brugola. �
Gli inserti con filettatura per legno, visibili in Fig. 11 e 12, sono
reperibili presso qualsiasi ferramenta; per essere pignolo, io uso gli
inserti su qualsiasi tipo di legno, se solo penso che dovrò
smontare la parte una volta.�
Fig. 10: il Jack
 
Fig. 11: inserto e vite
Fig.12:
inserto inserito nel legno
Come avete visto dalla sequenza di montaggio, le
aperture per l’altoparlante e per il condotto sono state
fatte
prima di montare il pannello anteriore.
La precisione del posizionamento dei fori per il fissaggio
dell’altoparlante è ovviamente essenziale,
soprattutto nel
caso dell’uso di inserti filettati.
Io ho proceduto in questo modo: dopo aver rettificato il foro da 282 mm
per assicurare che l’altoparlante ci entri perfettamente ma
senza
gioco ho posizionato l’altoparlante ed ho praticato un
contrassegno sul legno in corrispondenza del centro di ogni foro,
quindi tolto l’altoparlante ho praticato fori guida con una
punta
da 2 mm.
Dopo avere verificato il posizionamento dei fori guida ho quindi
effettuato i fori veri e propri con una punta da 7 mm, il diametro
richiesto dai miei inserti; è ovvio che il diametro del foro
finale dipende dal tipo di inserti usati, generalmente gli inserti per
viti da 5mm richiedono fori da 7 o 7,5mm.
Dopo aver verificato che l’altoparlante si monti
perfettamente, si rimuove e si passa al completamento della cassa.�
Si predispone il collegamento del cavo, saldato al
connettore e predisposto con due Fast-on adeguati dal lato
altoparlante: ho fissato il cavo (2,5 mm) alle pareti con abbondante
colla a caldo, sempre con la colla a caldo ho fissato il cappuccio al
connettore, ricavato dal contenitore di un rullino di pellicola: serve
a sigillare il mobile, che essendo un reflex deve
“respirare” solo attraverso il condotto.
Ho quindi applicato l’assorbente, il classico bugnato da 2
cm,
solo sulla sommità del mobile, su parte del fondo non in
corrispondenza del condotto di accordo e su parte di una parete
laterale, fissandolo accuratamente con adesivo forte (quello giallo che
si spalma sulle due superfici da incollare e si lascia asciugare,
qualsiasi marca va bene, basta che sia applicato su tutta la superficie
da incollare).
Finitura con vernice nera opaca, due mani di vernice previa stesura di
due mani di fondo opaco e carteggiatura, quindi applicazione delle
maniglie: ho interposto una guarnizione di gommapiuma fra la maniglia
ed il legno per evitare sfiati.�
La griglia è in acciaio forato con i bordi ripiegati,
costruita
da un artigiano, fissata ai quattro angoli e circa al centro in
prossimità del bordo del cono (serve ad evitare vibrazioni),
mediante distanziatori e viti con inserti filettati (da predisporre
prima del fissaggio finale dell’altoparlante).
Le normali griglie rotonde del diametro adatto costano molto meno,
vedete voi.
Anche l’altoparlante deve essere sigillato con una
guarnizione di gommapiuma.
Test
finale
Dopo
una prima
prova acustica, cioè collegato all’ampli, che mi
è
sembrata soddisfacente, ho provveduto ad una verifica
dell’impedenza con SpeakerWorkshop: questa misura ci dice
quanto
abbiamo rispettato le specifiche di progetto.
Ovviamente questa misura ha senso se prima l’altoparlante
è stato rodato a sufficienza: io l’ho collegato
per circa
6 ore ad una sorgente a 50 Hz, cioè i secondari filamenti di
un
trasformatore di alimentazione, prima con 6,3 V poi con 9,45 V (un
secondario e mezzo in serie); dato che la frequenza di risonanza del
cono è 48 Hz (nominale) non ho applicato tensioni
più
elevate in quanto l’escursione, controllata a vista, era
già sufficiente.
La misura è a lato: 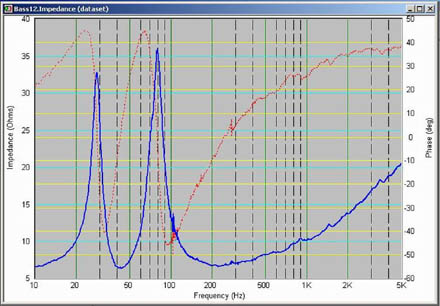 non
troppo lontana dalla curva di progetto, accordo a 42 Hz e picchi
distanziati correttamente (l’accordo è individuato
dal
passaggio della fase per lo zero). non
troppo lontana dalla curva di progetto, accordo a 42 Hz e picchi
distanziati correttamente (l’accordo è individuato
dal
passaggio della fase per lo zero).
La differenza rispetto al progetto è significativa o no? Tre
Hz
di differenza potrebbero non essere irrilevanti a queste frequenze.
Per capirlo ho quindi impiegato BASS-PC
“a rovescio”,
cioè non per progettare ma per verificare; ho quindi, a
parità delle altre condizioni, effettuato un ricalcolo
imponendo
la frequenza di accordo a 42 Hz: il risultato è stato un
condotto di accordo lungo 180 mm, evidentemente
l’allungamento
virtuale è maggiore di quanto avessi stimato, circa il 45%
contro il 30%; sicuramente ha influito il bordo anteriore del box,
profondo 2 cm.�
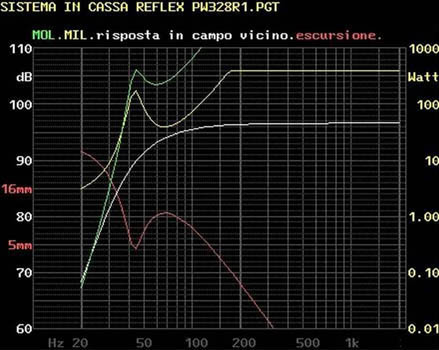
A questo punto due opzioni possibili:
accorciare il condotto,
portandolo a 100 o 110 mm, oppure verificare le curve per vedere se il
comportamento sia comunque accettabile.
Le curve a lato, risultato del ricalcolo, mi dicono che la massima
potenza applicabile non è scesa in misura significativa
(l’ultima curva “sembra” diversa solo
perché
è calcolata con una potenza limite pari a 400W
anziché i
100 della precedente) ed è comunque pari a circa 50W fra 60
Hz
ed 70 Hz, quindi comunque in linea con gli obiettivi di progetto.
L’unico modo per alzare la potenza
massima applicabile è
alzare la frequenza di accordo quindi ridurre l’estensione
verso
il basso, ma senza risultati eclatanti, questo è
evidentemente
il limite dell’altoparlante impiegato; credo che il risultato
migliore, in termini di potenza, si abbia con
l’allineamento QB3 N4 standard, ma al costo però
di una
minor estensione verso il basso unita ad un ginocchio più
pronunciato, indice di un suono meno smorzato.
Ho quindi deciso di tenerla come è; se mai costruissi un
100W
– cosa non improbabile – vedrò come si
comporta.
|
|
|
|